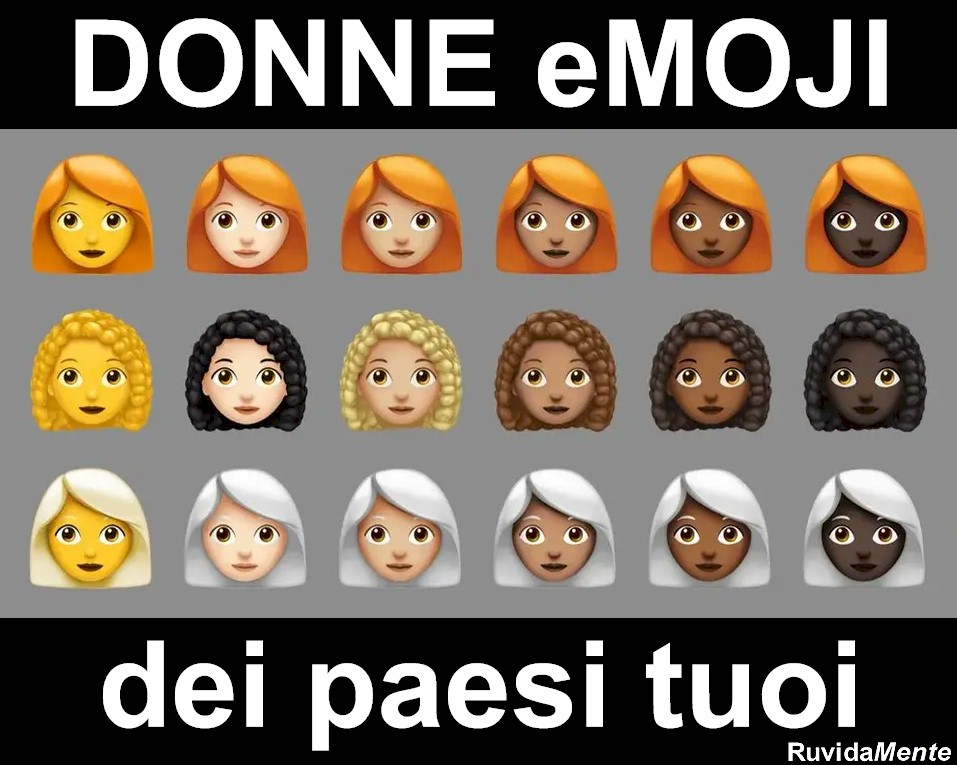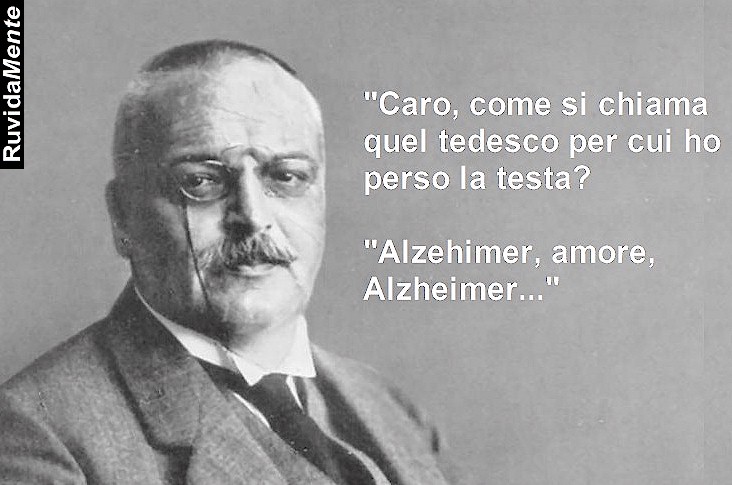Il culmine della carriera. Il sogno della sua vita. Il gradino più alto dell'azienda. La giusta mercede.
Alla capacità. All'astuzia. Agli intrallazzi. Ai favori. Alle amicizie coltivate sapientemente. Ai rospi verdi e grossi ingoiati con apparente disinvoltura. Alla barba rasata con cura ogni giorno. Alla Messa di mezzogiorno della domenica. Alla puntualità dei regali e degli auguri. Alla camicia bianca. Alle cravatte. Alle malvagità. Alle vigliaccherie. Agli atti di bontà interessata. A sua moglie. A quella cretina di sua moglie. A sua madre. A tutto pensava quella mattina. Udì quasi telepaticamente il verso garrulo della berlina blu ministeriale che si fermava sotto casa. Strinse la valigetta in pelle e si avviò.
Scese lentamente tutti i gradini, ripudiando per la prima volta l'ascensore. L'autista in divisa gli si fece incontro, lo salutò con un sorriso da hostess, gli aprì la porta, la richiuse dietro di lui.

La città gli scorreva nuova sotto gli occhi. Il fiume, le piazze, le chiese. Fuggivano veloci ai lati di questa macchina, che scivolava leggera sulla corrente amica delle corsie preferenziali.
Il palazzo, austero, comparve quasi all'improvviso. Lesto un usciere corse ad aprire inchinandosi. Il potere grigio di sempre, riveriva il poter bianco di ora.
Entrava per la prima volta nel portone che aveva varcato mille volte. Saliva per la prima volta le scale che tante volte avevano umiliato le sue gambe e frustrato il suo animo. Guardava per la prima volta i muri che ogni giorno gli erano crollati addosso. Tutto nuovo. Tutto finalmente vero. E vivo.
Le riverenze di chiunque incontrava apparivano sfuocate. Il suo sguardo era fisso sui segni della sua scalata. L'ufficio dove dimorò i primi anni, gomito a gomito con altri tre impiegati. Il secondo ufficio. Il terzo. Il passaggio al piano superiore. E poi sempre più su fino al penultimo piano. Trent'anni di carriera. Trent'anni di gradini. Fino all'ultimo.
Una targa in ottone brillava sulla porta d'ingresso dell'ultimo piano. La superò e calcò con fermezza la passatoia blu stesa sulla moquette rossa. Con gli occhi fissi al fondo del corridoio. Aprì la porta richiudendola immediatamente dietro di sé.

Si lasciò cadere sulla poltrona in pelle. Ne strinse con bramosia i braccioli. E si guardò intorno. Alcuni timbri erano allineati con cura in un contenitore. Prese un foglio bianco e vi impresse il primo:"Direzione Generale degli Affari Generali". Il suo regno. Subito dopo il secondo:"Il Direttore Generale". Il suo titolo.
Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali. Una formula che definiva una vita. Ci pensò e la sua schiena fu percorsa da un fremito di attivismo. Lavorare. Decidere. Imporre. Ordinare. Pretendere. Disporre. Richiedere. Costruire. Distruggere. Creare. Annientare. Vivere finalmente.
Prese in mano una delle cartelline in pelle disposte in bell'ordine in un lato del tavolo. Se la posò davanti. La scritta "Evidenza" le attribuiva, in quel momento, un certo fascino. Da quel giorno tutto ciò che sarebbe uscito da quella cartella avrebbe portato la sua impronta, il suo marchio.
La aprì con l'irruenza di chi finalmente può agire, senza limiti o legami, mentre nel cervello gli martellava "Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali, Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali, Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali".
La aprì. E fu avvolto in una nuvola di fredda, antica, sottilissima polvere grigia.

 RuvidaMente
RuvidaMente