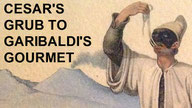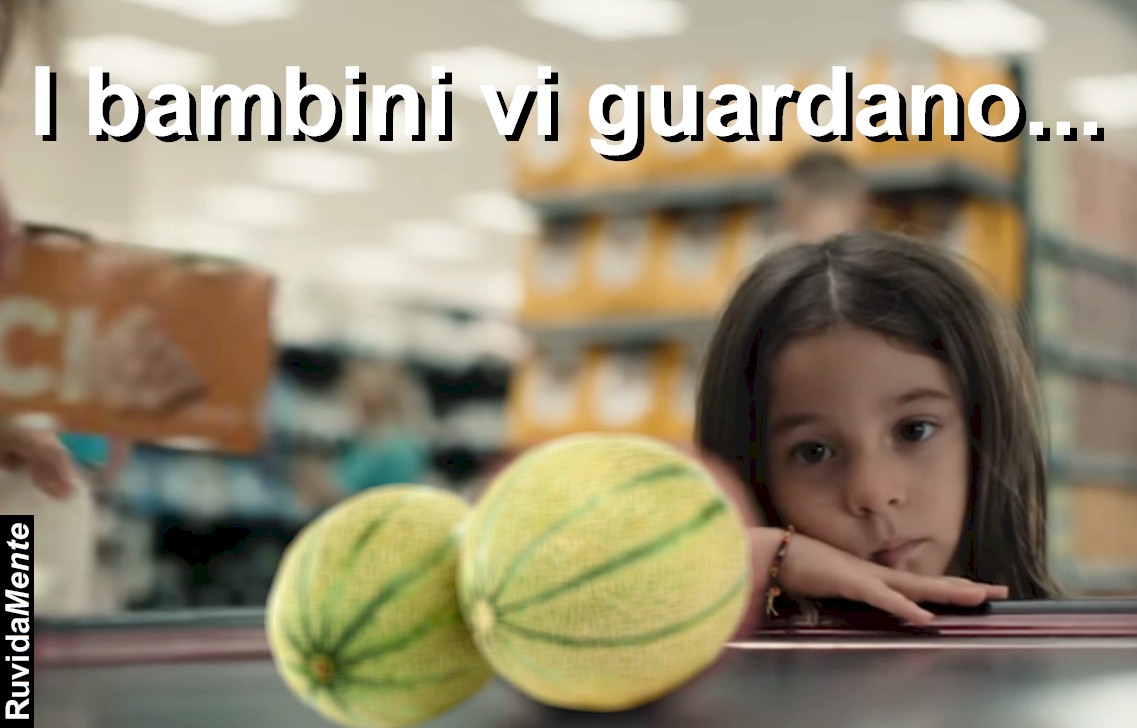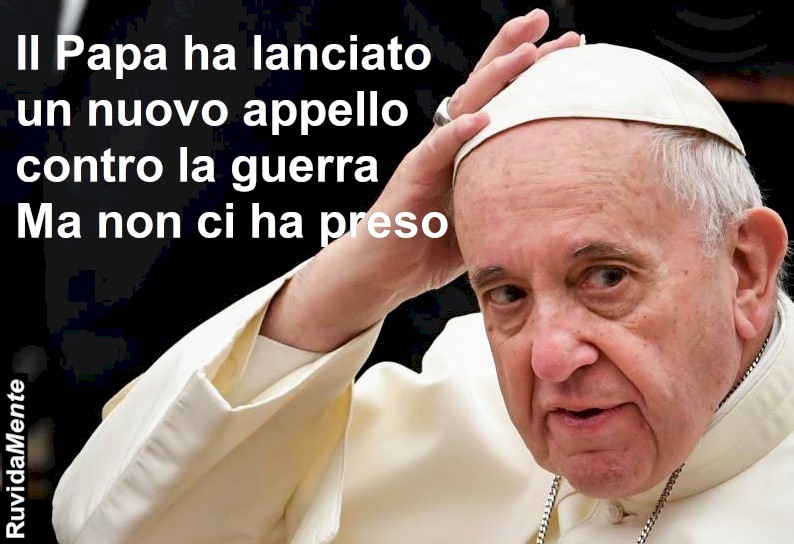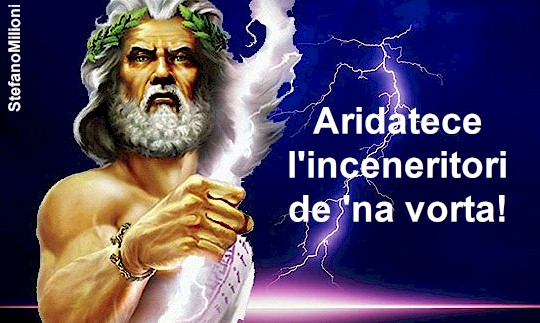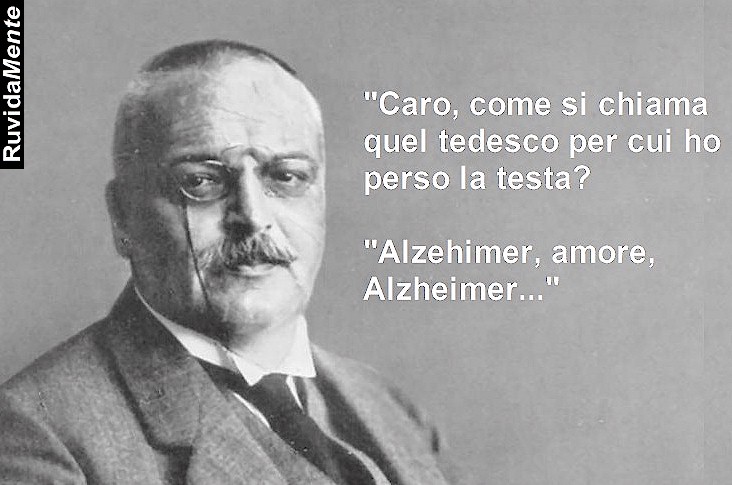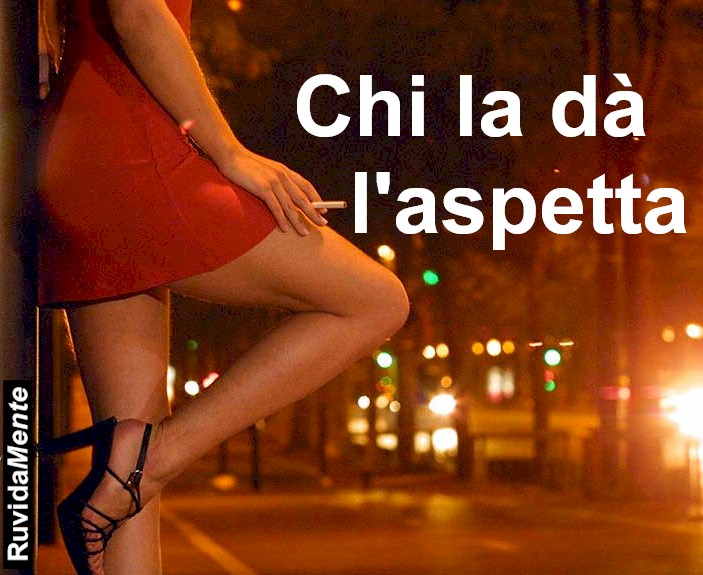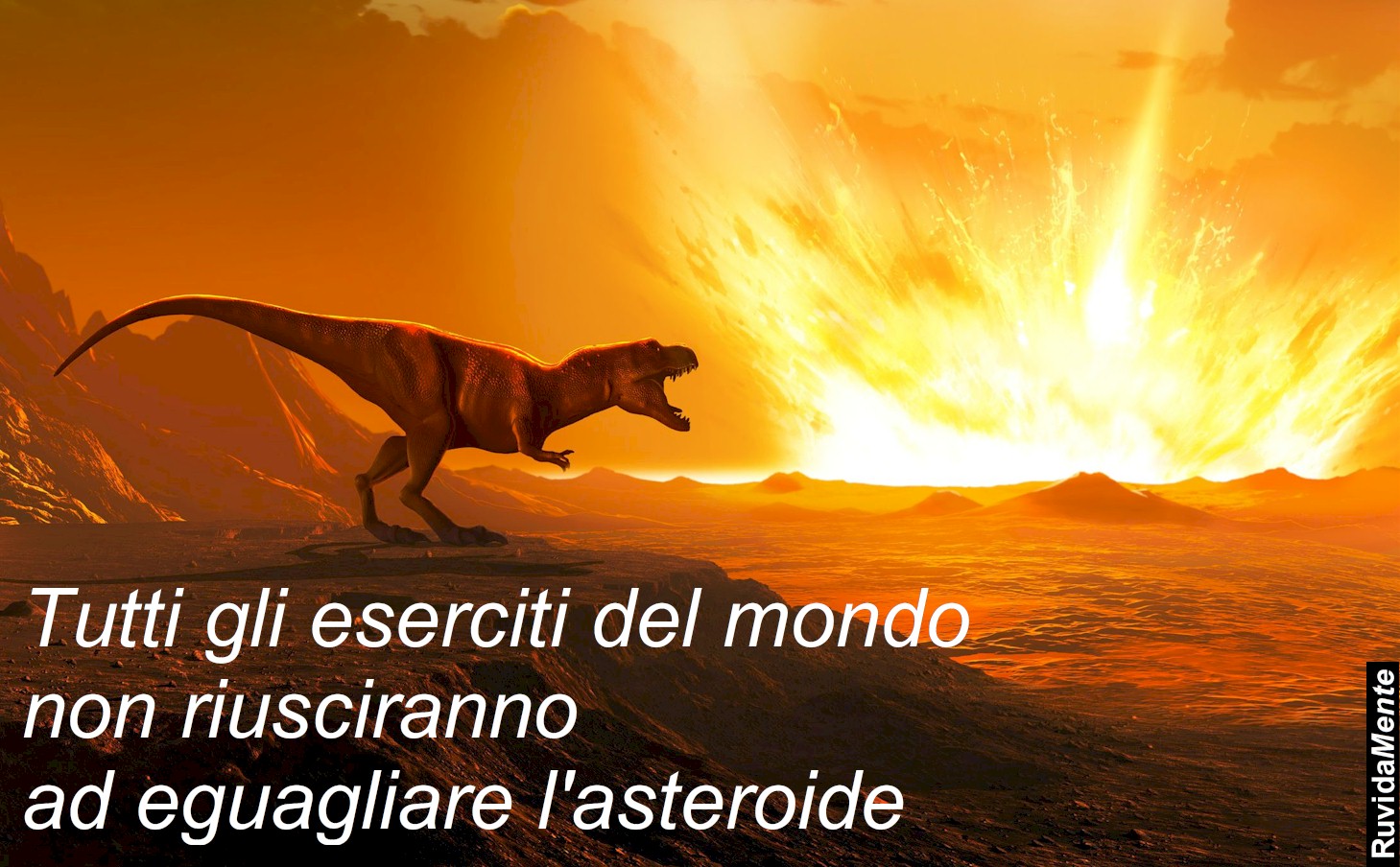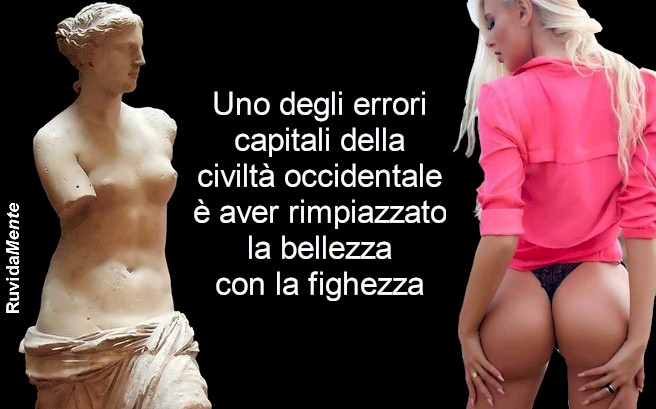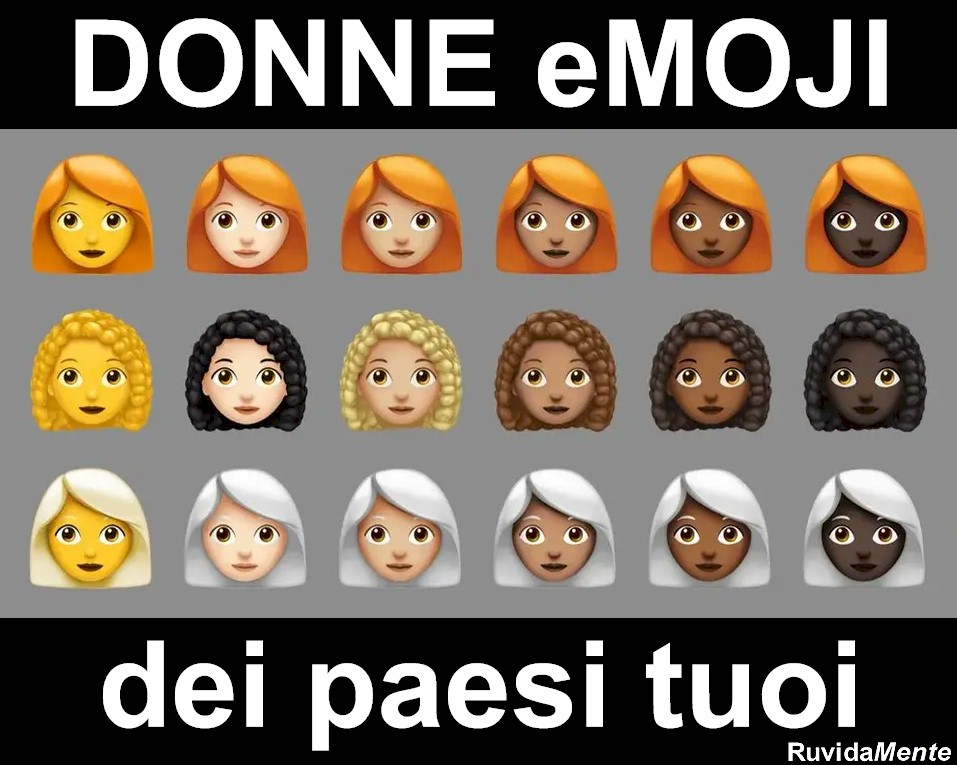Chi "ne sa" di ceramica, associa immediatamente le parole "Vecchia Lodi" con lo stile
caratterizzato da vivaci decorazioni a fiori policromi, creato nel corso del Settecento dai ceramisti lodigiani, già apprezzati e contesi in tutta la Lombardia fin da quando, nel XV secolo si
dedicavano prevalentemente alla produzione di oggetti d'uso quotidiano, decorati con la semplice gamma dei colori metallici in verde, bruno, blu e giallo antimonio.
Gli storici, però, collocano i primordi della ceramica lodigiana ben più indietro nel tempo: dagli scavi archeologici di Laus Pompeia (l'attuale Lodi vecchia) accanto
all'artigianato fittile, proveniente dall'Etruria e dalla Magna Grecia, è emersa una produzione locale soprattutto di statuette votive e lucerne.

Curiosamente negli archivi si scopre che per tutto il ‘500 e il ‘600 la miglior produzione era destinata prevalentemente all'esportazione, quasi a preparare il terreno per il forte sviluppo, sia qualitativo sia commerciale, verificatosi nel ‘700, quando le fornaci lodigiane dedite alla creazione di maioliche passarono da 4 a 5 e vennero introdotte nuove tecniche di decoro (fra le altre il cosiddetto “piccolo fuoco”) con le quali esprimere al meglio gli imperanti canoni estetici di ispirazione barocca.

L'artigianato lombardo della ceramica, quindi, vanta antiche e gloriose tradizioni ed è tuttora vitale anche se,
contrariamente a quanto accade di solito per questo settore, non si è sviluppato un polo di aggregazione geografica, fatta eccezione per la città di Laveno, in provincia di Vares,e diventata
ormai un'importante centro di produzione delle ceramiche da tavola, molte delle quali conservano ancora forme particolari di carattere tradizionale.
Ci sono, poi, laboratori sparsi un po’ in tutta la regione anche se si ha la più alta concentrazione a Milano, dove l'estero dei singoli operatori ha preso il
sopravvento sui filoni estetici tradizionali, fatta eccezione per i grandi vasi smaltati di colore verde scuro, un tempo utilizzati soprattutto per la conservazione dei cibi, i quali continuano a
trovare fedeli compratori.Chi "ne sa" di ceramica, associa immediatamente le parole "Vecchia Lodi" con lo stile caratterizzato da vivaci decorazioni a fiori policromi, creato nel corso del
Settecento dai ceramisti lodigiani, già apprezzati e contesi in tutta la Lombardia fin dal XV secolo.

Il territorio compreso tra Pesaro e Urbino cominciò a configurarsi come polo di produzione ceramica di qualità già dal Trecento per diventare poi, nella seconda metà del Quattrocento, uno dei centri ceramici artisticamente importanti e influenti, animato da una gran quantità di botteghe, intensi traffici commerciali, una consistente produzione, riconoscimenti di prestigio e apprezzamenti.
Verso la metà del Cinquecento iniziò la produzione di istoriati che contribuirono a rendere celebre il Ducato di Urbino e in particolare il centro di Casteldurante, divenuto in seguito
Urbania, dove furono prodotte alcune fra le più belle maioliche del Rinascimento.
Nel ‘700, due decori tipicamente pesaresi divennero dominanti: il motivo “al ticchio” e quello “alla rosa”, quest'ultima dipinta con colori a smalto, fantasiosa e creativa, che riscosso un
tale successo da essere ancora oggi considerata il simbolo delle maioliche pesaresi.
L’Ottocento, invece, segnò un momento di involuzione creativa e la produzione si orientò a beni di consumo popolare come le terraglie bianche o marmorizzate decorate a
mano o a riporto, e gli scaldini, realizzati in una sorprendente varietà di forme e con le più diverse tecniche decorative.
Per registrare una sorta di risveglio creativo si deve attendere la metà del ‘900 quando, sotto la spinta di importanti artisti contemporanei, quali Baratti, Valentini, Sora, Polidori, Wildy e
Bucci, l'antica tradizione venne rivitalizzata con originalità e fantasia dando forma a una nuova stagione della ceramica urbinate e pesarese.
Ascoli Piceno è il secondo polo marchigiano della ceramica. Le botteghe artigiane, quasi tutte concentrate nel centro storico, nella zona di via Pretoriana,
rappresentano per il visitatore del capoluogo ascolano una piacevole sorpresa. L'artigianato più diffuso è quello della maiolica che qui ha origine antichissime come attestano i frammenti di
anfore e crateri, piatti, boccali di epoca italica romana e alto medioevale, rinvenuti in diverse zone della città e del suo circondario.
Nel periodo che va dal Trecento al Cinquecento nella città erano attivi numerosi laboratori in cui si producevano in prevalenza stoviglie di uso comune, (piatti,
boccali, bottiglie, bacili, “cortisciane”, “pignatte”, “et vasa et coccie che si operano in cucina”) quasi sempre a tinta unita: bianco, turchino nero e rosso.
In un'alternanza di alti e bassi in cui le stagioni floride, quali il Settecento e i decenni centrali dell'Ottocento, erano sempre ascrivibili alla creatività e
all'abilità dei singoli artigiani che riuscivano a dare impulso a tutto il comparto, si giunse alla stagione d'oro del primo Novecento, grazie anche alla intraprendenza della fabbrica Matricardi
che ha fatto conoscere le ceramiche di Ascoli in tutto il mondo.
Attualmente la tradizione ascolana della maiolica è tenuta viva dalle numerose fabbriche artigianali che si dedicano prevalentemente alla produzione di zuppiere,
orcioli e piccole brocche con decori incentrati sul motivo floreale della “rosa picena”, grandi anfore e caffettiere orientaleggianti e piatti e vasi ornati con stilizzazioni e figure
geometriche.

CERAMICA E TERRACOTTA IN
[Abruzzo▪Basilicata] [Calabria
▪Campania] [Emilia▪Lazio▪Liguria]
[Lombardia▪Marche] [Piemonte▪Puglia] [Sardegna]
[Sicilia
▪Toscana] [Trentino▪Umbria▪Veneto]
TORNA A
 RuvidaMente
RuvidaMente