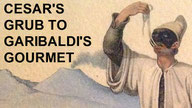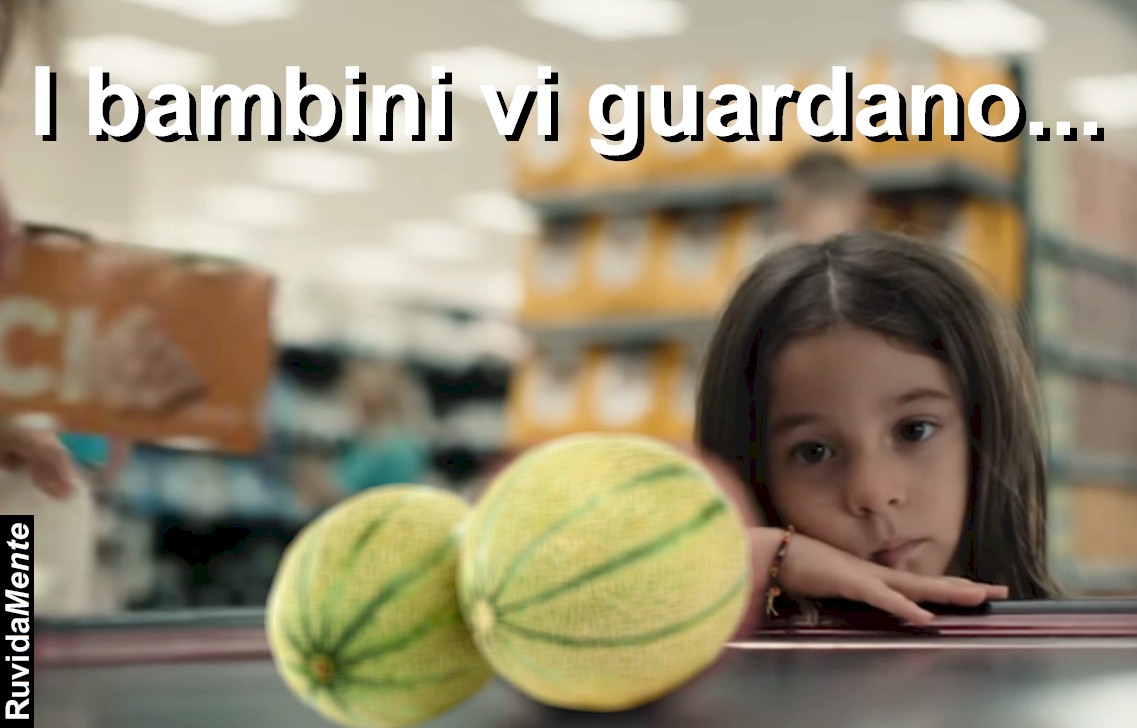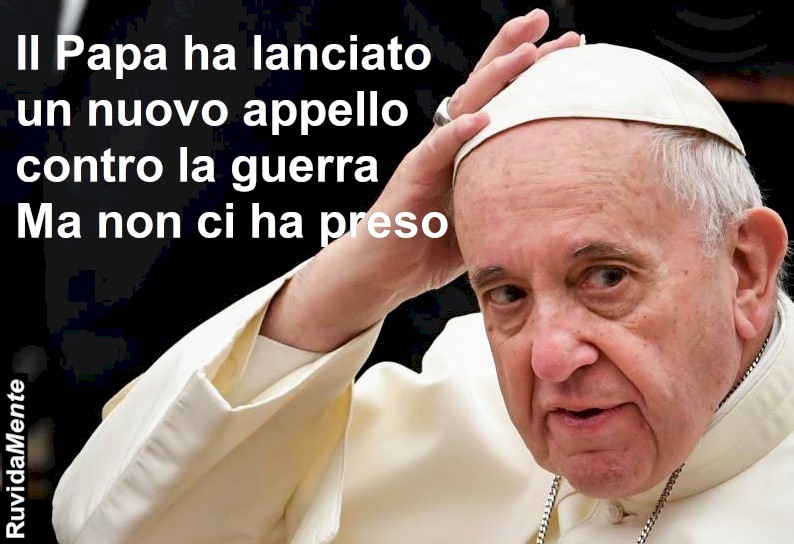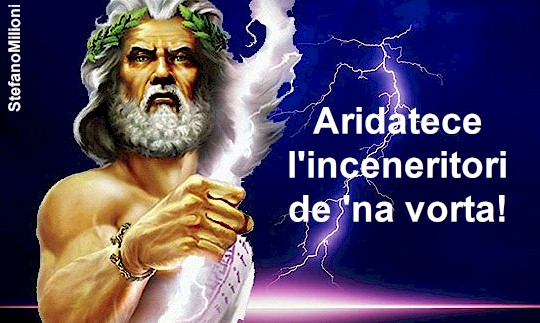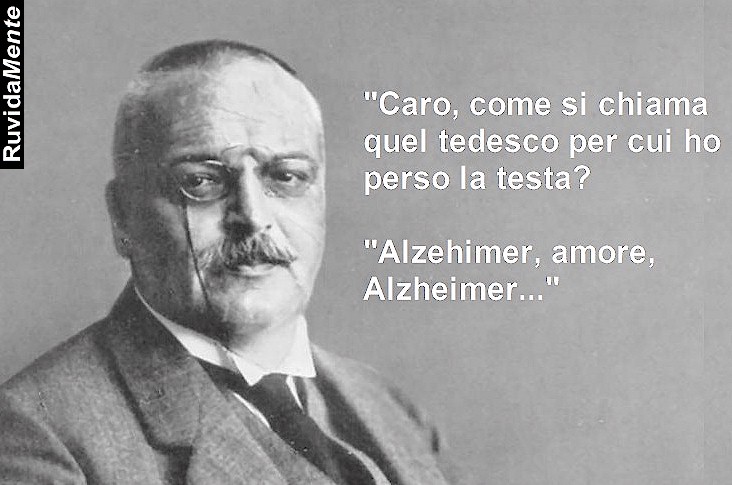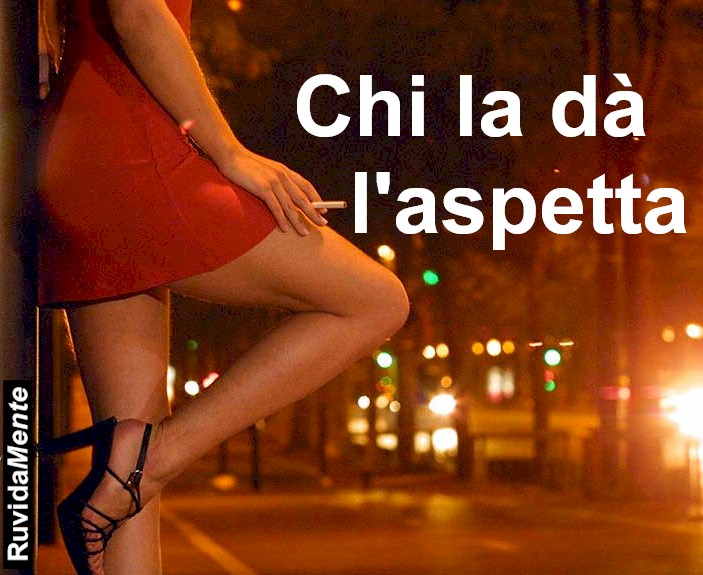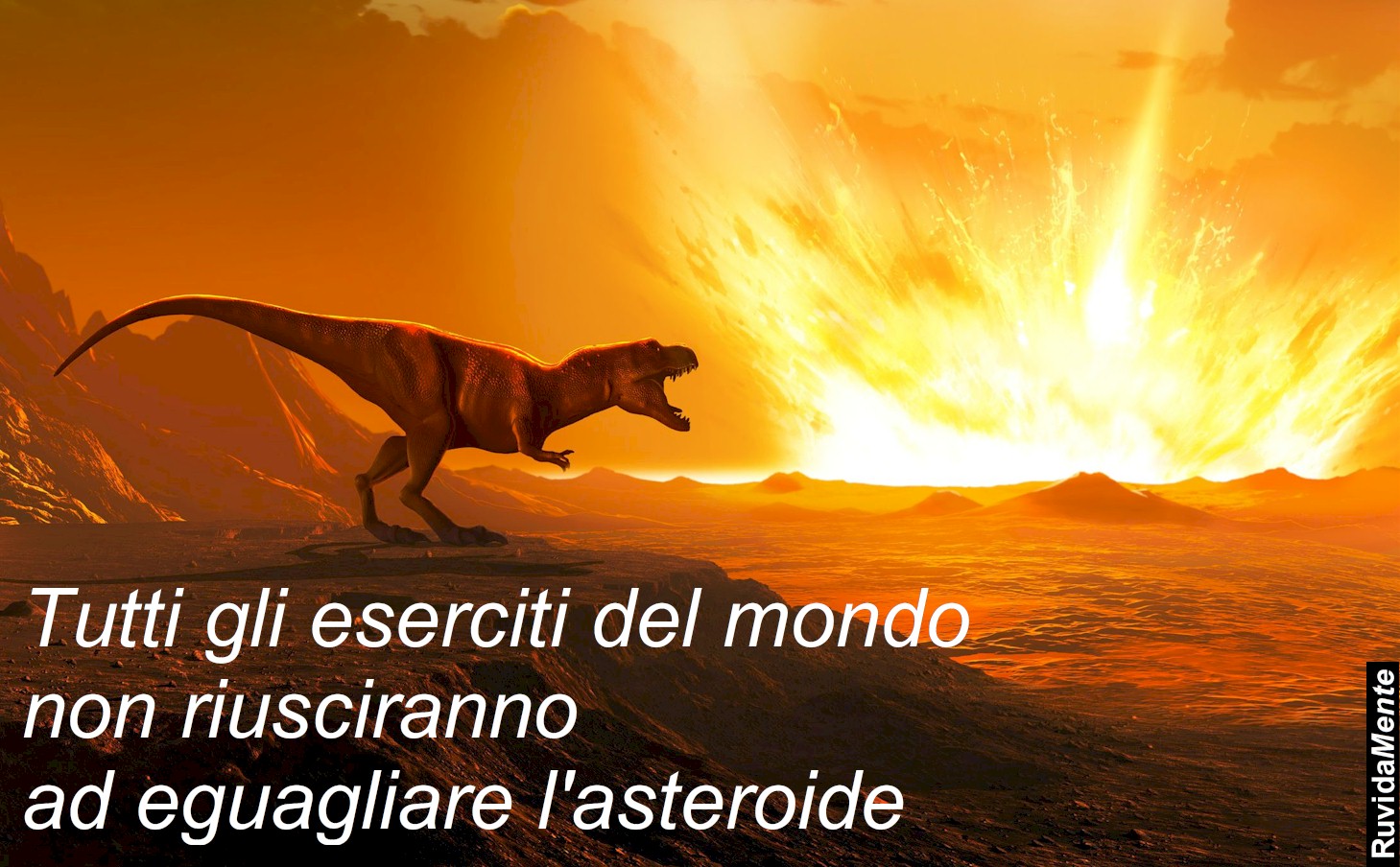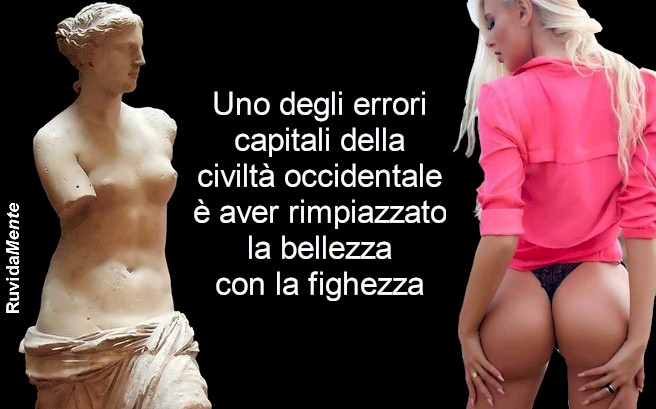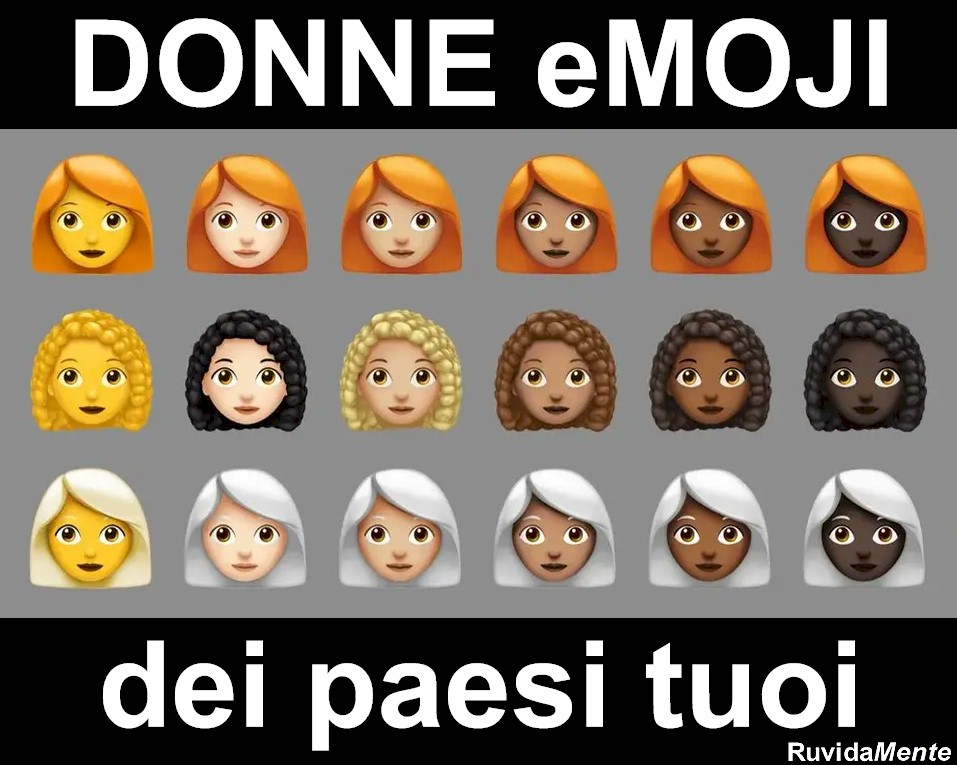In assoluto è pressoché impossibile definire con certezza origine e paternità dell'arte ceramica.In questo contesto di incertezze, però, la Sicilia, dove la ceramica comparve per la prima volta nel VI millennio a.C., costituisce un'importante testimonianza delle più antiche produzioni artigianali dell'umanità. Nell'VIII secolo a.C., sullo zoccolo duro di questo consolidato sviluppo, si inserirono i Greci che, insieme ai loro insediamenti, portarono una ventata di novità e contribuirono a raffinare le tecniche fino ad allora utilizzate in Sicilia.
Fu il successo politico di Atene nel V secolo a.C. a segnare l'arte della ceramica come espressione di un periodo storico-politico ben preciso e della civiltà greca. Ed è proprio in questo periodo che nacquero le scuole di ceramica in Sicilia, le migliori del Mediterraneo fino a tutto il IV secolo a.C.
Gli eventi storici seguenti hanno determinato, però, una cesura tra lo splendore dell'arte ceramica della Magna Grecia e i suoi esiti successivi. Dopo oltre un millennio di buio quasi totale, la produzione di rustiche terrecotte (prevalentemente contenitori per acqua) fu reintrodotta in alcuni piccoli centri arabi dislocati lungo le coste. ma si dovette arrivare al XVII secolo per vedere una comunità locale, peraltro costretta dagli eventi naturali, rimettere in funzione le primordiali fornaci.
Questo accadde a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, allora agglomerato di pastori insediatisi in riva al mare a seguito di movimenti franosi che avevano reso inabitabile il loro villaggio sulle alture. Più per necessità che per vocazione, cominciarono a realizzare mattoni evolvendo via via la produzione verso gli oggetti d'uso e alla fine del ‘700 arrivarono a realizzare piastrelle maiolicate e ceramiche artistiche.
La ceramica di Santo Stefano di Camastra assunse così il profilo per cui tutti oggi la apprezzano, basato su un repertorio ricchissimo di forme, figure e colori che
si concretizzano nella produzione di fioriere, piatti, brocche, vasi e mattonelle, con le tradizionali decorazioni policrome, caratteristica costante di questa ceramica, e una certa saporosa
origine rustica che si accompagna alla brillantezza degli smalti e al gusto pittorico delle decorazioni.
Anche la ceramica di Caltagirone in provincia di Catania ha una storia simile, avviata dagli arabi che sfruttavano le cave di argilla della zona. Questa produzione
fu interrotta nel ‘300 a causa di un'enorme frana e ripresa nel ‘500 nel nuovo rione di Cannataro rione dei “cannatari” (da cannate, recipienti per l'acqua) riscuotendo successi commerciali
in tutta l'isola.
La produzione spaziava dai vasi agli orci, ai lampadari, alle caratteristiche lampade antropomorfe, con decorazioni a fogliame e vivacizzate da tocchi di giallo e di verde oppure realizzate in monocromia turchina su fondo bianco.
Dopo le distruzioni del territorio di Catania del 1693, la produzione riprese faticosamente tra alti e bassi finché nel 1918 l'apertura di una scuola d'arte ridiede
slancio alla produzione, favorita anche dal diffondersi dell'uso della terracotta quale elemento decorativo in architettura, come testimoniano gli stupendi manufatti presenti nel cimitero
monumentale, nelle ville e nei palazzi.
Ai giorni nostri la tradizione è perpetuata da circa 150 botteghe che producono maioliche terrecotte e figurine ora realizzate nella più rigorosa tradizione calatina,
ora riprendendo, trasformando, innovando.
Sciacca, in provincia di Agrigento, può essere considerato il terzo polo ceramico della Sicilia. Tutto cominciò tra il ‘400 e il ‘500 quando i baroni e i vescovi diedero impulso all’attività di
alcuni maestri maiolicari locali con forti commesse di piastrelle decorate, per abbellire chiese e palazzi tra i quali il Duomo di Monreale di Monreale.

Fu l'occasione che permise di affinare le tecniche e ricercare canoni estetici diversi da quelli di influenza saracena e catalana aprendo al nuovo gusto rinascimentale
italiano che caratterizza ancora oggi la produzione di molti artigiani locali.
Il momento di maggior fulgore della maiolica di Sciacca fu il ‘500, periodo in cui operarono alcuni tra i più importanti maestri ceramisti tra i quali Giuseppe
Bonachia, detto “il Mayharata” unanimemente considerato il più grande pittore di mattonelle siciliano e autore della fascia maiolicata della cappella di San Giorgio dei Genovesi di Sciacca,
costruita nel 1520 è distrutta nel 1952.
I laboratori attualmente in funzione sono circa 30 e svolgono la loro attività artistica nel rispetto dell'antica tradizione che si esalta nella decorazione dei vasi in
cui dominano i colori del passato quali il giallo paglia, l'arancione, il turchese, il blu e il verde ramina.

In quasi tutte le regioni italiane, la lavorazione dell'argilla si è sviluppata parallelamente nella produzione di oggetti rustici, d'uso quotidiano, e in forme più raffinate che spaziano dalla maiolica alla ceramica d'arte, alla porcellana. E quasi sempre, una delle due ha prevalso sull'altra caratterizzando in questo modo la produzione regionale. In Toscana, invece, queste due forme di artigianato continuano a convivere, godendo entrambe di un buon successo commerciale.
Nel primo l'attività si affermò a partire dal ‘300, raggiungendo il massimo sviluppo tra il 1490 e il 1540 quando, grazie allo stimolo del mercato fiorentino, si passò
dalla maiolica arcaica e dai rustici boccali decorati in verde e bruno, ai primi generi di lusso (come la “zaffera a rilievo”) recuperando le tradizioni arabe, imitando e reinterpretando le
prestigiose produzioni smaltate provenienti dalla Spagna, assimilando i colori e i decori dei nuovi dettami rinascimentali, fino alla creazione delle serie che caratterizzarono l'epoca d'oro di
Montelupo Fiorentino: i fiori gotici, l'occhio della penna di pavone, la palmetta persiana .
Dalla metà del XVI secolo fino a tutto il ‘600, la produzione si sdoppio, da una parte le splendide ceramiche per i palazzi e per le chiese di Firenze, dall'altra
quelle di consumo, caratterizzate da un approccio popolare fresco e genuino in cui i decori rappresentavano scene di vita quotidiana, preti e briganti, musici e armigeri, donne e cavalieri.
I due secoli successivi segnarono una progressiva decadenza qualitativa e creativa che, fortunatamente, si arrestò alle soglie del ‘900 quando ripresero vigore le
grandi produzioni di maiolica e il settore si consolidò.
Attualmente, nella zona di Montelupo Fiorentino, operano circa 90 tra imprese industriali e manifatture artigiane, con una produzione prevalentemente centrata sugli
oggetti d'uso ed ornamento per la casa, in cui gli stili spaziano dalle riproduzioni rinascimentali al design moderno, dalla terracotta tradizionale ai prodotti di tendenza per la tavola
La storia della ceramica di Sesto Fiorentino, invece, ebbe inizio nel 1737, con la fondazione della manifattura Ginori, fabbrica artigianale di maioliche e porcellane
di grande pregio artistico che divennero famose in tutta Europa nel giro dei pochi decenni.
Intorno a questo nucleo produttivo di grande eccellenza, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, nacquero molte botteghe artigianali, spesso per iniziativa di ex pittori e modellatori della
Ginori stessa che per qualche ragione avevano abbandonato la fabbrica
Questa fioritura di laboratori intorno al nucleo centrale della manifattura storica, nel frattempo trasformatasi in vera e propria industria, è proseguita, tra alti e
bassi, ancora per tutto il ‘900, dando vita a un distretto di grande vivacità produttiva. Oggi si contano circa 90 aziende che perpetuano con successo l'antica tradizione della ceramica sestese.
CERAMICA E TERRACOTTA IN
[Abruzzo▪Basilicata] [Calabria
▪Campania] [Emilia▪Lazio▪Liguria]
TORNA A
 RuvidaMente
RuvidaMente