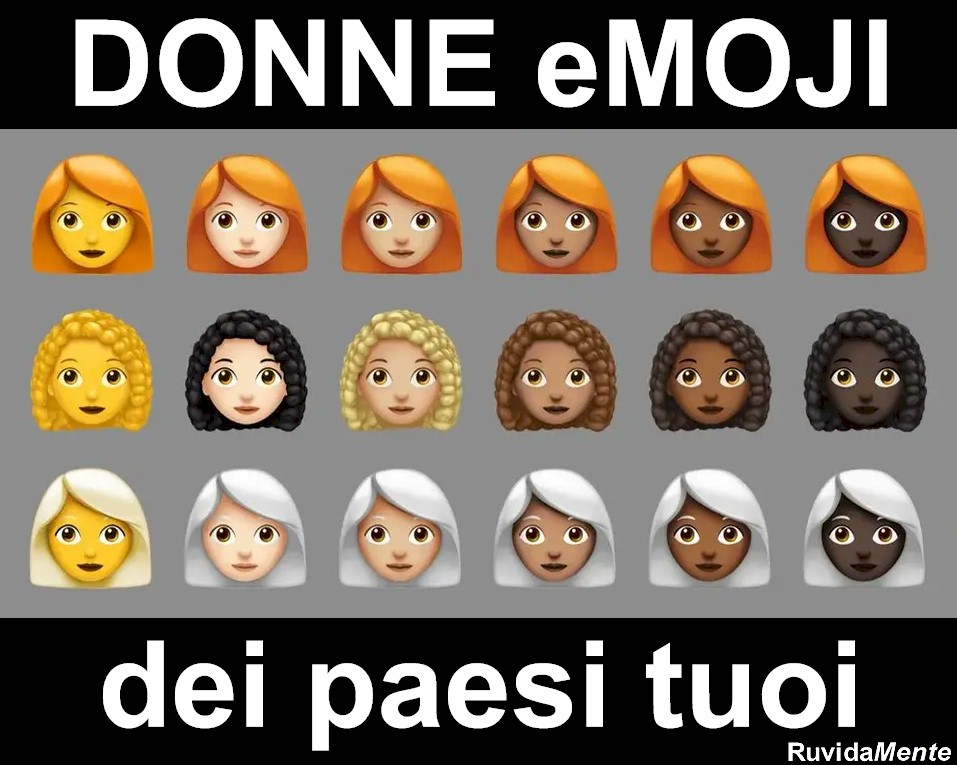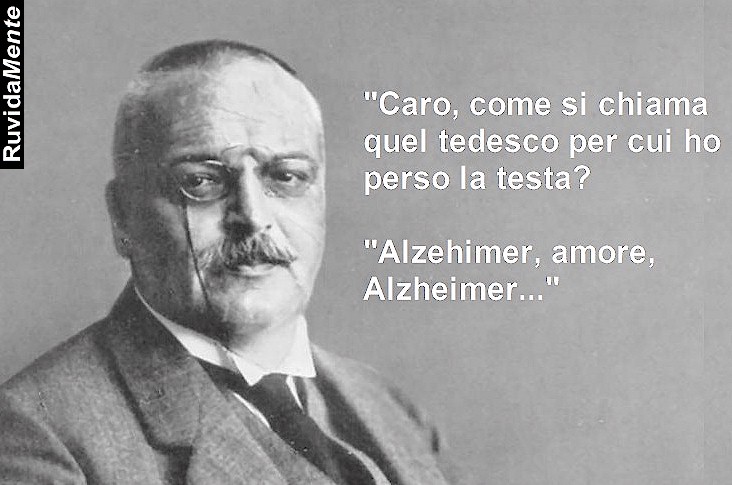Il primo fornitore di materia prima di qualunque forma di comunicazione ha un’identità precisa: si chiama “cambiamento”. E questo è ancor più vero nel mondo del vino: se non ci fosse un continuo fervore fatto di innovazione, progresso tecnologico, riscoperta di antiche pratiche viticole e vinicole, recupero e deportazione di antichi vitigni, la comunicazione del vino non avrebbe nemmeno ragione di esistere. Invece, tra vecchi e nuovi attori del mondo della produzione, da qualche decennio è in atto un affannoso rincorrersi fatto di accelerazioni, volate, sorpassi, improvvise frenate, ricerca di percorsi alternativi e, più spesso, di scorciatoie.
Questo ha portato ad un moltiplicarsi abnorme dell’offerta, non solo in termini di etichette presenti sul mercato, ma anche di tipologie vinicole, così radicalmente dissimili le une dalle altre che non sarebbe improprio parlare addirittura di diverse “tipologie merceologiche”.
Il guaio è che la collocazione di queste nuove “personalità” tipologiche, non è definita, chiara, mappabile tanto in termini geografici che economici, che normativi. Comunque cataloghiamo il vino, per prezzo, per denominazione, per area geografica, all’interno di quella categoria ritroviamo tutte le macro-tipologie che si sono delineate nel mercato. E lo stesso accade se come teatro d’indagine utilizziamo il produttore: che si tratti di un piccolo, un medio o un grande viticultore, una cantina sociale o un mercante, una boutique winery o una multinazionale, nel suo catalogo, immancabilmente troveremo, nella maggior parte dei casi, una pluralità di tipologie affiancate senza una logica, senza che alle spalle vi sia una strategia e, men che meno, una filosofia aziendale.
La buona regola di un osservatore attento è fermarsi ogni tanto, ragionare e magari trarre delle conclusioni, stampare una fotografia d’insieme, salire dal particolare al generale e capire in che direzione stiamo andando. Per migliorare proprio il lavoro dell’osservatore, fornire strumenti critici a chi produce, dare una mano al consumatore che ha mille motivi per ritrovarsi per lo meno disorientato.
Anni di attenzione verso ciò che si agita, tanto sulla scintillante superficie delle tavole
imbandite che nel buio delle cantine, ci porta a delineare la presenza, sul mercato, di sei macro-tipologie, ognuna con una sua ben definita ragion d’essere, sia tecnica che
merceologica:
il vino-alcol, il vino-zucchero, il vino-frutto, il vino-legno, il vino-terra e il vino-immagine.
È il vino che ha calcato la scena da protagonista per qualche millennio, quello che ha fatto cantare i poeti perché contribuiva a illanguidire gli animi ed indurli al trasporto amoroso, quello che infiammava i soldati e dava loro il coraggio di lanciarsi nella battaglia. La quantità d’alcol presente in un’unità di misura è stata per secoli il parametro della qualità, l’indicatore del valore economico di qualunque partita di vino.
Con l’evolversi delle tecniche vitivinicole e dei gusti del consumatore, però, l’alcol ha cominciato a perdere il suo ruolo centrale a vantaggio di altri elementi che via via hanno fatto la fortuna di qualche zona vincola (pensate all’effervescenza dello Champagne, al fruttato dei vini tedeschi, al dolce del Porto) senza però mai riuscire ad imporsi come nuovi parametri di valutazione qualitativa e di valore. Nell’ultimo secolo, il vino-alcol è stato sempre più relegato nella fascia dei consumi di basso livello e ha visto tra i suoi principali artefici due categorie di produttori: gli industriali (in cui, per nostra comodità, includiamo anche i commercianti e le cantine sociali) e gli autoproduttori (ovvero quella miriade di contadini con un fazzoletto di vigna che producono il vino per sé, i propri familiari e pochi clienti-amici).
In termini statistici, il vino-alcol rappresenta ancora la fetta più grande del mercato ma negli ultimi trenta anni lo scenario è mutato radicalmente. Industriali, commercianti e cantine sociali, pur dedicandosi prevalentemente alla fascia bassa del mercato, hanno inevitabilmente investito in tecnologia trasformando radicalmente il proprio prodotto, conferendogli caratteristiche che vanno ben al di là delle istintive richieste della loro clientela. Chi ha memoria gustativa trova oggi nei vini venduti in brick, o nelle dame, o alla spina, caratteristiche organolettiche che negli anni Settanta contribuivano all’eccellenza di alcuni produttori d’avanguardia.
Questo salto di qualità ha determinato un curioso fenomeno: i consumatori di vino-alcol sono sopravvissuti alla quasi totale sparizione del prodotto che cercano e si trovano “costretti” a bere meglio perché sul mercato di peggio non c’è. A meno che non si rivolgano al variegato mondo degli autoproduttori che forse si è un po’ ridotto in quantità ma non è mutato di una virgola in termini qualitativi. Lì l’obiettivo è lo stesso di qualche secolo fa: produrre quanta più uva possibile e ricavarne un vino ben ricco d’alcol. Ed anche le tecniche utilizzate sono sempre le stesse, primordiali, rozze, taccagne, quasi a mutuare la regola che sembra provenire dalla religiosità popolare: il vino è un miracolo ed il miracolo è bello e credibile se si palesa in un contesto di povertà (economica e mentale). Lo slogan lo conosciamo benissimo: “Questo vino è fatto con l’uva!”.
Se il vino-alcol è stato per millenni il dominus della scena vitivinicola, in ogni tempo ha dovuto cedere una piccola parte del proscenio, ma la più in vista, al vino-zucchero. Perché da sempre e fino ai primi anni del Novecento, se il contenuto in alcol era il primo motivo di attrazione, l’essere dolce era l’elemento discriminante tra il vino del volgo e quello dei potenti, quello delle taverne e quello delle tavole regali, il primo bevuto seduti su una panca, il secondo mollemente adagiati su un triclinio.
Il Novecento può essere a buon diritto definito il secolo del riscatto dei vini secchi e quello del tramonto dei vini dolci, il cui universo si è nettamente spaccato in due: da una parte quelli di bassa qualità, quasi sempre frizzanti o spumanti, fatti per catturare i palati ignoranti, per allietare le feste popolari ed i banchetti di nozze; dall’altra la nobile stirpe dei passiti, i botridizzati, le vendemmie tardive, così raffinati ed estremi che la dolcezza diventa un elemento marginale, quasi un incidente inevitabile, al massimo una sorta di basamento la cui funzione è quella di supportare, e quindi esaltare, l’abnorme insieme di profumi e sapori che riescono a concentrare in un piccolo calice.
I primi sono quelli quantitativamente più diffusi e possono generare forti guadagni, anche se difficilmente consolidabili: l’ignoranza è sempre transitoria ed i palati o si evolvono approdando a vini migliori, o regrediscono diventando facile preda dei soft drinks, le cole e le birrette.
I secondi rappresentano una piccola nicchia di mercato, marginale in quanto a fatturato globale ma estremamente significativa per quanto riguarda l’immagine di chi li produce. Si tratta, insomma, di esercizi di stile, pezzi di bravura in cui ci si lancia alla ricerca dell’applauso a scena aperta, non importa se poi il botteghino piangerà, lamentando che c’erano più invitati che spettatori paganti.
Non c’è persona al mondo, esperto o novizio, bevitore abituale o occasionale, che non dispieghi un bel sorriso quando avvicina naso e labbra ad un calice che sprigiona freschezza, profumi di fiori e sapori fruttati. Il vino-frutto è l’archetipo sognato e perseguito fin dagli albori dell’enologia, quello che donò ebbrezza a Noè, quello cantato da tanti poeti e bevuto da pochi mortali. L’essere stato chimera per millenni è dovuto al fatto che le tecniche di vinificazione e conservazione permettevano al vino di esprimere direttamente le caratteristiche dell’uva con cui era ottenuto solo per un brevissimo periodo dell’anno, dalla svinatura all’arrivo dei primi caldi. Ed il rapido degrado susseguente ha spinto i viticoltori ad inventare tecniche di conservazione che inevitabilmente mortificavano proprio il fruttato, quello stretto e naturale (oltre che piacevole) legame con il vitigno di provenienza. I progressi tecnologici degli ultimi cinquanta anni hanno messo a nostra disposizione tecniche che permettono di superare egregiamente quell’antico handicap e offrire al mercato vini-frutto che mantengono la loro fragranza per tutto l’anno ed anche oltre. Ci sarebbe da sbizzarrirsi in una competizione di eccellenza, invece ben pochi produttori di prestigio si misurano con questa tipologia e se lo fanno è prevalentemente per ragioni di cassetta, per aggiungere al listino un vino di facile mercato, destinato a procurare ori piuttosto che allori.
Eppure non ci sarebbe momento più indicato di questo, almeno in Italia, per affrontare la produzione del vino-frutto in termini di alta qualità: la generalizzata focalizzazione sui vitigni autoctoni, infatti, in quale altro ambito potrebbe offrire i suoi migliori risultati? Che senso ha riscoprire il Nero d’Avola e poi affinarlo in barrique per farlo assomigliare quanto più possibile ad un Cabernet bordolese? È un’operazione sensata cercare di salvaguardare il nostro “immenso patrimonio varietale” senza poi trasferirne le caratteristiche peculiari nel vino che se ne ricava? Il guaio è che, per il momento, quella dei vitigni autoctoni sembra più una moda (se non una disperata speranza commerciale) che una scelta strategica di lungo periodo. Anche se qualche produttore illuminato sta seminando bene e c’è da augurarsi che possa tracciare un nuovo percorso capace di avviare anche i vini-frutto verso l’olimpo dell’élite enologica.
Domina la scena da qualche secolo ed è il risultato del convergere di fattori casuali e intuizioni tecnologiche che hanno portato ad una codifica, universalmente accettata, dei parameri di qualità dei vini moderni. Il fattore casuale consiste nell’avvento dei contenitori di legno che via via, nelle cantine, hanno sostituito anfore, orci e vasche in pietra e muratura. L’intuizione, nell’aver compreso che questi nuovi contenitori non erano solo recipienti ma vere e proprie macchine enologiche che intervenivano nella maturazione del vino, lo miglioravano pur trasformandolo dal punto di vista gustativo, ne uniformavano le caratteristiche salienti rendendo più simili i vini di diverse provenienze e vendemmie, gli conferivano longevità allungando non poco la stagione della sua commerciabilità.
Non è casuale che la terra primigenia del vino-legno sia Bordeaux e che quello sia il luogo in cui da sempre il mercato è nelle mani dei “negociant”, ovvero gente attenta proprio a quelle caratteristiche di stabilità organolettica e temporale che garantisce un vino (ben) affinato in legno. E non è altrettanto casuale che il vino-legno sia diventato uno standard mondiale, primo cimento di chiunque voglia misurarsi, nel vecchio come nei nuovi mondi, con i mercati internazionali. Uno standard gustativo che negli ultimi trenta anni ha rapidamente sceso i gradini della piramide qualitativa spingendo i più smaliziati produttori di massa (leggi: australiani e cileni) a riscoprire antiche tecniche di arricchimento in tannini (oggi si chiamano “chips”, Sante Lancerio, lodandone l’impiego, le chiamava “tacchie”) utilizzandole per produrre vini-legno a basso costo e con enormi potenzialità di mercato.
I produttori italiani si sono accorti con molto ritardo di questo trend e, quando ne hanno acquisito consapevolezza, vi si sono buttati con l’entusiasmo (e l’ingenuità) dei novizi mirando immediatamente a “battere” i dominatori del mercato, ovvero i grandi chateau bordolesi. Qualcuno, come il Sassicaia, ha anche vinto gloriosamente la sua battaglia ma è così evidente che i “nostri” sono talmente carenti in unità, equipaggiamenti ed organizzazione che la guerra non potranno mai nemmeno sognare di vincerla.
Il vino-legno italiano, insomma, con la sola eccezione delle due roccaforti del Brunello e del Barolo, peraltro in perenne stato di ristrutturazione, appare come un grande mosaico in cui ogni singola tessera splende per bellezza, colore ed intensità di luce, ma l’immagine d’insieme continua ad apparire sfuocata, di quelle in cui ciascuno riesce a vederci quello che vuole.
Rileggendo le schede di valutazione pubblicate nelle vecchie annate delle numerose guide ai vini ancora imperanti, vi accorgereste come alcuni descrittori fossero quasi assenti nelle prime e presenti con sempre maggior frequenza anno dopo anno. Parliamo del sostantivo-aggettivo “minerale”, della grafite, la pietra focaia, e tutti quegli elementi che provengono dalle viscere della terra anziché dal mondo vegetale.
Questo cambiamento nel nostro linguaggio non è una fisima di degustatori in cerca di originalità ma la spia di un cambiamento in atto, di una nuova tendenza che serpeggia tra i produttori votati all’alta qualità e che non la perseguono cercando di assomigliare ai mostri sacri già consolidati. Questa nuova sfida possiamo chiamarla vino-terra, ovvero un vino che trascende il vitigno e lo utilizza in quanto strumento per assorbire e far suoi gli umori del suolo in cui affonda le radici. E poi trascende il legno e lo piega ad attrezzo utile per cementare quegli umori, smussarne le spigolosità, bilanciarli e restituirceli in perfetta armonia tra loro.
Intendiamoci, niente di nuovo sotto il sole. Il vino-terra ha una sua ben precisa patria di elezione, consolidata da qualche secolo ed apprezzata soprattutto da chi di vino se ne intende al di là delle mode e dei giochi di prestigio del marketing: la Borgogna. Lo straordinario è che, quasi in modo spontaneo, nelle più diverse parti d’Italia, nuovi produttori decidano sempre più spesso di cimentarsi nella produzione di vini-terra, affrontando un’impresa per molti versi temeraria, sia dal punto di vista vitivinicolo che commerciale. Perché si tratta di vini che richiedono grandi fatiche e sacrifici, terroir di rara complessità minerale, vigne estreme per età, conformazione e metodo di allevamento, pratiche agronomiche ed enologiche raramente codificate, intuizione più che raziocinio, coraggio condito con un pizzico di follia. Ed una volta avviati al mercato devono combattere contro gli stereotipi del successo consolidato, fatto di potenza, ricchezza, aggressività, tutti elementi che hanno facile gioco nell’affabulare anche il consumatore ben acculturato.
Per quanto l’impresa sia ardua, i risultati sono confortanti ed è sicuramente da questa nicchia che emergeranno i grandi vini italiani del futuro. Hanno solo bisogno di tempo, di incoraggiamenti e di un consumatore più maturo, disincantato e profondamente sensuale.
Questa sesta macro-tipologia sarebbe da prendere in seria considerazione ma, percorrendo trasversalmente ciascuna delle precedenti, essa non potrebbe strutturalmente far parte di questo elenco. Il vino-immagine rappresenta una categoria possente per numeri e valore, protagonista di ogni mercato nazionale ed internazionale, vincente in ogni tempo, capace di sedurre e affascinare anche il degustatore più esperto e smaliziato. Il vino-immagine è un prodotto che si concretizza in bottiglie che non vengono ordinate e stappate per la tipologia cui appartengono, per i profumi ed i sapori che riescono a dispiegare, per il piacere che si prova a berle. Vengono ordinate e stappate per ciò che rappresentano, per la capacità di appagare le aspettative della nostra mente prima ancora di quelle del nostro palato e della nostra pancia.
Le energie spese dai produttori per confezionare intorno ai propri vini un’immagine vincente sono in costante crescita e la lotta per emergere si fa sempre più dura, senza esclusione di colpi. Sono sforzi che spesso pagano, ammantando i vini che ne sono oggetto di un’aura magica capace di condizionare enormemente le scelte del consumatore, ma anche l’atteggiamento degli esperti e di quei degustatori che fanno dell’obiettività il proprio marchio distintivo (ed è questa la prima ragione del moltiplicarsi delle degustazioni cieche, la necessità di verificare su campioni anonimi i giudizi positivi elargiti degustando a carte scoperte).
Tutto questo, ovviamente, senza volere a tutti i costi connotare negativamente la categoria del vino-immagine. Si tratta solo di riuscire ad individuare la sottile linea di demarcazione tra fascino e bellezza. E degustare senza i condizionamenti dell’immagine può servire a svelare quando il fascino, spesso, è solo uno strumento per nascondere una sostanziale mancanza di bellezza.
Anche se oggi, ad onor del vero, il problema del vino italiano sembra essere del tutto inverso: tanti, troppi vini sono sorprendentemente belli ma relegati ai margini del mercato per una cronica mancanza di fascino. E non saranno certo i giudizi, i voti e le classifiche stilate dagli esperti a trasformare i topini in cavalli bianchi, le zucche in carrozze dorate e le cenerentole in principesse.
LEGGI ANCHE:

 RuvidaMente
RuvidaMente