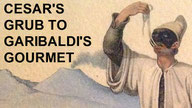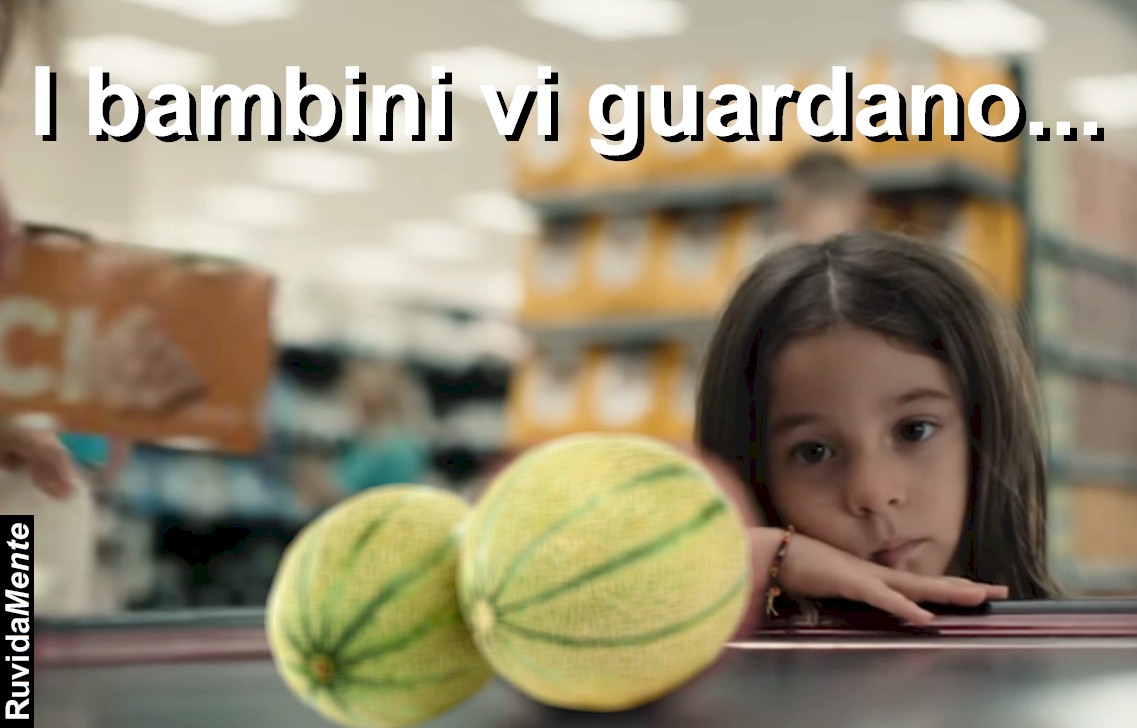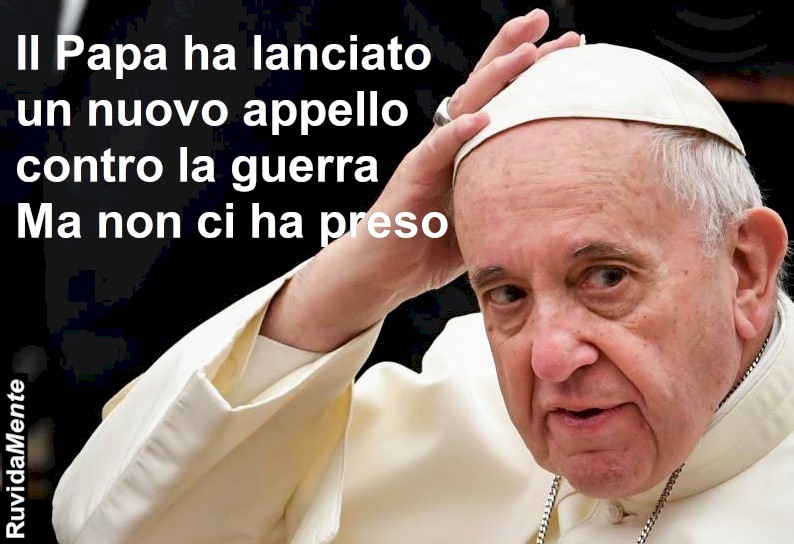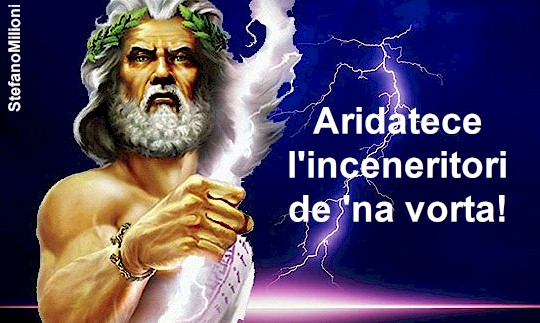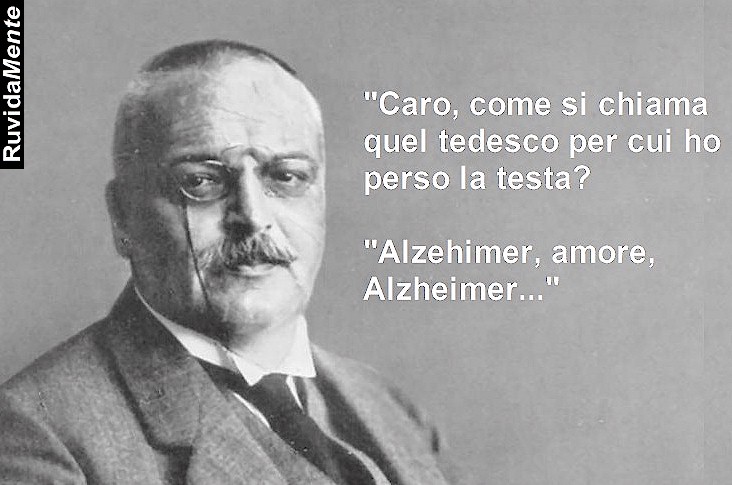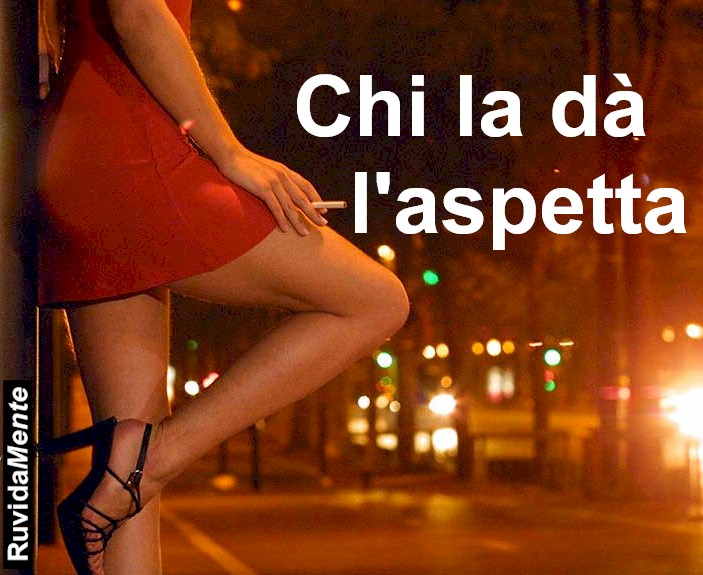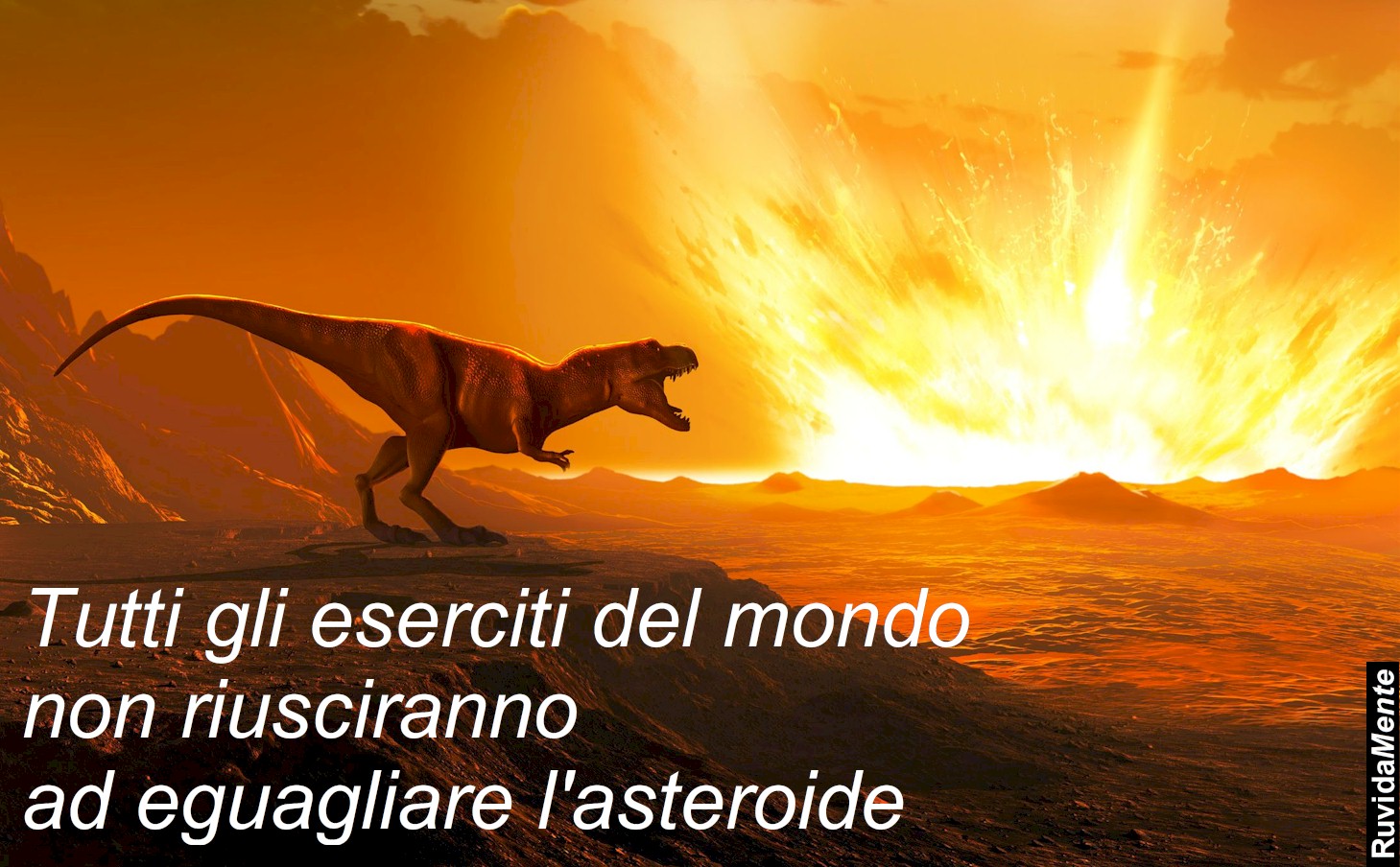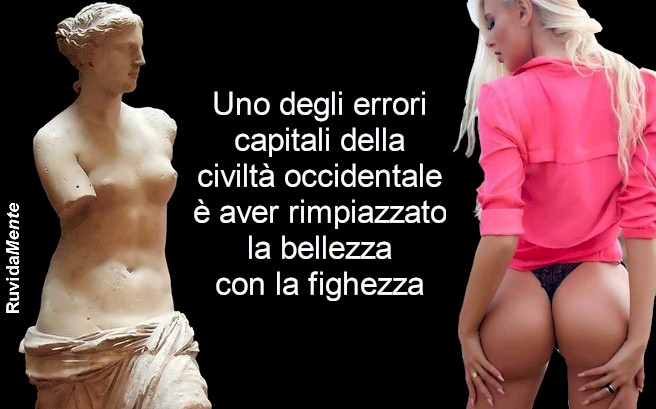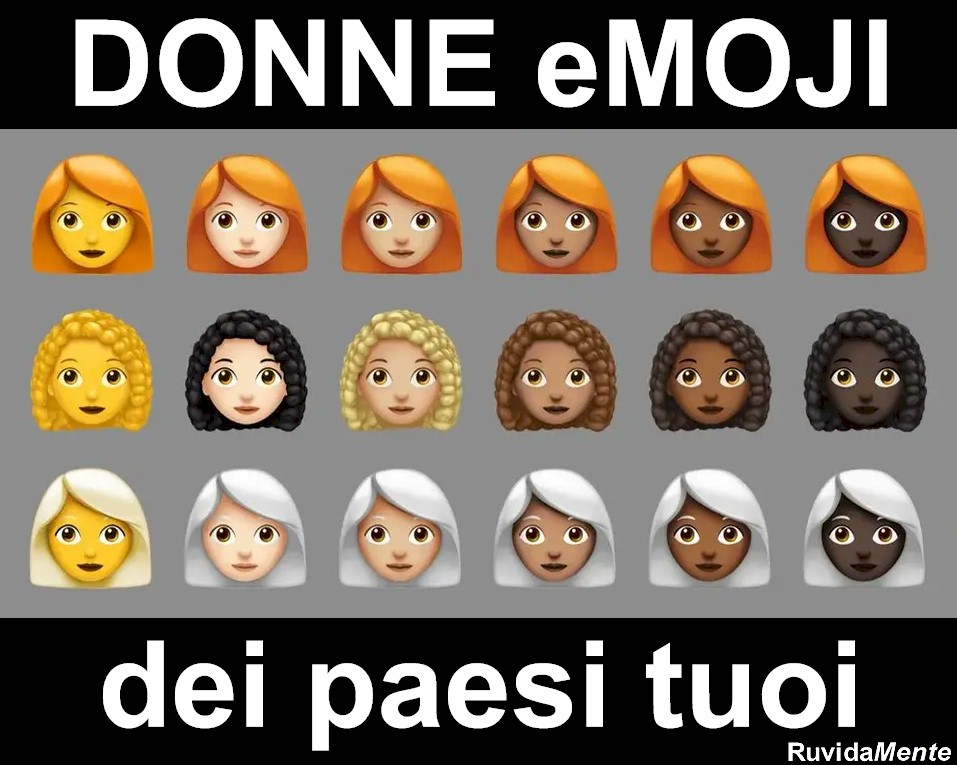Napoli, vera e propria capitale del Mezzogiorno, con la sua complessa storia politica e culturale, fa della Campania una regione a se' stante, in cui si confrontano realtà diverse, spesso antitetiche.
Da una parte, un esteso entroterra formato da tanti piccoli centri, confinati per secoli in un pressoché totale isolamento, dall'altra una città cosmopolita, fulcro di scambi con tutto il mondo conosciuto.
Questa situazione ha permesso lo sviluppo di due filoni di artigianato ben distinti. Il primo, tipico delle zone rurali dell'intera penisola, dedito alla soddisfazione delle necessità locali e articolato nelle produzioni di necessità, di consumo e, in parte, voluttuarie. Il secondo, sollecitato da una committenza agiata e dai gusti raffinati, spesso imposto dirigisticamente dai regnanti con l'impianto di manifatture che si sono sviluppate grazie alla vivacità intellettuale e all'atteggiamento positivo di quelle popolazioni.
Le espressioni artigianali più alte e originali della Campania sono espresse da questo secondo filone e hanno dato luogo a comparti produttivi di eccezionale livello qualitativo, capaci di primeggiare su tutti i mercati mondiali.
LA CERAMICA
L'origine delle porcellane di Capodimonte data 1739, quando Carlo III di Borbone creò una manifattura tanto prestigiosa quanto segnata da una breve esistenza, conclusasi vent'anni dopo quando il re, salito al trono di Spagna, si trasferì a Madrid.
Dodici anni dopo, però, con la creazione della Real Fabbrica Ferdinandea la tradizione fu ripresa accreditando la sua eccellenza ad un livello tale che, quando nel 1805
cessò la sua attività, la produzione delle porcellane poté essere perpetuata ad opera di singoli artigiani dotati ormai di qualità tecniche e creative che hanno permesso loro di far fronte alle
richieste del mercato fino ai giorni nostri.
Se a Capodimonte compete il primato delle porcellane d'arte, a Vietri sul Mare spetta il titolo di capitale campana della ceramica, una forma di artigianato
sviluppatasi dal '400 al '600.
Il passaggio dalla ceramica d'arte a quella di consumo è avvenuto tra il 1920 e il 1940, ad opera di un nutrito drappello di artigiani provenienti dal Nord Europa cui va il merito del rilancio della produzione vietrese.
Un altro importante polo produttivo è Cava dei Tirreni. Qui, dopo un avvio nella scia dei ceramisti vietresi, il settore si è consolidato con la specializzazione nelle piastrelle di ceramica
smaltata i cui motivi decorativi trovano ispirazione nella tradizione vietrese e nell'arte della maiolica napoletana.
Del tutto autonoma, invece, l'evoluzione della ceramica di San Lorenzello e Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, che ripropone oggetti dalle sagome
settecentesche con decorazioni di fiori, frutta e uccelli, dai colori giallo, arancio, verde e blu, oppure acquasantiere, vasi da farmacia a da conserve, medaglioni e tavolette maiolicate
narranti la vita dei Santi.

IL CORALLO
Nonostante lungo il litorale napoletano la pesca del corallo fosse praticata fin dall'antichità, primi laboratori di lavorazione e incisione sono sorti a Torre del Greco agli inizi dell''800, occupando gli stessi pescatori che si sono inventati artigiani, traendo ispirazione, per i loro monili, dai reperti che, negli stessi anni, venivano alla luce negli scavi di Ercolano e Pompei.
Nel 1879, la creazione della Scuola di Incisione del Corallo ha contribuito ad incrementare ulteriormente la qualità degli artigiani locali che sono riusciti anche a
diversificare la produzione, proponendo lavori di incisione su conchiglie, turchese, malachite e tartaruga.
Le competenze acquisite hanno permesso di superare anche la penuria di materia prima derivata dall'impoverimento dei fondali e l'attività prosegue oggi, floridissima,
lavorando coralli di provenienza orientale.
IL PRESEPE NAPOLETANO
L'arte presepiale napoletana è figlia di un insolito processo che ha visto, nel '700, un folto gruppo di scultori inventarsi artigiani cedendo alle sollecitazione dei
loro aristocratici committenti che desideravano arricchire il loro Natale con presepi di straordinaria bellezza.
Il presepe napoletano, con personaggi che propongono usi e costumi popolari, è composto da figure con alcune parti in terracotta dipinte con colori vivaci, quindi
montate su un manichino in fil di ferro e stoppa e addobbate con abiti in seta pura e ricamati in oro.
La raffinata opera di questi artigiani, capaci di operare contemporaneamente su più materiali, affiancando alla scultura fasi di oreficeria e di tessitura pregiata, si estende anche alla ricostruzione delle scenografie (la taverna, il mercato, i mestieri) creando un unicum espressivo che rende unica al mondo questa forma d’arte che continua ad essere praticata da un ristretto drappello di artigiani riuniti in un consorzio che ne promuove e ne tutela l'operato.
LA TESSITURA
L'arte della tessitura, in Campania, ha luogo e data di nascita certi. Ferdinando IV, infatti, nel 1789, fondò la colonia di S. Leucio, in provincia di Benevento, e per renderla economicamente autonoma creò una manifattura di veli di seta.
L'attività iniziò con una seteria meccanica che sfruttava la materia prima generata dal bachi allevati localmente; quindi, dai primi filatoi e dai telai, si passò alla costruzione di una grande filanda.
Oggi, nonostante la scomparsa dell'allevamento del bachi e della filatura, questa manifattura continua a mantenere in vita una tradizione lontana servendosi di artigiani locali che producono tessuti jacquard per l'arredamento, damaschi e broccati.
Ovviamente, oggi la produzione è realizzata in massima parte con telai meccanici, anche se, in fase di rifinitura, i lavori vengono lavorati a mano e avere un “San Leucio” rimane, senza dubbio, un segno di distinzione e di prestigio.
LA CARTA DI AMALFI
In uso sin dal 1231, la carta d'Amalfi veniva prodotta nelle cartiere che sorgevano nella Valle del Mulini. II processo di fabbricazione della "carta a mano" d'Amalfi seguiva diverse fasi, dalla triturazione dei cenci alla formatura della poltiglia di stracci e colla in forme con la bordura di legno e la filigrana nel mezzo.
Una volta consolidati, i fogli formati dalla poltiglia venivano trasferiti su appositi feltri, pressati, staccati, asciugati, stirati e confezionati in pacchi pronti
per l'impiego nelle più raffinate forme di editoria d'arte.
Attualmente, in Campania, le cartiere che lavorano ancora la carta a mano sono una decina, di cui solo due ad Amalfi, e le loro produzioni sono in tutto paragonabili a
quelle esposte nel Museo della Carta allestito nel cuore della Valle dei Mulini.
Come attività derivata, sempre in provincia di Salerno, a Castel San Giorgio, alcuni artigiani hanno messo a punto una raffinata tecnica che permette di ottenere suggestive stampe fotografiche direttamente su fogli di carta a mano di Amalfi.
IL RICAMO
La lunga attesa delle donne dei marinai ha fatto sì che lungo le coste e nelle isole campane si sviluppasse l'arte del ricamo, dando vita ad una vera e propria produzione artigianale che è ancora vitale soprattutto nell'isola di Procida.
Metri e metri di merletti, destinati a fare mostra di se' su bellissime tovaglie, lenzuola e camicette, sono il risultato di una dedizione continua e costante che si tramanda di madre in figlia, un lavoro artigianale nell'accezione più vera del termine.
La produzione è basata soprattutto sulla riscoperta di vecchi motivi grafici, utilizzando i disegni che fanno parte del patrimonio di famiglia e realizzando cosi un
prodotto artistico che affonda le sue radici nella tradizione e nella storia del luogo.
Le donne di Santa Paolina, in provincia di Avellino, invece, perpetuano l'antica tradizione della lavorazione del tombolo. Attraverso l'abile manipolazione dei fuselli,
qui chiamati "tonnarielli", realizzano merletti di grande pregio che riproducono antichi disegni come "la faglia d'uva" e la "spina di pesce".

IL TORRONE DI BENEVENTO
Composto da albume d'uovo, miele, nocciole e mandorle, arricchito con cioccolato, liquori ed essenze di agrumi, il Torrone di Benevento è il dolce "tipico" del Sannio.
Conosciuto già al tempo dei Romani e citato negli scritti di Tito Livio, il Torrone di Benevento si diffuse in particolar modo nel
'600, periodo a cui risalgono le prime varietà: il Perfetto Amore, ricoperto di cioccolato, limone o caffé; l'Ingranito, arricchito da piccoli confetti allungati e farcito con una granella di
zucchero; il Torrone del Papa, realizzato con zucchero liquefatto e pinoli.
Nel Torrone di Benevento, passato e presente, arte e tradizione si fondono armoniosamente, soprattutto perché oggi come ieri la qualità dipende dagli stessi fattori:
scelta delle materie prime, lavorazione accurata, cottura perfetta, rispetto delle antiche ricette e delle metodologie di produzione artigianali.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Soprattutto lungo le coste e nelle isole, in Campania non bisogna certo rincorrere fiere e mercatini per trovarsi a contatto con le più varie espressioni dell'artigianato locale.
Gli stessi centri storici di Napoli, Salerno, Amalfi e Sorrento si presentano in qualunque giorno dell'anno come allestiti per l'occasione e per il turista al divertimento si associa unicamente l'imbarazzo della scelta.
Ovviamente, vi sono occasioni d'incontro assolutamente inusuali, dove l'offerta dei prodotti dell'artigianato contemporaneo e di quello antico si interseca con manifestazioni di grande tradizione storica e religiosa, in un connubio di sacro e profano in cui la contagiosa spontaneità delle popolazioni locali riesce sempre a scongiurare gli scivolamenti verso il cattivo gusto e la profanazione.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente