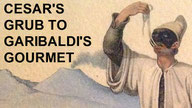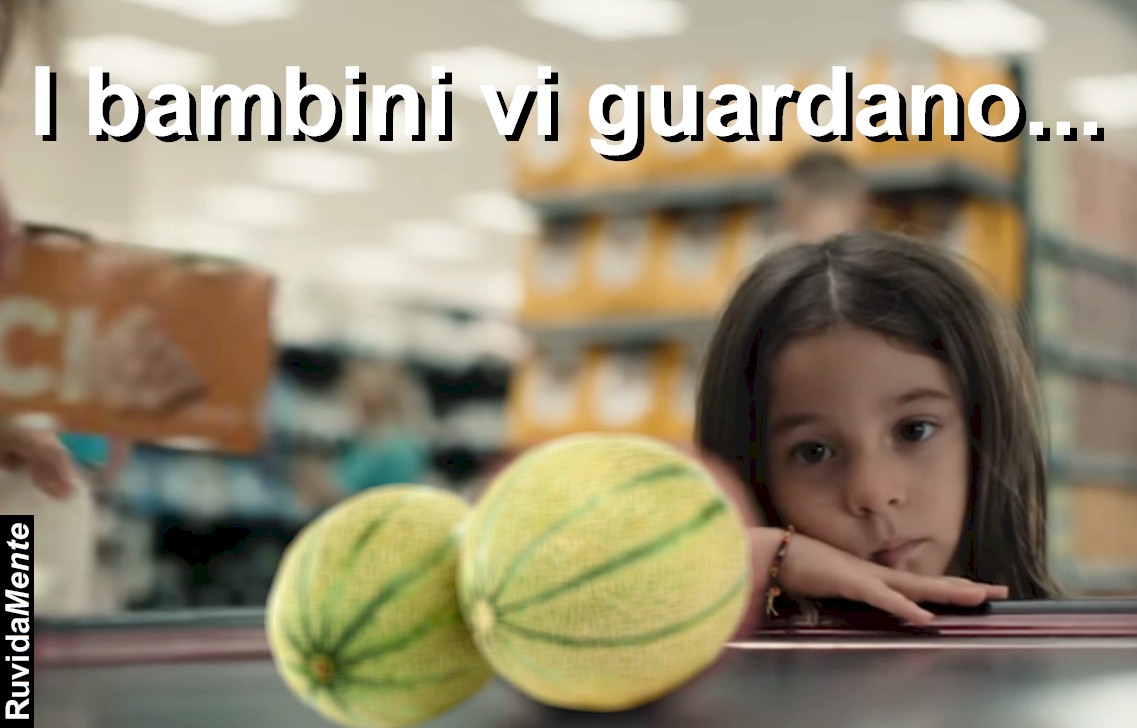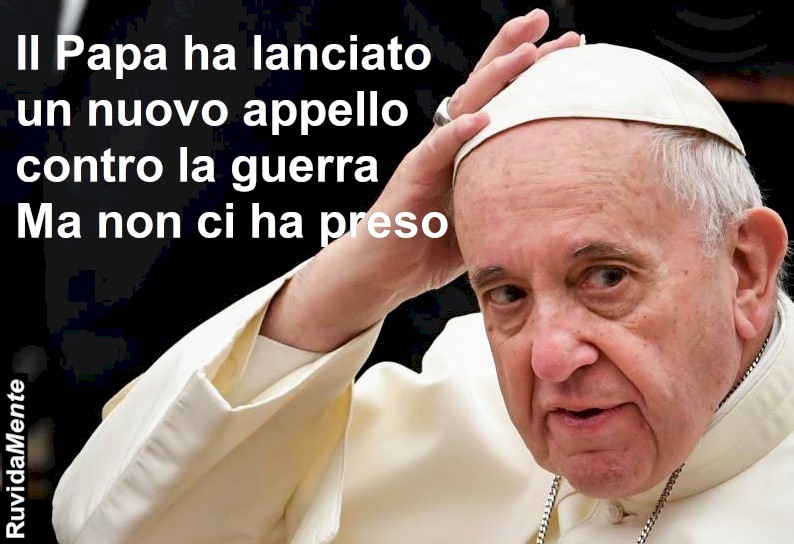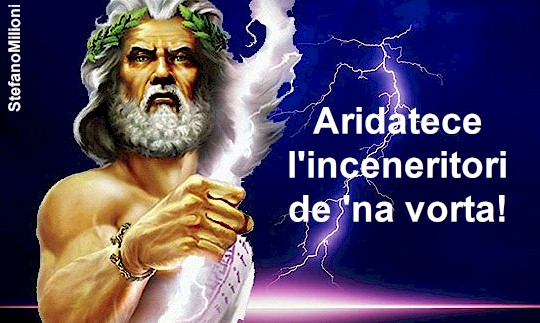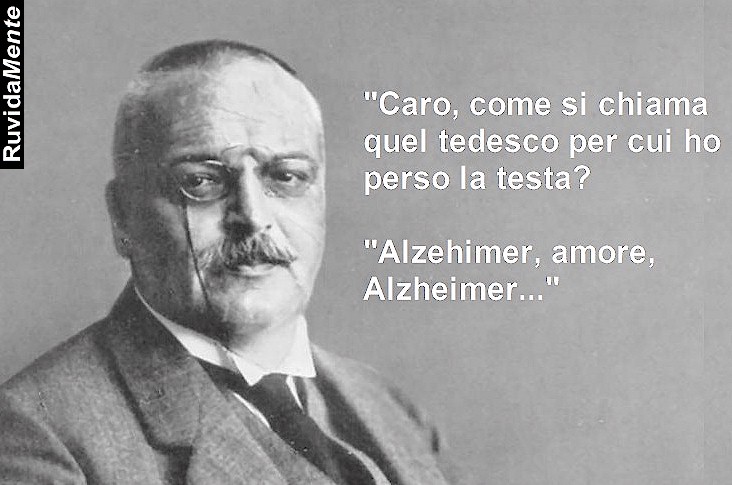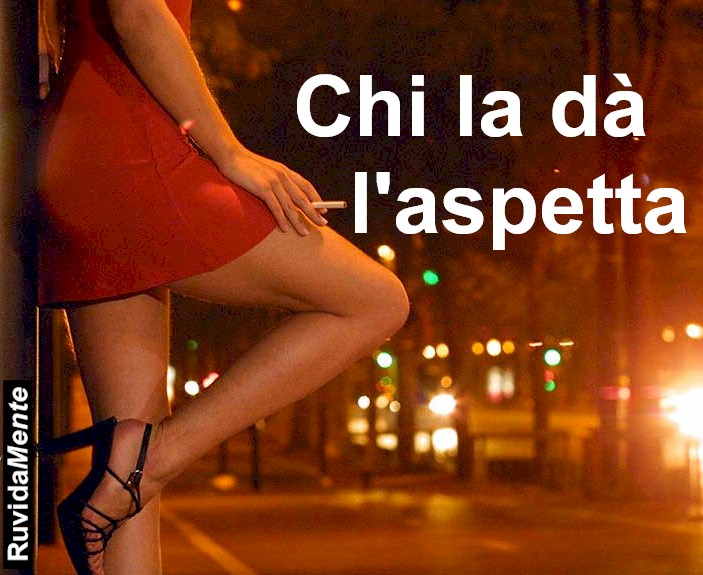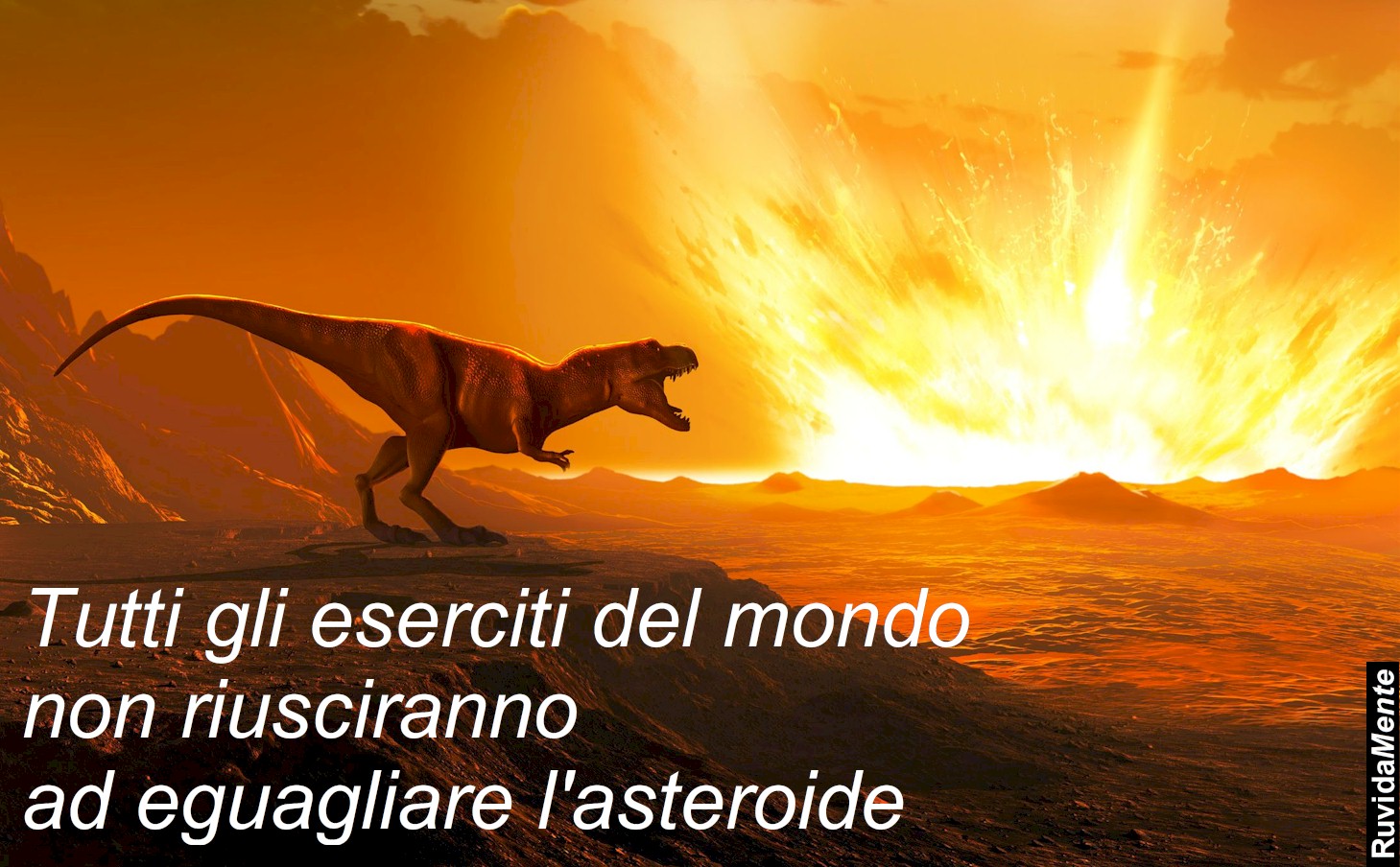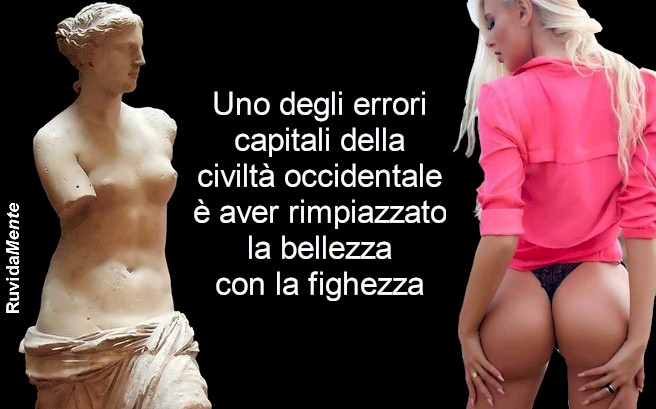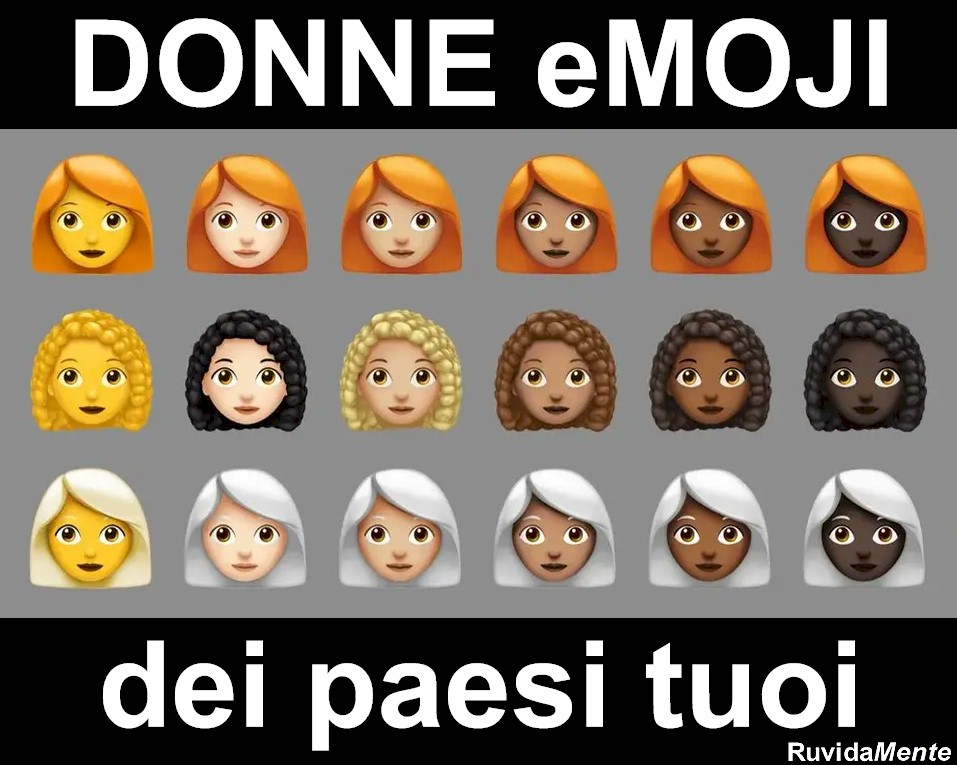Quando l'agricoltura era l'attività dominante, quella capace di condizionare l'economia di un territorio, "benessere" e "ricchezza" erano due termini inscindibili, addirittura intercambiabili nel linguaggio corrente. La grande fertilità delle pianure emiliane e romagnole ha fatto di questa regione un territorio in cui per tanto tempo tutte le espressioni della vita hanno gravitato intorno all'agricoltura e lo stesso artigianato si è sviluppato in funzione di questa grande risorsa.
In seguito, quando il primato dell'economia è passato nella sfera dell'industria, e buon parte della tradizionale ricchezza di queste genti si è ridimensionata, emiliani e romagnoli non si sono lasciati sfuggire l'altra faccia della loro fortunata condizione e si sono tenuti ben stretti tutti i fattori alla base del loro benessere.
Tra questi, oltre ai capisaldi della cultura popolare (riti, tradizioni, balli, musica, gastronomia, ecc.) anche le tante forme di artigianato che, in un contesto caratterizzato da un generale ottimismo e un approccio positivo alle problematiche della vita, non è stato idealizzato e mummificato come valore antico da preservare, ma vissuto quotidianamente, in alcuni casi revitalizzandolo nelle sue forme più tradizionali, altre volte rinnovandolo profondamente e facendone il motore di una mutazione radicale che ha permesso di trasformare una terra a vocazione agricola in uno dei più avanzati distretti dell'innovazione industriale.
LA CERAMICA
La "ceramica" è una delle realtà industriali più rilevanti dell'Emilia Romagna. Non c'è paese al mondo dove non vengano esportate le piastrelle e le mattonelle prodotte a Sassuolo, in provincia di Modena, e Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Non è un'industria nata dal nulla, ma la felice evoluzione di un insieme di elementi – tecnica, cultura, tradizione, manualità – che si sono sviluppati attraverso i secoli nella produzione artigianale di manufatti in ceramica, sia di uso comune che d'arte.
Diversamente da quanto accade spesso in questi casi, in questa regione
il passaggio dall'artigianato all'industria non ha comportato il soccombere del primo alla seconda e i due camparti prosperano in parallelo, seppur con dimensioni di mercato completamente
diverse.
Storicamente nasce tutto a Faenza, dove la ceramica d'arte ha fama tanto antica e consolidata che nelle lingue di mezza Europa il nome della città è diventato sinonimo
di "maiolica" ed anche nel gergo degli informati e addetti ai lavori per "faenze", indipendentemente da dove vengono prodotte, si intendono unicamente le ceramiche di terracotta smaltata in
bianco all’ossido di stagno e decorata con colori vivaci.

La memoria storica di questa attività che si perpetua da oltre otto
secoli è il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, dove le produzioni storiche locali si confrontano con pezzi provenienti da ogni parte del mondo. Intorno, nelle vie del centro storico,
è un brulicare di botteghe dove si formano al tornio vasi dalle fogge più disparate che poi saranno decorati a mano e cotti secondo le tecniche tradizionali. Gran parte della produzione ripropone
le forme e i decori classici della ceramica faentina, ispirati soprattutto al periodo medioevale e rinascimentale, ma sono in forte sviluppo anche produzioni all'insegna della creatività cui
offrono un prezioso contributo artisti contemporanei di fama internazionale.
Faenza, comunque, non detiene il monopolio assoluto della ceramica artigianale. Interessanti realtà sono tuttora vitali in provincia di Parma, in particolare a Noceto,
nota per i suoi vasi da farmacia, e Ferlaro Collecchio, dove si è sviluppato uno stile particolare, caratterizzato dai fondi bianchi con decorazioni che vanno dal color ruggine all’azzurro
intenso. Non vanno dimenticati, infine, i tradizionali boccali un tempo imperanti nelle osterie e nelle trattorie popolari, che oggi costituiscono la principale produzione delle botteghe di
Imola.
IL MOSAICO
Una forma di artigianato può nascere per le più diverse ragioni e spesso la casualità ne è la matrice principale. Meno casuali sono le ragioni che le permettono di sopravvivere o, addirittura, svilupparsi, e tra queste gioca un ruolo determinante la formazione dei nuovi operatori. Con buona dose di retorica, si vorrebbe sempre vincente il passaggio di testimone di padre in figlio, ma i risultati più concreti li danno le scuole specializzate, come nel caso dell'Istituto Statale d'Arte per il Mosaico di Ravenna cui va riconosciuto il merito di aver trasformato il mosaico in qualcosa di vitale, da progettare e produrre, e non solo da ammirare nello splendore dei monumenti bizantini della città.
D'altra parte, quella del mosaico non è una produzione che si esaurisce nel gesto creativo: in essa si devono combinare la fantasia creatrice dell’artista e la paziente
manualità dell’artigiano, e questo richiede doti di educazione e disciplina che può trasmettere solo una scuola.
Nel loro complesso, le attuali botteghe dei mosaicisti di Ravenna rappresentano una straordinaria realtà artigianale dove si percorrono tutte le possibili strade di
quest'arte, dalla riproduzione di mosaici antichi, utilizzando tecniche e paste vitree colorate simili a quelle che venivano impiegate in epoca romana e bizantina, alla sperimentazione di nuovi
percorsi, estetici e tecnici, i cui esiti hanno attirato l'attenzione di numerosi artisti contemporanei, quali Capogrossi, Campigli, Chagall, Guttuso, Cagli, Birolli e molti altri, tutti attratti
dalle insospettate potenzialità espressive di un tecnica tanto antica.
IL FERRO BATTUTO
In una regione in cui l'economia si è sviluppata a tappe forzate creando un "modello" spesso esportato con successo, è naturale che gran parte delle botteghe di fabbro
si siano trasformate in aziende, piccole ma estremamente dinamiche, per lo più dedite alla produzione di carpenteria metallica e infissi. È l'inevitabile evoluzione di un artigianato, quello del
ferro battuto, che in Emilia Romagna ha una lunga e ben consolidata tradizione e che, fortunatamente, si perpetua di fianco alle forme di industrializzazione favorite dalle richieste del
mercato.
Le espressioni più caratteristiche di questa antica arte sopravvivono, più per ragioni turistiche che produttive, nelle viuzze di Grazzano Visconi, in provincia di
Piacenza, un agglomerato di fattezze medioevali sorto alla fine dell'Ottocento, nel quale le numerose botteghe di fabbro si inseriscono con grande effetto scenografico.
La lavorazione artistica del ferro, comunque, è ancora praticata diffusamente in tutta la regione, con alcuni centri dove prevalgono lavorazioni particolari, come Ciano d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove si producono letti e altri oggetti d’arredamento, Brisighella, in provincia di Ravenna, specializzata nella replica degli antichi lampadari e negli attrezzi per camino, e Ferrara dove gli artigiani prediligono la realizzazione di cancellate, ringhiere e balaustrate.
LA TESSITURA E IL RICAMO
Al pari di molte altre regioni italiane, anche l'Emilia Romagna ha un centro in cui, in passato, si è sviluppata la tradizionale lavorazione dei ricami. Curiosamente,
qui ciò è avvenuto a Rimini, la cui fama di capitale delle vacanze sembra mal conciliarsi con la quieta e certosina dedizione che richiedono i merletti a tombolo. Eppure, questa produzione
continua, seppur in forma molto ridotta rispetto al passato.
Nella regione, comunque, la più importante attività tessile era determinata dalla grande estensione delle coltivazioni di canapa che caratterizzavano la pianura
emiliana: questa quotidiana dimestichezza con la materia prima ha fatto sì che in ogni casa contadina fossero operativi, soprattutto nei mesi invernali, telai manuali dai quali madri e figlie
ricavavano manufatti per uso proprio e per offrire sulle bancarelle dei mercati di paese.
Si tratta di produzioni che si differenziano nettamente da quelle di altre regioni soprattutto per l'abbondanza e la vivacità delle decorazioni, applicate con una tecnica al tempo stesso semplice ed originale, attraverso l'impiego di stampi intagliati in legno di pero e impasti di colori minerali in cui dominano i toni del verde, del blu e del rosso.
È un artigianato che viene ancora praticato soprattutto nella zone di Gambettola, in provincia di Forlì, e di Imola, con procedure a loro modo "eroiche" dove si combinano l'ereditarietà della tradizione (gli stampi utilizzati sono ancora quelli dell''800 e di inizio '900) ed i segreti del mestiere, soprattutto per quel che riguarda le formule di preparazione dei colori.
GLI INTRECCIATI
Nelle zone palustri del delta del Po, il connubio terra-acqua, senza una precisa linea di demarcazione, ha sempre favorito lo sviluppo di una vegetazione rigogliosa che ha attratto popolose colonie di animali. In un contesto di tale esuberanza, l'uomo ha accettato di sfidare la sostanziale insalubrità di questi luoghi, attratto dalle ricchezze immediate che essi offrivano, ingegnandosi di sfruttare fino all'ultima risorsa.
Per cui, una volta soddisfatta la sua brama di cacciatore e pescatore, è riuscito a far tesoro anche delle risorse apparentemente più insignificanti, quali la tipica
canna palustre, detta qui “pavera”, il cui arbusto veniva utilizzato per tessere stuoie, e le foglie per intrecciare sporte e cappelli, oppure la “bosmarola”, un'erba spontanea delle zone umide,
impiegata per fabbricare scopini e spazzole molto resistenti.
Sono attività che, in alcune forme tradizionali, sopravvivono qua e là per il delta, soprattutto nella zona di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. In forma più
organizzata, invece, hanno ritrovato vitalità altrove, in particolare a Ciano d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, e Roccabianca, nel Parmense, dove si è sviluppata una florida produzione di
oggetti e mobili in vimini
LE OCARINE
Emiliani e Romagnoli hanno un'innata predisposizione alla socializzazione e a tutte le forme di espressione che la favoriscono. Ne sono uno specchio fedele i loro cibi, i vini e, soprattutto, la loro musica, tanto nelle sue espressioni colte (la lirica) che in quelle popolari (il liscio).
Tra gli elementi che rendono immediatamente gradevole la musica che qui allieta le feste di paese c'è un popolare timbro sonoro che nemmeno i più sofisticati strumenti elettronici riescono a riprodurre: è quello dell'ocarina, un semplice strumento a fiato in terracotta inventato a Budrio, in provincia di Bologna, da Giuseppe Donati verso il 1860.
Il suo immediato successo, dovuto anche ad una geniale concezione che permette di modulare una scala diatonica insieme a note cromatiche, ha fatto di Budrio una specie di luogo di culto dove fin dall''800 si promuove e si preserva l'arte di produrre le ocarine, come quella di suonarle, tanto nei suoi ambiti naturali, quelli della tradizionale musica popolare, quanto lanciandosi in confronti arditi in cui i musicisti locali si misurano con i grandi brani della musica classica.
I RICHIAMI
Le zone paludose del delta, grazie all'abbondanza di uccelli migratori che vi fanno tappa ogni anno, sono sempre state un vero paradiso per i cacciatori. Qui, una delle tecniche di caccia più diffuse prevedeva l'utilizzo dei richiami galleggianti, qui chiamati stampi, perfette riproduzioni di germani ed altri uccelli palustri che venivano lasciati fluttuare in ben precisi specchi d'acqua, con la funzione di attrarvi gli stormi di migratori.
Oggi, questo tipo di caccia è molto meno praticato e i richiami utilizzati sono quasi sempre di plastica, più rozzi e meno costosi, ma sufficientemente efficaci. Ma gli artigiani che si sono specializzati nella produzione degli stampi (la maggior parte si concentra nel territorio del comune di Argenta, in provincia di Ferrara) non sono rimasti senza lavoro, avendo trovato un insperato nuovo canale di vendita nel settore dei componenti d'arredo.
La raffinatezza delle loro realizzazioni, infatti, non è sfuggita all'occhio esperto di architetti ed arredatori che hanno immediatamente apprezzato la maestria con cui gli arbusti palustri vengono trattati e legati in fasci, quindi modellati a riprodurre le sembianze del corpo dell'anitra, sormontati da una testa realisticamente scolpita in legno e infine verniciati con grande realismo.
LE IMBARCAZIONI
Il delta del Po è un microcosmo straordinario che ha sempre attirato le popolazioni circostanti che, per viverlo e farlo proprio, si sono dovute ingegnare costruendo mezzi di locomozione al tempo stesso semplici e straordinariamente efficienti, facili da manovrare e, soprattutto, capaci di giungere ovunque.
Dalle prime imbarcazioni a fondo piatto, dalle linee sommariamente abbozzate, si è via via passati alla progettazione di modelli specializzati, quali il “mammalucco”, uno scafo di cinque metri adatto alla caccia; la “batana”, leggermente più lunga e molto più larga, funzionale alle attività della pesca, e il “velocipede”, dallo scafo lungo e affusolato, utilizzato per le regate.
Nonostante la spietata concorrenza degli scafi in plastica, i cantieri del delta che producono queste barche continuano la loro produzione con un discreto successo, costretti, per l'esiguità delle commesse, a perpetuare la tradizionale lavorazione a mano e quindi ad utilizzare, come un tempo, i legnami classici della zona, il pioppo per fondo e fiancate, il noce, il ciliegio e altri alberi da frutto per le centine.

IL CULATELLO
L'Emilia è un vero e proprio paradiso dei salumi. Ma un paradiso piramidale al cui culmine si colloca uno dei più straordinari e raffinati salumi d'Italia e del mondo: il culatello. D'altra parte, qualcosa di più raffinato del prosciutto di Parma lo potevano inventare solo coloro che da secoli hanno una quotidiana dimestichezza nel trattare, trasformare ed esaltare le cosce dei suini.
Il culatello viene prodotto in una ristretta zona lungo il torrente Parma, tra Zibello e Langhirano, ed è un salume costoso, prima di tutto perché per realizzarlo si sacrificano le migliori cosce di maiale ricavandone solamente la parte centrale che viene disossata e mondata di ogni parte grassa.
Dopo circa dieci giorni di salatura, i singoli pezzi vengono lavati con vino, ricoperti con un velo di sale e pepe macinato grossolanamente, quindi insaccati nel budello, badando di eliminare anche la minima bolla d'aria. A questo punto i culatelli vengono messi a stagionare per un periodo che si protrae da dieci a dodici mesi.
Questo è il periodo più delicato, dal quale dipende la minore o maggiore "soavità" del prodotto finale. È importante evitare che la carne si secchi troppo, e per questo si interviene inumidendo i culatelli con un canovaccio imbevuto di vino bianco, oppure cognac, o distillato di malto.
Anche grazie a queste cure, il culatello è un salume per il quale il momento del taglio diventa un rito ed il primo assaggio è sempre un'emozione, l'esame attraverso il quale chi lo ha accudito riceverà l'applauso o il biasimo dei suoi commensali.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Il carattere esuberante e incline ai piaceri della vita di emiliani e romagnoli si manifesta anche nelle feste e nelle manifestazioni organizzate in tutta la regione, dove quelle a tematica gastronomica dominano incontrastate. In realtà, questo dominio è solo di facciata, in quanto intorno all'occasione contingente, si aggregano sempre tutti gli elementi dell'intrattenimento popolare, con le sue declinazioni religiose, folcloriche e commerciali.
Per tutti, valga l'esempio della Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali di Coriano, in provincia di Ravenna, dove ai protagonisti ufficiali, olive, olio extravergine, tartufo, funghi, vino, miele e formaggi, si contrappone uno dei più vivaci mercati regionali dell'artigianato del vimini, del ferro battuto, della terracotta, del rame e del legno.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente