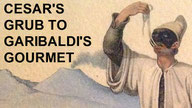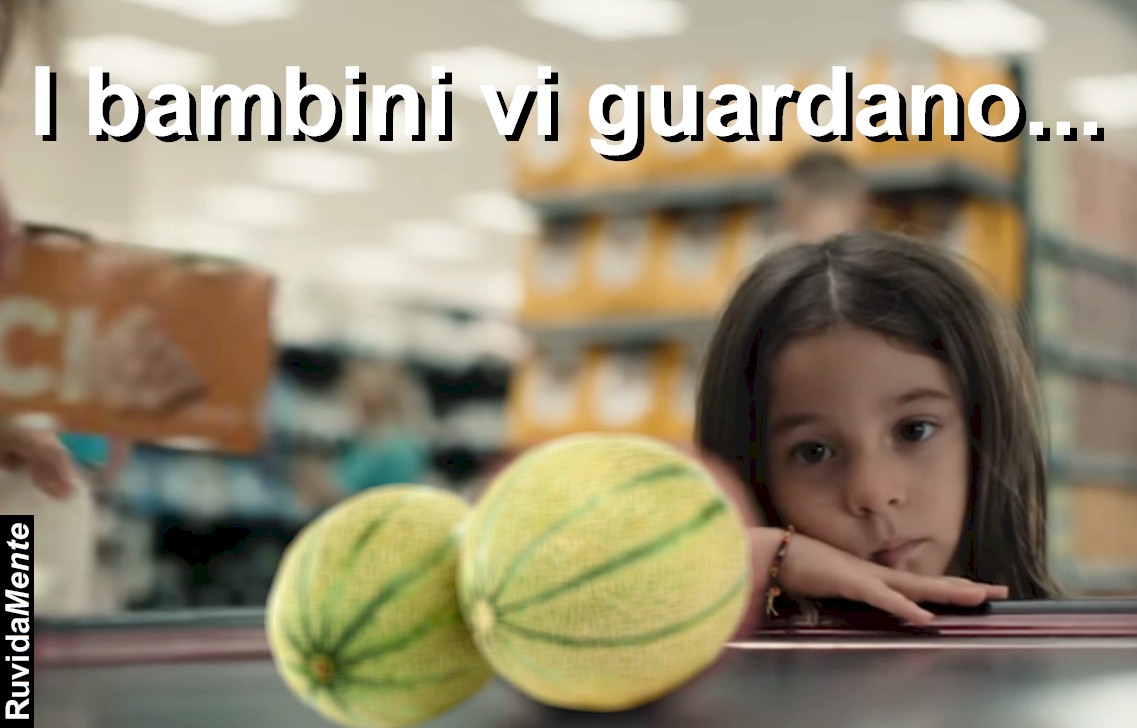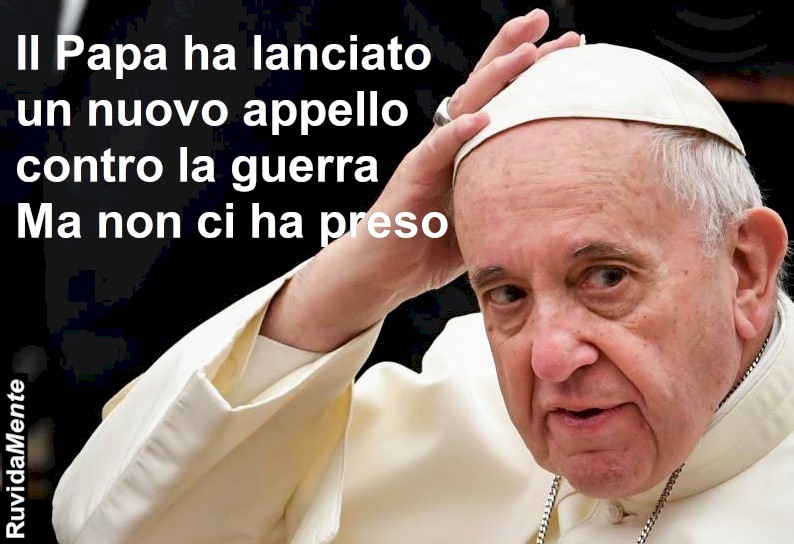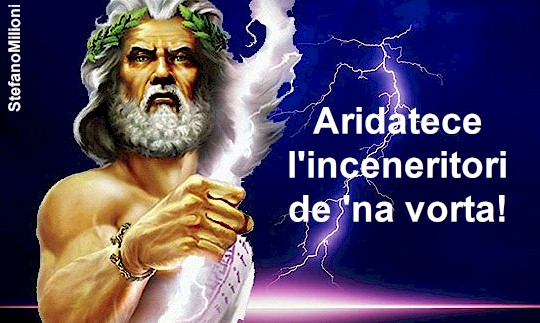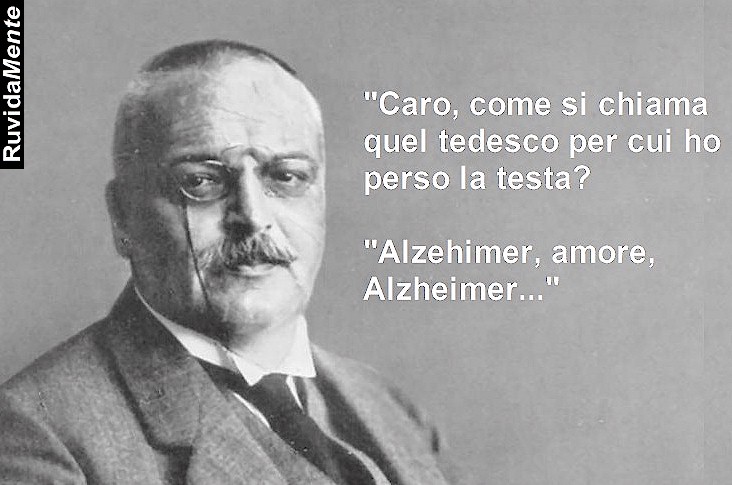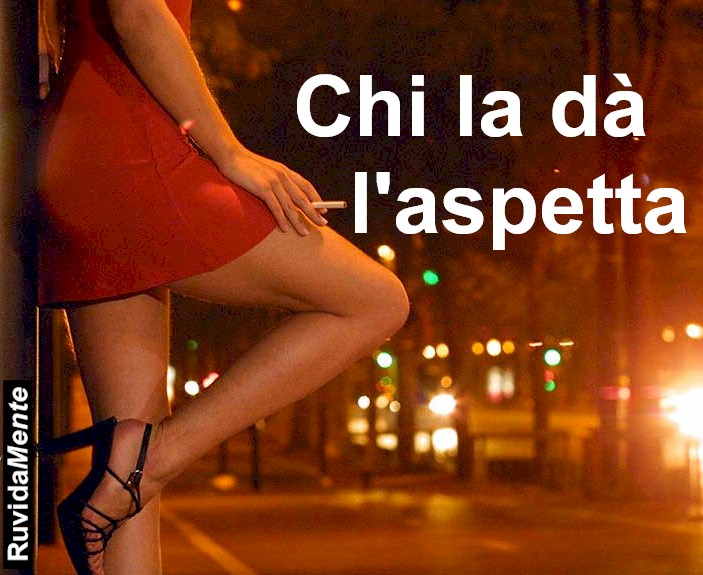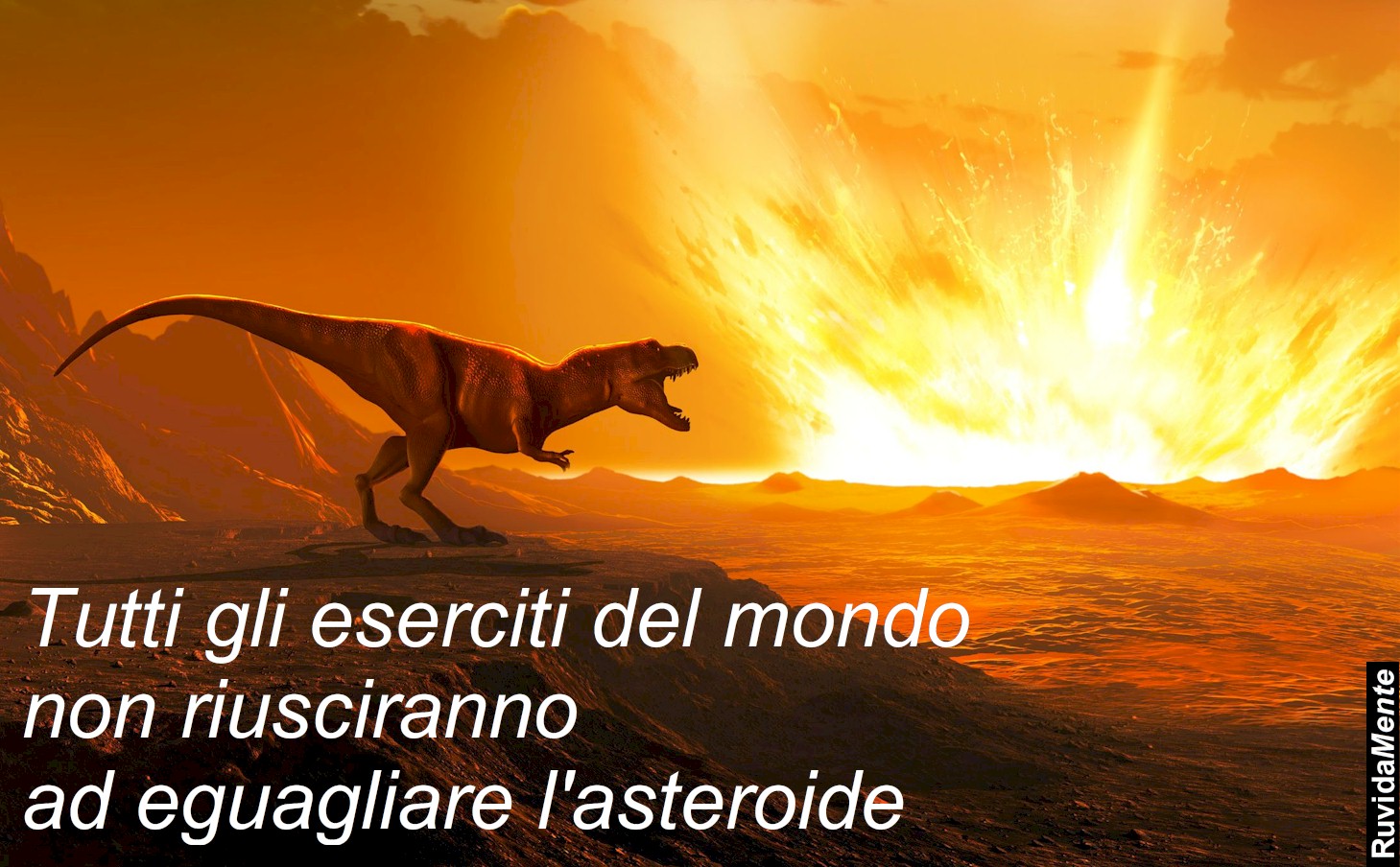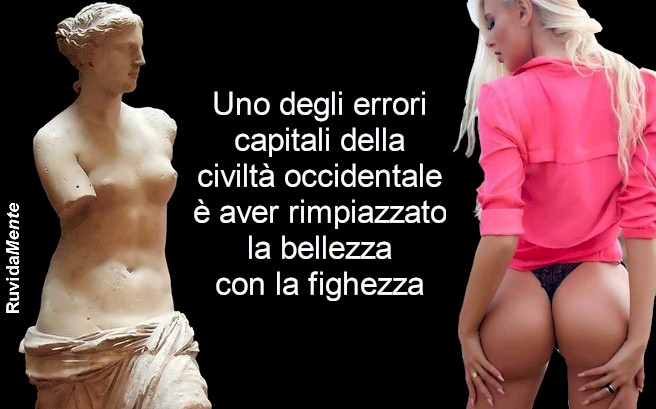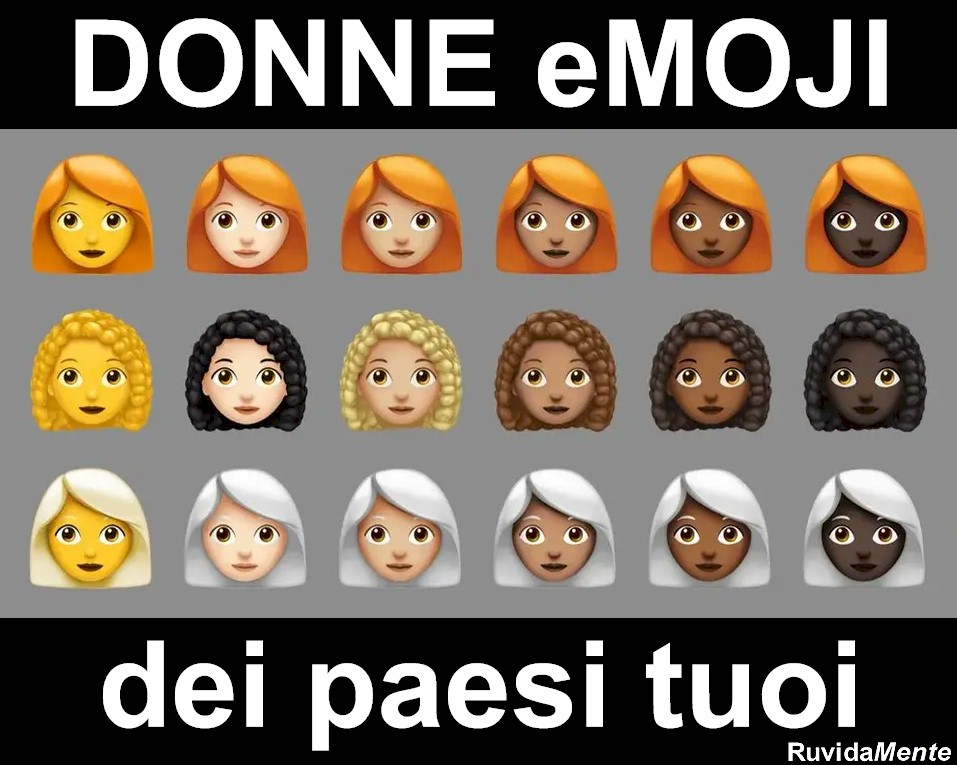Come in tutte le regioni che hanno conosciuto una forte industrializzazione, anche per l'artigianato della Liguria è facile emettere una sbrigativa diagnosi di estinzione. E se i dati statistici sembrano confortare una così impietosa sentenza, la realtà dei fatti ci spinge a pensare il contrario, stimolandoci a ripescare nella memoria ricordi e testimonianze recenti sulle attività di questo o di quell'artigiano, rese ancor più vivide dalla costante originalità dei manufatti, del contesto o della passione che gli artefici trasmettono attraverso il loro lavoro.
D'altra parte, i Liguri, vuoi per il loro carattere, vuoi per la complessità culturale indotta da secoli di interscambi con "l'altra parte del mondo", in qualunque loro espressione, non sono mai "banali" o superficiali: ogni loro atto o creazione è sempre frutto di impegno, di elaborazione culturale, di "rimuginamento" interiore che si trasforma in oggetto in cui funzionalità e bellezza sono solo una amichevole porta di accesso verso un mondo molto più complesso di quello che appare.
Proprio per questa ragione, almeno per la Liguria, il parametro di valutazione delle attività artigianali non può essere ridotto alla conta degli addetti o ai livelli di fatturato: qui, non c'è attività che possa definirsi estinta finché ci sarà anche un solo artigiano a praticarla.
LA CERAMICA
I primordi della ceramica di Albisola, caratterizzata dalle decorazioni blu cobalto, su fondo bianco o grigio-azzurro, risalgono al XII secolo. Nel '500, questa attività conosce un grande sviluppo, sia qualitativo che quantitativo, grazie all'opera di celebri famiglie che permettono alle maioliche di Albisola di affermarsi a livello internazionale.
Dopo la metà del '700, la tradizionale monocromia blu si trasforma e si arricchisce con fondi viola e rosa e colorazioni bruno-chiare. Nell''800, la concorrenza della nascente produzione industriale impone una radicale trasformazione del settore. Da un lato nasce la nuova ceramica popolare, a macchie nere e larghissima diffusione, dall'altra una ceramica squisitamente artistica.

Nel '900, la ceramica di Albisola diventa materia per espressioni artistiche delle avanguardie, in primo luogo il Futurismo, e ancora oggi i laboratori di Albisola Marina sono il polo d'attrazione per tanti artisti internazionali.
Ne è splendida testimonianza la passeggiata a mare di Albisola, composta da venti riquadri in ceramica realizzati da artisti del calibro di Capogrossi, Crippa, Luzzati, Fontana e altri esponenti di primo piano dell'arte contemporanea.
IL DAMASCO
A Lorsica, in provincia di Genova, sopravvive intatta l'antica lavorazione del damasco. Qui, i telai sono come quelli che si adoperavano nel '500 e il filo grezzo viene appositamente tinto e imbobinato su rocchetti da cui si prepara l'ordito. Nella fase successiva i fili passano ad otto per volta nel telaio, ad uno ad uno nei licci e poi ancora, a cinque per cinque, attraverso il pettine.
Per ottenere una pezza di un metro e trenta di altezza si devono far passare attraverso i licci ben quindicimila fili, un impegno che sembrerebbe una follia, ma l'unico in grado di ottenere un damasco che non appaia piatto, ma in rilevo dal dritto e concavo dal rovescio.
I risultati sono straordinari, con un fantastico gioco di fili d'argento e oro che formano i disegni, stagliati sui colori intensi dello sfondo, degni di appartenere, benché prodotti oggi, a pieno titolo all'antica tradizione del tessuto damascato ligure.
PIZZI MERLETTI E MACRAME'
La lavorazione del pizzo a tombolo si è diffusa in Liguria alla fine del '400, come riconversione dell'industria tessile della seta di cui Genova aveva perso la leadership a favore di Lione.
Facendo di necessità virtù, gli artigiani liguri sono riusciti presto ad affermarsi dando inizio ad una stagione felice che è culminata nel '600 e '700 con la conquista
di tutti i mercati europei. Florido ancora nell''800, questo artigianato è andato via via scemando e le poche merlettaie ancora attive si concentrano ora tra Rapallo, Santa Margherita e
Portofino.
Diversa, invece, è la storia del "macramè", una tecnica di annodatura di origine araba sviluppatasi a Chiavari agli inizi del '600. Con questa lavorazione
esclusivamente manuale si producevano raffinate bordure per asciugamani di lino, talmente apprezzate da rappresentare per i secoli successivi il punto di forza delle tessiture del Tigullio.
La crisi è intervenuta all'inizio del '900, con una ripresa negli anni '60 ad opera di uno sparuto drappello di ricamatrici che hanno saputo ridare impulso a questo raffinata e difficile forma di artigianato, indirizzandola verso altre forme di impiego, dalle tomaie delle scarpe alle borse, alle cinture, ai capi di abbigliamento.
L'ARDESIA
Nella corona di monti alle spalle del Golfo del Tigullio, fin da epoca precedente la dominazione romana, si estraeva l'ardesia, impiegata principalmente come materiale di copertura per i tetti.
Attraversi i secoli, però, la cultura dell'ardesia ha avuto grande sviluppo non solo negli impieghi edili, ma anche nella scultura decorativa, con grande varietà di
risultati plastici e destinazioni funzionali: in particolare nei portali d'epoca rinascimentale, lavorati a rilievo, e nell'uso di lastre di ardesia quale supporto per dipinti, con pittura a
olio, tempera e affresco.
Lo sfruttamento intensivo delle cave di ardesia è iniziato nel XII secolo a Uscio e Recco, quindi la produzione si è spostata verso il Monte di S. Giacomo, alle spalle
di Lavagna, finché, a partire dalla metà dell''800, l'attività si è sviluppata quasi esclusivamente nella Val Fontanabuona.
Attualmente, è in forte crescita il suo utilizzo nei settori dell'edilizia, nell'interior design, nelle piastrellature e nel restauro di edifici storici.
LA FILIGRANA
La tradizione dell''oreficeria risale ai tempi delle crociate e al successivo sviluppo di traffici con l'Oriente. Un ulteriore impulso fu determinato dalla fastosità
dall'oreficeria religiosa nel '600 e '700, che consentì agli orafi di scatenare la loro creatività svincolandoli dai parametri di costo dei manufatti.
Lo sviluppo della filigrana è posteriore e viene fatto risalire all'iniziativa di alcuni argentieri originari di Campo Ligure che, alla fine dell'800, avrebbero
abbandonato le botteghe genovesi facendo ritorno al paese d'origine. Il loro successo, favorito sia dalla personale abilità tecnica, sia dalla disponibilità di manodopera riconvertita
dall'industria tessile locale, fu immediato e nel breve volgere di un ventennio ha trasformato Campo Ligure in uno dei principali centri europei per la produzione della filigrana.
Da allora, la produzione ha continuato a mietere successi, raggiungendo la massima espansione negli anni '40 e rimanendo, nonostante una fisiologica contrazione nel
periodo successivo, uno dei settori artigianali più vivaci di tutta la Liguria, con un buon numero di imprese stabilmente impegnate nella creazione di gioielli in filigrana, anche se il numero
dei lavoranti si sta riducendo progressivamente.
IL LEGNO
La lavorazione del legno non poteva essere estranea ad una popolazione da sempre dedita alla marineria e, di conseguenza, alla costruzione delle imbarcazioni. Il
passaggio ad attività artigianali non legate alla cantieristica ha, però, origini più recenti, quando, facendo tesoro delle secolari professionalità maturate nell'arredo dei luoghi sacri,
all'inizio dell''800 si è sviluppata l'arte dell'intaglio ligneo, finalizzato prevalentemente alla costruzione di mobili.
Nello stesso periodo, ad opera di un singolo artigiano soprannominato "Campanino", iniziò a Chiavari la produzione di una caratteristica sedia che ha segnato un'epoca e
ha generato la nascita di un comparto artigianale di grande rilievo, florido per tutto l''800 e messo in crisi solo dallo strepitoso successo riscosso su tutti i mercati dalle sedie viennesi
"thonet".
La crisi fu grave ma non portò alla scomparsa delle aziende artigianali che, seppur ridimensionate, hanno continuato a produrre sedie fino ai giorni nostri, alcune industrializzandosi, altre perseverando nell'applicazione delle tecniche tradizionali.
IL FERRO
Le costruzioni dei centri storici della Liguria, dalle case dei piccoli borghi marinari ai palazzi delle città, sono sempre estremamente curate, ricche di particolari
preziosi anche nelle parti meno visibili. In questa ricchezza di "accessori", spiccano ovunque gli elementi in ferro battuto, testimonianza di un'arte che si è sviluppata fin da epoche remote
soprattutto all'interno dei centri abitati. Parallelamente, zone che offrivano maggiori spazi per le attività artigianali, quali Voltri, Masone, Voltaggio, Sassello e tutta la Valpolcevera, fin
dal '400 hanno ospitato laboratori specializzati nella produzione di chi odi, richiesti soprattutto dall'industria cantieristica.
Entrambi questi settori hanno cominciato ad entrare in crisi nell''800 con l'effetto che l'attività delle "chioderie", nonostante ripetuti tentativi di rilancio, si è
praticamente estinta, mentre quella del ferro battuto, seppur fortemente ridimensionata, è sopravvissuta ad opera di singoli artigiani che traggono i loro redditi dalla creazione di oggettistica,
dalle commesse di componenti per l'edilizia e dal restauro degli antichi manufatti.

IL MOSCIAME
Il mosciame è una conserva alimentare realizzata con i filetti di tonno appena pescato. Si tratta di un prodotto diffuso prevalentemente a livello locale, lavorato nei mesi di giugno e luglio, quando si pescano i migliori esemplari di tonno.
Con un'accurata opera di rifilatura, dal pesce si ricavano i filetti da porre sotto sale per qualche ora. Quindi vengono lavati, asciugati, pressati e sottoposti ad una essiccazione dolce e lenta, ai i raggi del sole o in camere alla temperatura costante di 25-30ºC.
Questa fase, che si può prolungare per qualche giorno, è la più delicata e l'abilità dell'artigiano consiste nel cogliere il momento in cui lucidità tonalità del colore bruno indicano il livello ottimale di maturazione.
Il mosciame si conserva bene sotto vuoto e si consuma affettato dopo averlo ammorbidito in una marinata di olio extravergine di oliva. Si può condire a piacere, ma già di per se' rappresenta un'esperienza gastronomica straordinaria.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Creazione e manutenzione sono le due facce dell'artigianato ligure, per forza di cose impegnato tanto a perpetuarsi che a mantenere in vita le testimonianze del suo ricchissimo passato.
Ecco, quindi che l'ideale luogo d'incontro, oltre alla visita diretta alle botteghe, sono i numerosi mercatini dell'antiquariato, diffusi uniformemente in ogni provincia della regione e in ogni periodo dell'anno.
Con l'invito a non mancare, tra fine Agosto e Settembre, l'appuntamento con la Mostra della Filigrana di Campo Ligure, dove senza alcun senso di sudditanza gli artisti di oggi espongono i loro gioielli di fianco a rarissimi pezzi antichi.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente