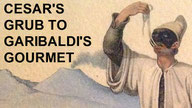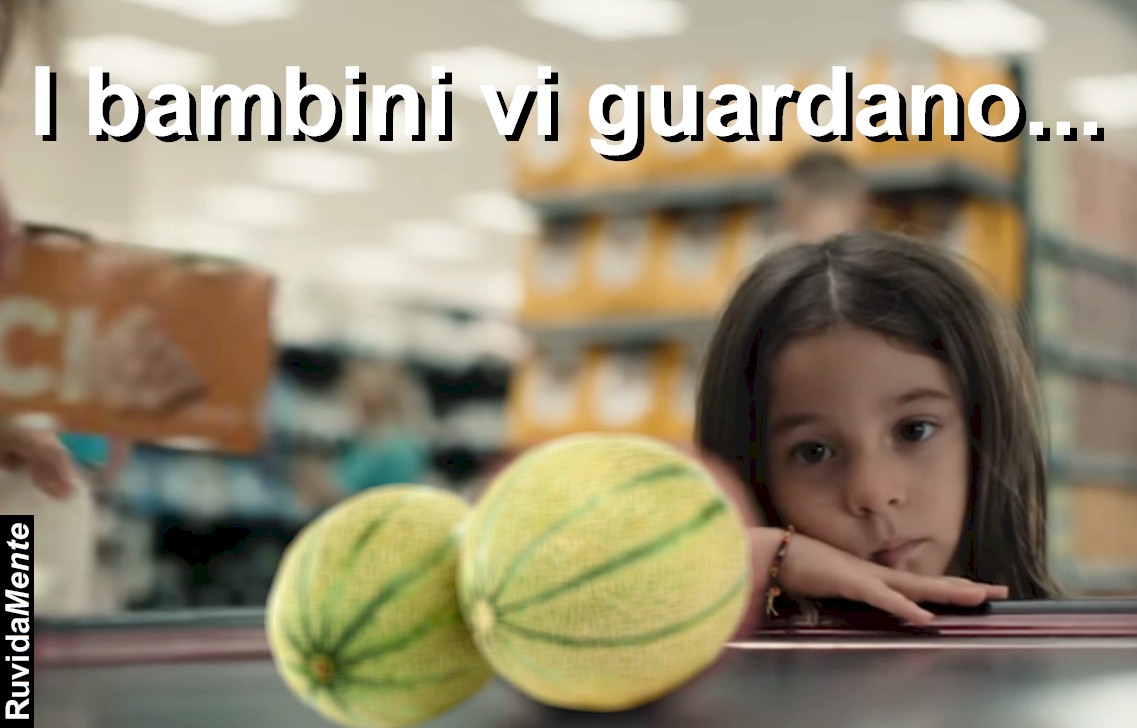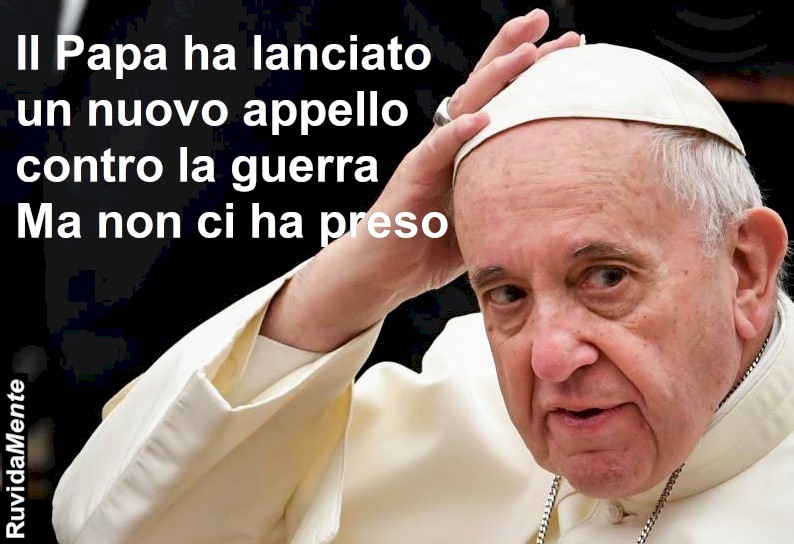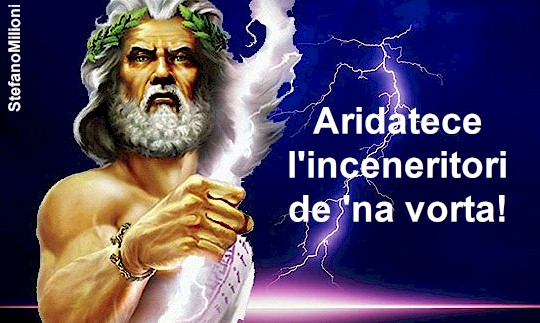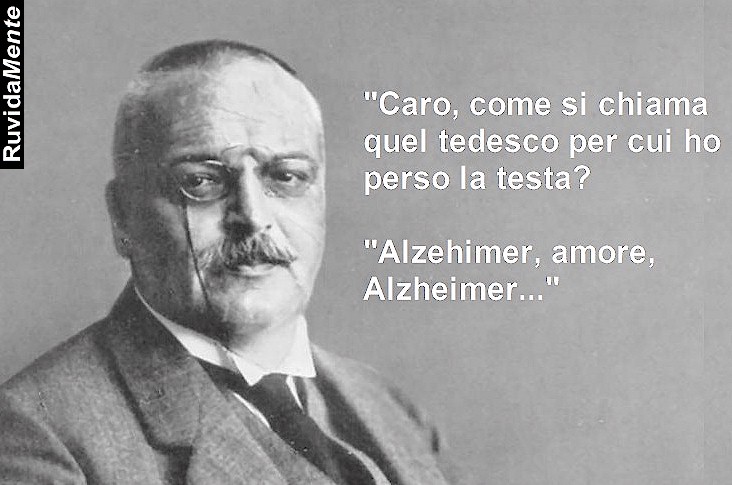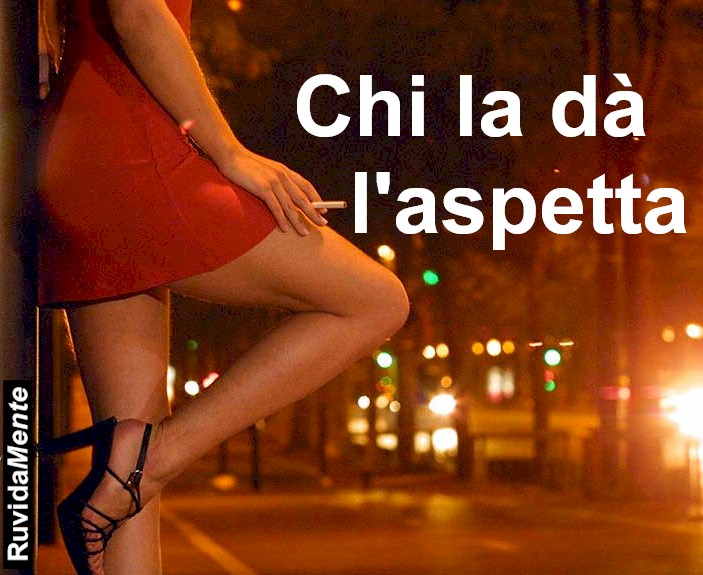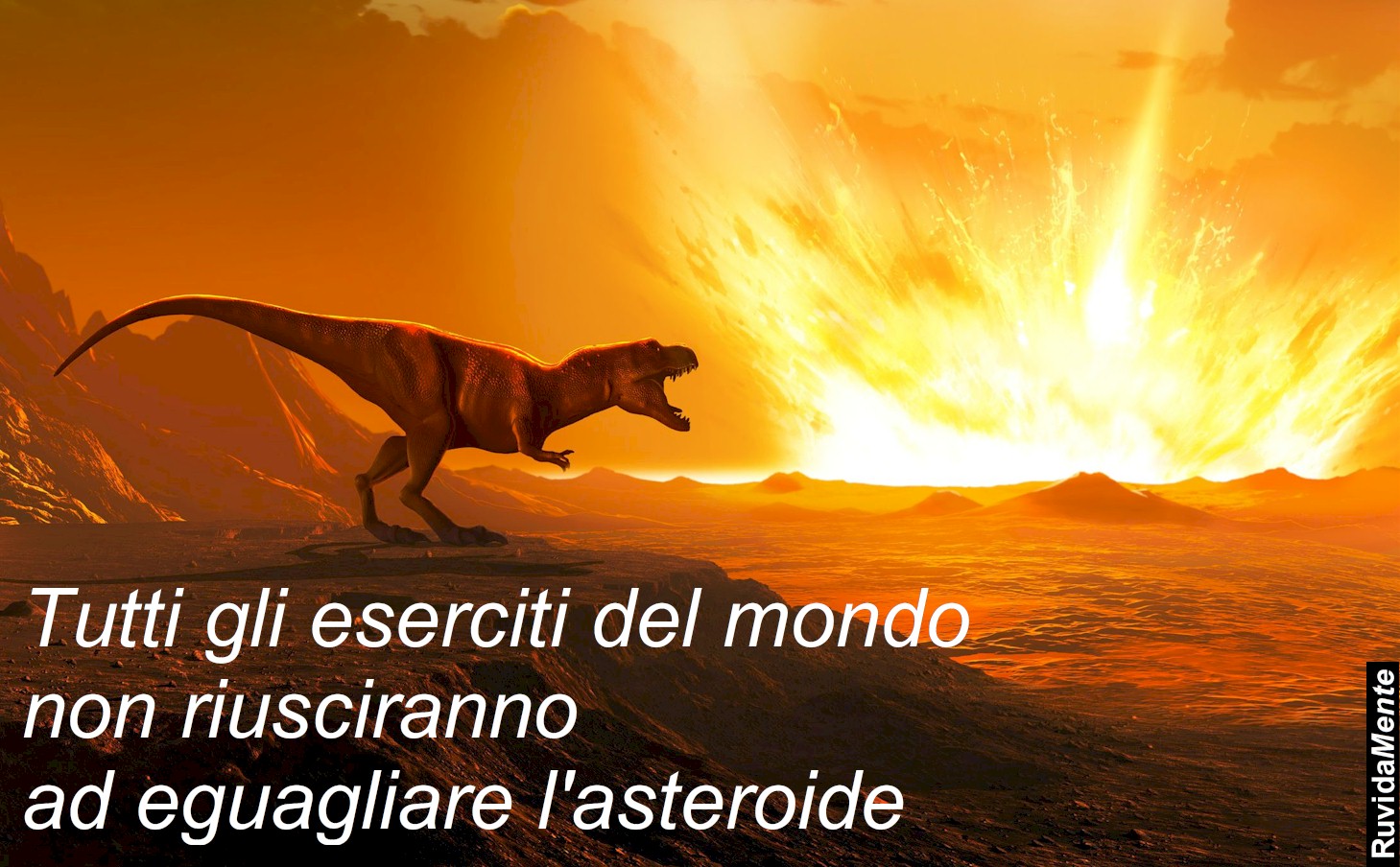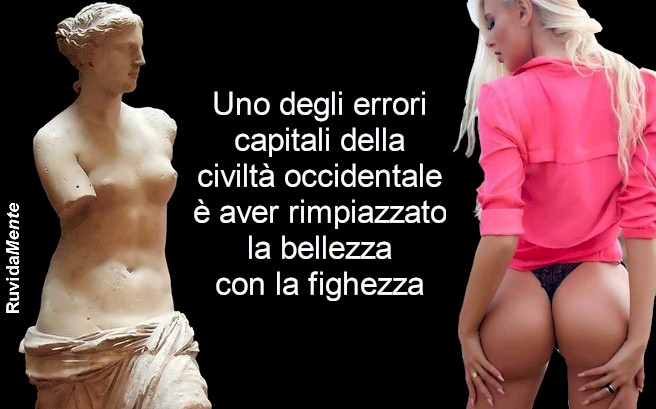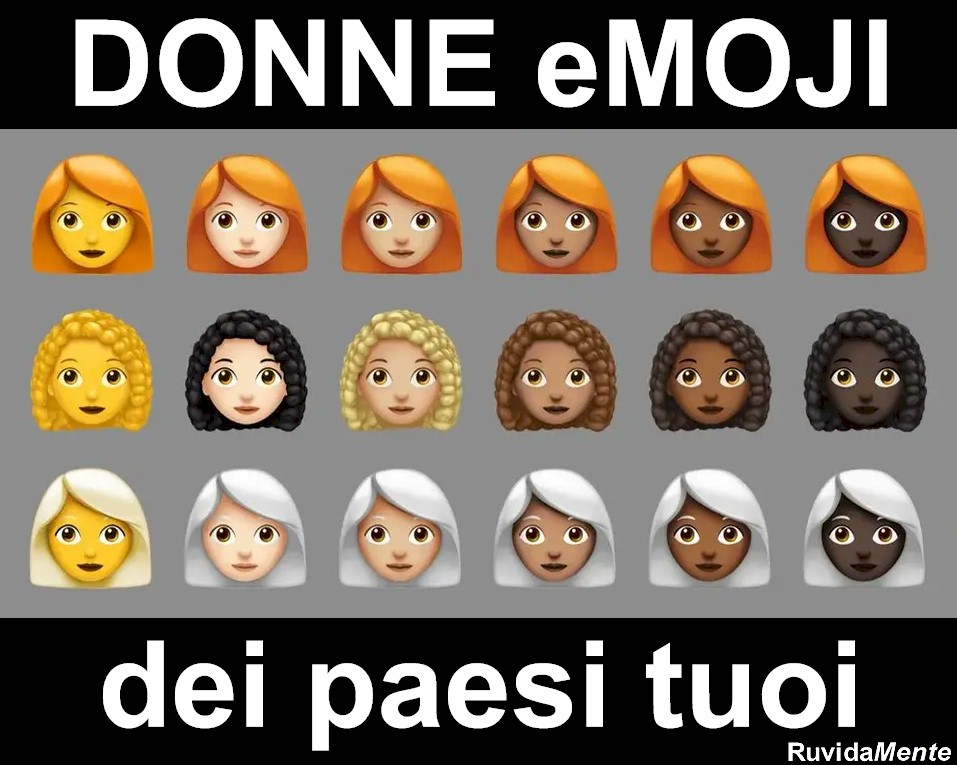Benché il Piemonte sia una delle regioni dove per
primo, e più profondamente, si è sviluppato il processo di industrializzazione del nostro paese, trascinando anche le comunità più isolate e lontane dai centri industriali in un colossale
processo di rinnovamento, l'anima contadina delle sue popolazioni resiste e sopravvive con vigoria tale che questa regione rimane un esempio di come, caparbiamente, si possano traghettare
tradizioni, modi di vita e mestieri attraverso due epoche, a loro modo antitetiche.
Non stupisce, quindi, che le antiche attività artigianali piemontesi, pur nella loro molteplicità di matrici, culturali, etniche e
confessionali, resistano e, spesso, prosperino, a dispetto di un contesto sociale che sembrerebbe votato ad una irreversibile corsa verso il futuro.
IL TERRITORIO
Piemonte. Già l'etimologia del suo nome definisce la natura montuosa di questa
terra a ridosso dell'arco alpino, le cui vette delimitano in maniera netta i confini con la Svizzera, la Francia, la Liguria e la Valle d'Aosta. Solamente ad est si apre verso la Pianura Padana,
confinando con la Lombardia ed un lembo dell'Emilia.
Il predominio delle forme di alta e media montagna è una delle caratteristiche principali della regione. Solamente il 27% dell'intera superficie è pianeggiante, mentre
la fascia collinare si estende per circa il 30% del territorio; il restante 43% è montagna.
La cerchia delle Alpi Piemontesi è smembrata longitudinalmente da profonde incisioni vallive che mancano di quella fascia prealpina calcarea che avvolge, ad esempio, le
Alpi Lombarde, creando un'area di transizione tra la pianura e l'asse cristallino interno del sistema alpino. Ciò accentua la già notevole dissimmetria tra il versante interno ed esterno delle
Alpi Piemontesi. Le Alpi Occidentali sono costituite essenzialmente da terreni cristallini, mentre le Orientali abbondano di terreni calcarei e dolomie.
Le colline, dal punto di vista genetico, geologico e petrografico appartengono al sistema appenninico e si differenziano assai dai terreni circostanti. Queste colline
costituiscono una vera e propria catena di corrugamenti in piccolo, costituita da terreni terziari nei quali, a profondi nuclei calcarei si sovrappongono potenti assise di marne, sabbie e
conglomerati.
A sud di questo sistema collinoso, delimitato nettamente a settentrione dal corso del Po, si estendono i terreni quaternari dell'Astigiano e del Monferrato, anch'essi
modellati a colline, non per sollevamento del suolo, ma per un profondo e costante lavoro di erosione delle acque correnti. In questi terreni scorre il fiume Tanaro ed alla valle formata dal suo
corso fa seguito il vasto rilievo collinoso delle Langhe.
Il territorio del Monferrato e delle Langhe è l'unico tratto del versante appenninico rivolto verso la Pianura Padana in cui i solchi vallivi non abbiano direzione
trasversale e raggiungano una certa lunghezza.
Ai piedi delle terrazze che costituiscono l'alta pianura, il continuo afflusso di materiali di natura alluvionale ha determinato, nel corso dei secoli, il formarsi di
un bassopiano nel quale le acque, infiltratesi attraverso i depositi alluvionali, si raccolgono sugli strati argillosi compatti. L'abbondanza di queste acque fa sì che il bassopiano padano si
presti assai bene alla coltivazione dei cereali ed alla coltura pratense.
LA STORIA
Nell'antichità, il territorio attuale del Piemonte era abitato per metà dai Liguri e per metà dai Galli Cisalpini. Fra i due popoli avvennero anche mescolanze: i
Salassi in Valle d'Aosta ed i Taurini del territorio intorno a Torino avevano caratteristiche razziali miste.
Dopo la seconda Guerra Punica sia i Liguri che i Galli Cisalpini furono sottomessi dalle armate romane. Tuttavia, la regione entrò nell'orbita di Roma molto tardi,
all'inizio dell'Impero. Nell'alto Medioevo il Piemonte, che ancora non si chiamava in questo modo, fu occupato dai Longobardi e successivamente dai Franchi; il territorio venne frazionato in
ducati, marchesati e contee. Nel secolo X ebbe grande importanza la marca di Ivrea, che in seguito si frazionò nelle marche di Ivrea e Torino, passate poi in possesso dei Savoia. Accanto ai
liberi Comuni delle città, nel XII secolo, si affermarono i potenti marchesati di Saluzzo e del Monferrato.
Dal secolo XV la storia del Piemonte andò via via identificandosi sempre più con quella del ducato dei Savoia. Coinvolto nelle guerre di potere fra Spagna e Francia, il
loro ducato si risollevò con Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele (1553-1630). Il Monferrato entrò a far parte dello Stato Sabaudo nel 1714, che già nel 1743 poteva comprendere nel suo ambito
tutta la regione.
Dopo il periodo napoleonico, nel quale la regione divenne parte del Regno di Francia, il Piemonte divenne il centro ed il fulcro dei moti carbonari e delle insurrezioni
popolari che avrebbero condotto, nel 1861, all'Unità d'Italia.
L'AGRICOLTURA
L'agricoltura occupa un posto di primo piano nell'economia del Piemonte: il frumento è il cereale più coltivato, e le colture sono equamente divise tra pianura e
collina. Segue il granturco, che viene prodotto in tutte le province piemontesi, ed il riso, la cui coltivazione dà una caratteristica fisionomia alle pianure del vercellese e del novarese. Tra i
cereali minori troviamo la segala, prodotta nelle zone di montagna delle province di Cuneo e Torino, mentre tra le colture industriali ha particolare importanza la barbabietola da zucchero,
seguita dal lino, la saggina da scopa, l'arachide, il ravizzone e la menta piperita.
Sono molto estese le coltivazioni di ortaggi in pieno campo, soprattutto per la produzione delle patate precoci, dei pomodori, degli asparagi, dei piselli, dei cardi e
dei peperoni. Un cenno particolare merita il celebrato tartufo, la cui raccolta è concentrata nei territori di Alba e di Asti.
Nella produzione di frutta fresca, il Piemonte occupa un posto preminente fra le altre regioni italiane: pesche, mele, susine, pere e fragole vengono prodotte ovunque,
soprattutto nelle zone di alta pianura e di bassa montagna.
La viticoltura è favorita dalla presenza di vaste aree collinose. La quasi totalità della produzione di uva in Piemonte viene vinificata.
L'ARTIGIANATO TIPICO
L'artigianato tipico della Valle d'Aosta affonda le sue radici nella civiltà contadina delle Alpi. Il tradizionale stile di vita dei montanari implicava per ciascuno di
essere al tempo stesso agricoltore ed allevatore, al fine di sfruttare al meglio le risorse limitate di un territorio avaro, e di diventare in caso di necessità anche artigiano, dato che i
mercati cittadini erano distanti e i prezzi alti in rapporto alle limitate disponibilità finanziarie. Da qui la necessità di produrre direttamente a casa propria, per quanto possibile, gli
attrezzi necessari per il lavoro dei campi e l'uso domestico.
Innumerevoli generazioni di contadini-artigiani hanno così elaborato, attraverso i secoli, molteplici tecniche per sfruttare in modo ottimale alcuni prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento - la canapa, la lana e il cuoio - e per utilizzare al meglio materie prime come il legno e la pietra che la natura offriva in quantità abbondante. Senza
dimenticare inoltre che un importante attività mineraria forniva ai fabbri della regione ferro e rame di eccellente qualità.
L'artigianato valdostano, fiorente per secoli, conobbe una grave crisi nell'Ottocento per l'introduzione nella regione, fino allora caratterizzata da una economia in
gran parte di tipo autarchico, di prodotti industriali a prezzi concorrenziali. Questo, però, non ha fortunatamente portato alla completa sparizione dell'artigianato locale: essendo gli utensili
di prima necessità oramai importati e l'agricoltura meccanizzata, tutti coloro che avevano acquisito competenze e raffinate capacità tecniche, in questi ultimi decenni hanno saputo riconvertirsi
dedicandosi a forme di artigianato d'arte le cui creazioni non cessano di diversificarsi e di raffinarsi.
I METALLI
Nelle valli piemontesi, la lavorazione degli oggetti di rame era funzionale alla vita quotidiana e diffusa uniformemente in tutto il territorio, come testimoniano
numerosi passi degli statuti medioevali e, ancor prima, reperti archeologici risalenti addirittura al tempo dei Salassi.
Curiosamente, della crescita di competenze tecniche che si accompagnava al trasferimento di esperienze da una generazione all'altra, ha beneficiata per prima proprio
l'industria automobilistica che ha potuto trasformate ed assorbire in tempi brevi i bravi calderai in provetti carrozzieri, allontanandoli da un mercato che, grazie al diffondersi di vasellame di
produzione industriale, li avrebbe comunque indotti all'abbandono o al fallimento.
Questa naturale emigrazione dalle botteghe alla fabbrica, ha avuto l'effetto positivo di lasciare sufficienti spazi di mercato ai pochi irriducibili, che hanno potuto
continuare la loro tradizionale attività, soprattutto nelle zone di Courgné, Pont Canavese e Alpette, in provincia di Torino, dove, caso probabilmente unico, è tuttora in attività una scuola per
ramai.
Nella Valle Strona, in provincia di Novara, a partire dal XVII secolo si è sviluppata un'attività affine, ma concentrata sull'utilizzo del peltro come materia prima. La
qualità di queste lavorazioni era tale che diede vita ad un vero e proprio movimento migratorio di questi artigiani verso l'Europa Centrale, richiestissimi soprattutto nell'area di cultura
tedesca.
Il ferro battuto, invece, richiedendo un inferiore livello di specializzazione, era praticato più diffusamente e la sua tradizione ha iniziato un lento processo di
eutanasia, fino a scomparire totalmente in alcune zone, con l'eccezione di solitarie officine che compaiono all'improvviso qua e là, e fatta eccezione per alcuni centri della provincia di Cuneo e
il territorio di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove si osserva tuttora un fervore di attività accompagnato da un elevato livello qualitativo delle lavorazioni.
Come estensione della lavorazione del ferro battuto, sempre in provincia di Cuneo, a Vernante, si perpetua la produzione artigianale di coltelli a serramanico di forme
diverse, interamente lavorati a mano, con un tipico manico in corno, noti con il nome di "vernantini". Diffusi in tutto il Piemonte ed in Liguria fin dal primo '800, questi coltelli erano usato
per tutti i lavori agricoli e domestici e, grazie alla particolare affilatura, anche per intagliare il legno.
L'OREFICERIA
Forse grazie alla lunga contiguità con una corte reale e alla nobiltà che la circondava, la lavorazione artistica dei metalli preziosi ha trovato sempre florido mercato
in Piemonte, sviluppandosi soprattutto in provincia di Vercelli e di Alessandria, che vanta punzoni risalenti alla fine del Cinquecento.
Oggi, però, il polo dell'oreficeria piemontese si concentra a Valenza Po, in provincia di Alessandria, nonostante la tradizione sia relativamente recente, con origini
databili solo agli inizi dell'Ottocento.
Qui, nonostante la crescita forte e continua, la produzione è tuttora esclusivamente artigianale, diffusa su un universo di oltre 1300 laboratori, tutti talmente concentrati sulla componente tecnica ed artistica del loro lavoro (alla capacità di trattare i metalli preziosi si è aggiunta, col tempo, una notevole acquisizione di competenze nel trattamento delle pietre preziose) che ben pochi si occupano direttamente della parte commerciale, delegandola prevalentemente a ditte esterne specializzate.
LA PIETRA
Chiunque si sofferma ad ammirare l'impennarsi al cielo delle guglie del Duomo di Milano, così ricche di ornamenti e sculture, difficilmente sospetterebbe che tanta magnificenza ha una precisa matrice geografica piemontese, concentrata nel distretto marmifero della provincia di Novara, dalle cui cave si estraggono da secoli il granito rosa di Baveno, la pietra verde di Mergozzo e il marmo di Candoglia.
Questa preziosa risorsa ha contribuito allo svilupparsi di una secolare scuola di artigiani e di scultori, localizzata soprattutto a Baveno, Gravellona Toce, Mergozzo e Ornavasso, che si perpetua anche ai giorni nostri, sebbene diversificata in più ampia gamma di produzioni, che spaziano dalle più classiche realizzazioni artistiche agli oggetti decorativi per la casa e per il giardino.
IL LEGNO
La lavorazione del legno è sempre stata un'attività tipica delle popolazioni di montagna, praticata soprattutto durante i mesi invernali, approfittando di una materia
prima abbondante per convertire in operosità un ozio forzato. Si spaziava dalle suppellettili domestiche agli attrezzi per i lavori della campagna, della cantina e della stalla, fino ad oggetti
di ispirazione artistica e religosa: gli ambulanti passavano a raccoglierli e scendevano a valle per venderli nei mercatini di paese.
Benché votate all'estinzione, simili attività sopravvivono ancora in Valsesia, in Valle Strona e nelle valli di Viù, dove si producono sia oggetti legati alle attività
agricole e casalinghe, sia oggetti decorativi.
In alcune aree, come la Valsesia, la Val Varaita ed il territorio di Pinerolo, grazie anche alla vicinanza di mercati più ricchi, queste forme artigianali si sono evolute verso la produzione di
mobili rustici, in legno naturale, con ornamenti intagliati di carattere tradizionale.
Il salto di qualità, verso la produzione di mobili in stile antico e in legni pregiati, invece, lo hanno operato gli artigiani della zona di Saluzzo, in provincia di
Cuneo, che, ispirandosi alla tradizione degli ebanisti piemontesi del Seicento e Settecento, affiancata da uno studio attento dei modelli e dall'uso di tecniche esclusivamente manuali, riescono
ad ottenere prodotti di grande valore.
GLI STRUMENTI MUSICALI
In una regione dove le tradizioni popolari e religiose sono sempre state profondamente radicate nel vissuto quotidiano delle popolazioni, è naturale che si siano sviluppati molti centri di produzione artigianale di strumenti musicali. Tanti hanno conosciuto un lento declino.
Altri, invece, hanno acquisito un livello di specializzazione tale che li ha preservati da una sicura estinzione. È il caso di Centallo e Piasco, in provincia di Cuneo, dove ancora prospera la fabbricazione, rispettivamente, di organi e arpe.
Oppure Leinì, in provincia di Torino, dove tuttora si producono rinomate fisarmoniche, e Quarna, in provincia di Novara, che si distingue per gli strumenti a fiato in legno e in metallo. Botteghe di liutai che lavorano con metodi tradizionali si trovano inoltre in provincia di Alessandria, a Rosignano Monferrato e a Solero.
LA CERAMICA

La palma di epicentro dell'artigianato piemontese della ceramica spetta sicuramente alla cittadina di Castellamonte, nel Canavese, dove la tradizione si perpetua da tempo immemorabile. Qui, per secoli, sono stati prodotti incessantemente oggetti umili ed indispensabili alla vita quotidiana quali scodelle, piatti, orci, pignatte e stoviglie; al punto che i suoi abitanti venivano chiamati in tutto il Piemonte con l'appellativo bonario ed ironico di "pignater".
È una tradizione, questa, che vede gli albori nel buio dei secoli e delle trasmissioni orali di memorie, ma è sicuramente dal periodo degli antichi Salassi che si hanno
cenni reali dell'attività ceramica locale; e numerose sono le anfore, pàtere, lacrimatoi e lucerne ritrovate in zona e risalenti al periodo Romano. Benché ancora oggi si producano soprattutto
stoviglie di uso domestico, tra le quali si distinguono le caratteristiche pignatte panciute con piccoli manici, di un bel colore rosso chiaro, l'odierna notorietà è dovuta alle grandi stufe in
ceramica smaltata, eccellenti manufatti di antica tradizione che, da qui, vengono esportati in tutto il mondo.
Le antiche produzioni ceramiche si perpetuano anche nella zona di Mondovì, soprattutto a Villanova e Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo, caratterizzate soprattutto da
stoviglie da tavola e ornamentali, in particolare statuette di soggetto religioso e piastrelle decorative, cui recentemente si sono aggiunti piatti dipinti a mano raffiguranti scene di campagna o
animali.
Per chi, invece, è alla ricerca di raffinati componenti di edilizia rustica, merita una segnalazione Vinovo, in provincia di Torino, dove ancora si producono mattoni fatti a mano ed elementi architettonici in terracotta, ricavati da antichi stampi in legno tuttora in uso, in un numero incredibile di forme.
LA TESSITURA E IL RICAMO
Il grande sviluppo dell'industria tessile in Piemonte è la naturale evoluzione dell'intensa attività artigianale sviluppatasi in molti distretti fin dall'Ottocento. Non tutti i centri di produzione, però, hanno subito lo stesso destino e, a macchia di leopardo, sono sopravvissute alcune oasi di lavorazione manuale tradizionale.
A Caraglio, in provincia di Cuneo, si producono tuttora raffinati e preziosi damaschi e broccati, mentre a Pella, sul lago d'Orta, in provincia di Novara, è ancora
attiva la lavorazione della canapa su telai a mano. In provincia di Vercelli, invece, si mantiene viva la raffinata arte del "puncetto", un pizzo in cotone formato da piccoli nodi scorsoi
collegati da una fitta rete. Un tempo, questo elemento faceva parte del costume femminile tradizionale della zona ed oggi è utilizzato per bordure, centrini e preziose decorazioni.
Curiosamente, però, la forma di artigianato tessile più preziosa, ha radici recenti, quando, nel dopoguerra, ad Asti hanno cominciato ad operare le prime arazzerie che
sono riuscite a piegare mirabilmente le tecniche più genuine di un'arte che ha raggiunto nel Medioevo le sue più alte espressioni, con le esigenze espressive dei più raffinati artisti moderni.

LA GASTRONOMIA
Il Piemonte non ha espresso nessuno dei "grandi" formaggi italiani, anche se due mostri sacri come il Grana Padano ed il Gorgonzola vengono ampiamente prodotti entro i suoi confini. Questo, però, è dovuto non ad una scarsa vocazione casearia, bensì ad una grande ed atavica tradizione che ha permesso ad ogni valle e alpeggio di sviluppare proprie piccole produzioni, ben differenziate per tecniche, sapori e nomi.
Quella dei formaggi tipici piemontesi è una galassia che, proprio nel momento in cui l'evoluzione del mercato sembrava decretarne la
sparizione, ha sputo affascinare i consumatori più attenti, instaurando con loro un rapporto diretto che l'ha messa al riparo da reali pericoli di estinzione.
In questo panorama, alcuni formaggi si sono imposti prima di altri, varcando i confini della regione e, talvolta, viaggiando verso le tavole dei più raffinati ristoranti del mondo, È il caso del
Raschera, del Murazzano e del Castelmagno, tutti prodotti in provincia di Cuneo ed insigniti della Denominazione di Origine fin dal 1982.
Sull'onda del loro successo, hanno ritrovato vigore le produzioni di tanti piccoli capolavori, quali il Bettelmatt, prodotto nelle altitudini dell'Alpe Bettelmatt e
delle Alpi di Formazza, in provincia di Novara, il Frachet della Valsesia e il Murianego, proveniente dagli alpeggi del Moncenisio.
Nonostante tutte le zone possano vantare formaggi di grande tipicità (basti pensare al Sargnon nel Biellese, al Seirass del Lausun nel Pinerolese, allo Spress nella Val
d'Ossola e Val Vigezzo, a allo Zufi nelle aree di cultura Walser, in provincia di Novara e al Tomino del Bec di Acqui Terme), al territorio cuneese va sicuramente assegnata la palma per la
maggiore vivacità, che si esprime in una intensa attività di promozione, culturale prima ancora che commerciale (le produzioni, d'altra parte, sono quantitativamente limitatissime), cui va
ascritto il merito di aver fatto scoprire ai consumatori tesori quali l'Acceglio, prodotto nel comune omonimo, il Valcasotto, tipico dell'alta Valle Tanaro, il Testun di Boves e del Monregalese e
la rarissima Tuma d'la Mura.

IL CASTELMAGNO
Il Castelmagno è forse il più prezioso dei formaggi delle Langhe e prende il nome da uno dei tre comuni in cui, seguendo le rigide regole della Doc ottenuta nel 1982,
può essere prodotto e stagionato (gli altri sono Pradleves e Monterosso Grana).
Fa parte del gruppo dei formaggi erborinati e per la sua produzione viene impiegato latte vaccino locale con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino. La sua lavorazione è complessa e, seguendo una procedura consolidata da secoli, si protrae per 7-9 giorni, quando inizia il periodo di maturazione (da 2 a 5 mesi) in grotte naturali.
Quando la crosta raggiunge un colore che varia dal giallo-rossastro al rosato intenso, il Castelmagno è pronto per gustarne il sapore che, con il procedere della maturazione, spazia dal delicato all'intenso, al piccante.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Con largo anticipo rispetto alle altre regioni italiane, in Piemonte si è sviluppato un turismo di breve raggio che ha portato gli abitanti delle metropoli padane a sciamare, nei fine settimana, verso le campagne, risalendo le colline ammantate di vigneti e sostando nelle valli una volta attraversate di corsa per raggiungere le stazioni sciistiche.
Questo movimento è stato benefico per tutte quelle iniziative locali, mercati, sagre, fiere e manifestazioni che, diversamente, avrebbero finito per scomparire o trasformarsi, perdendo completamente le loro connotazioni tradizionali.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente