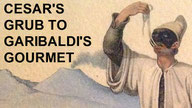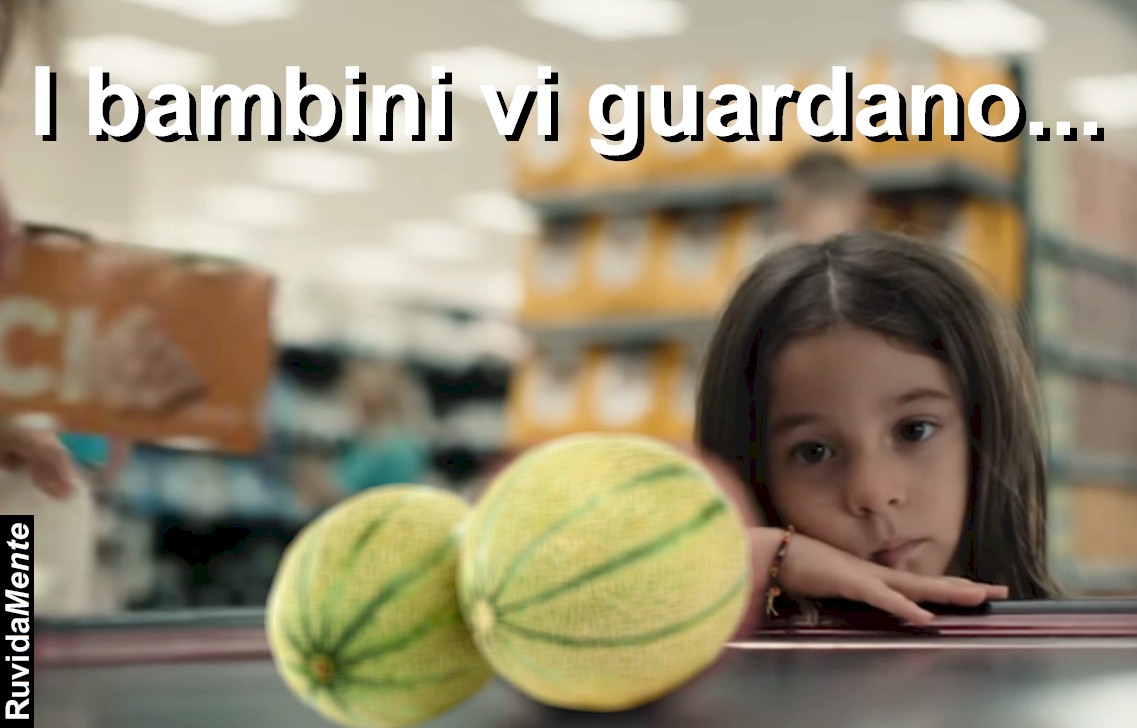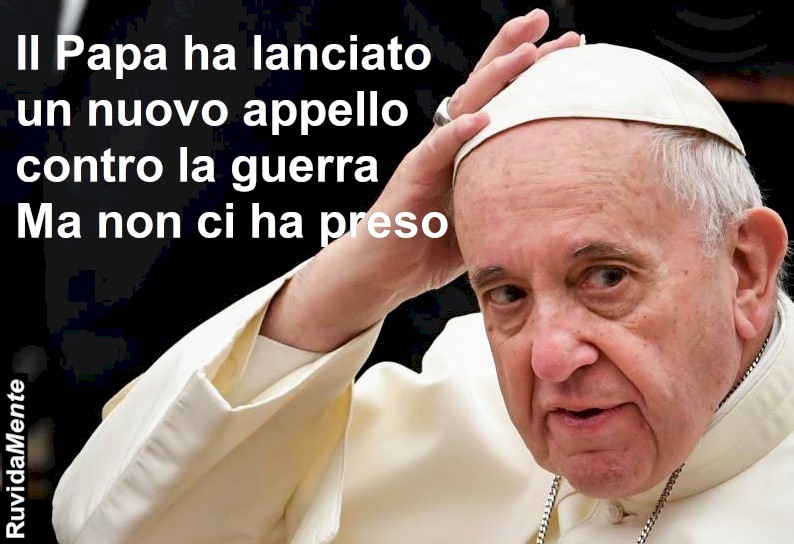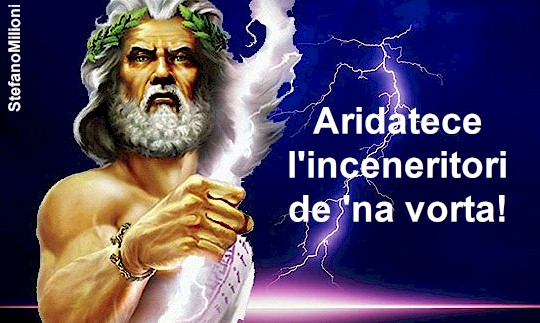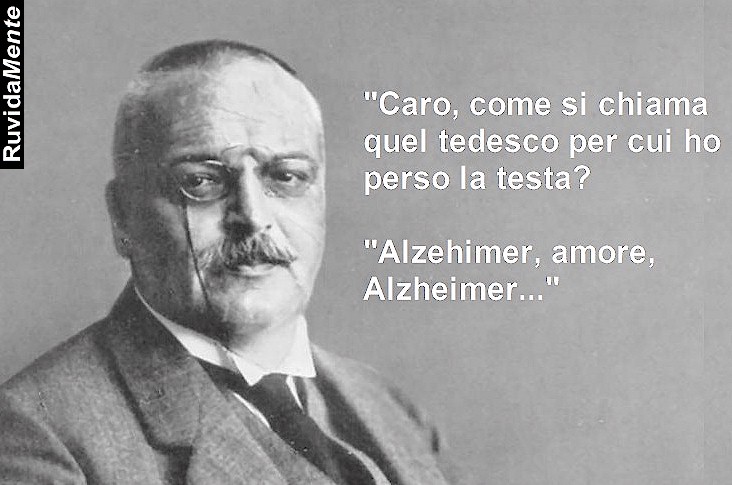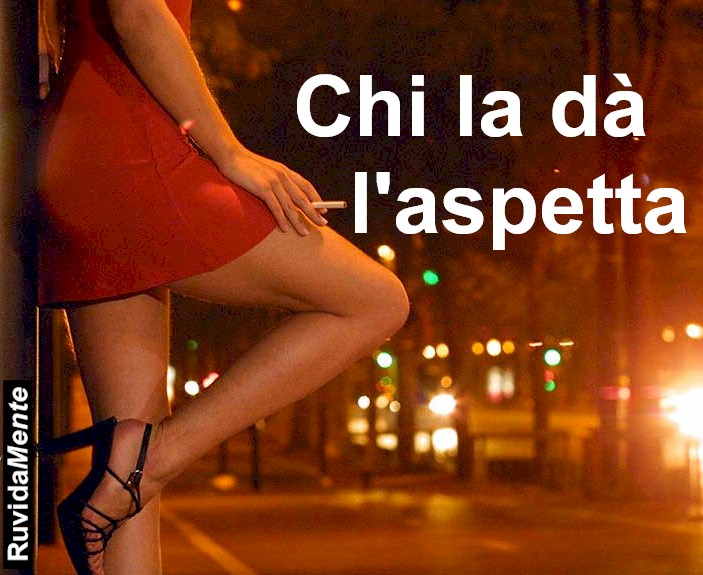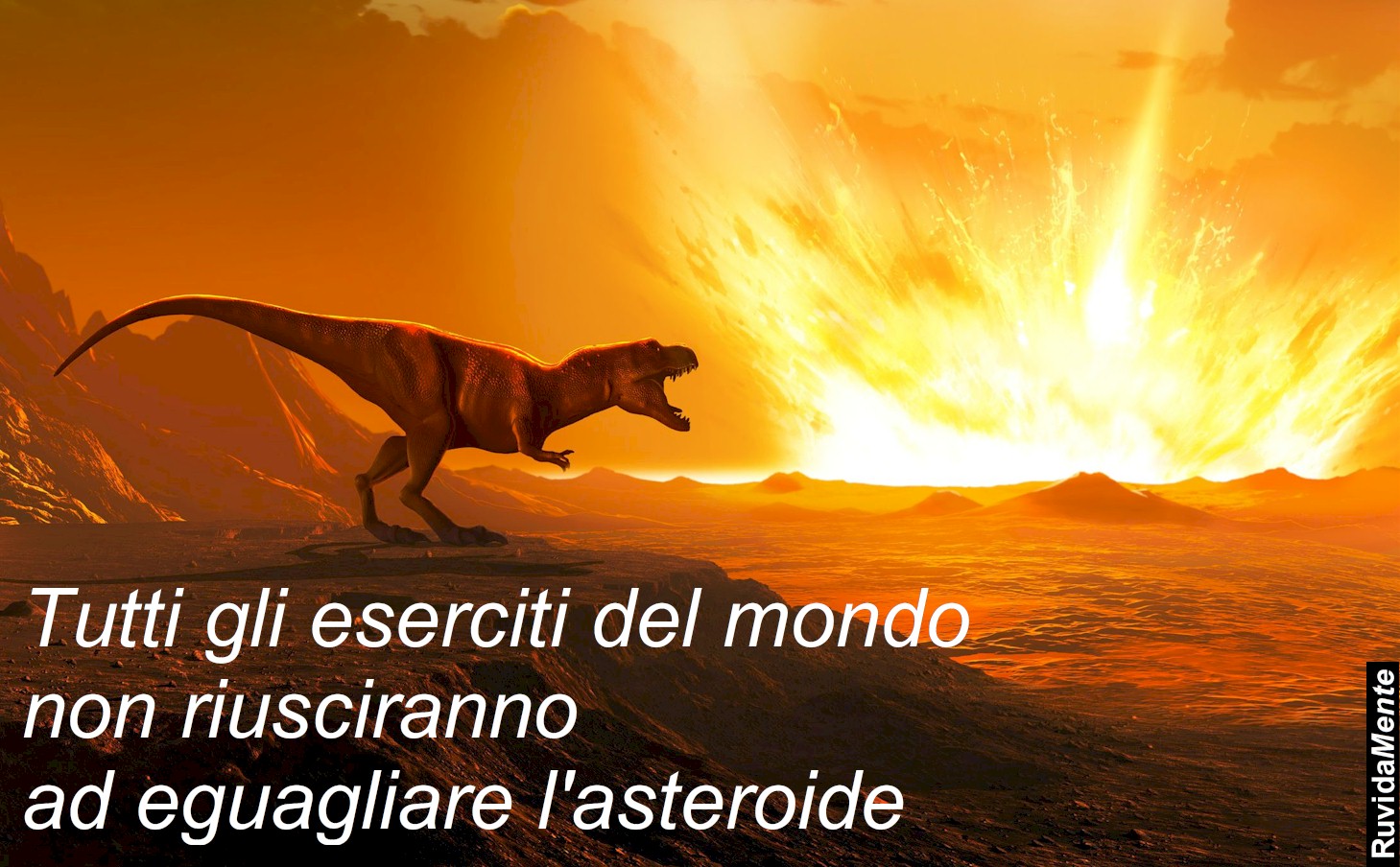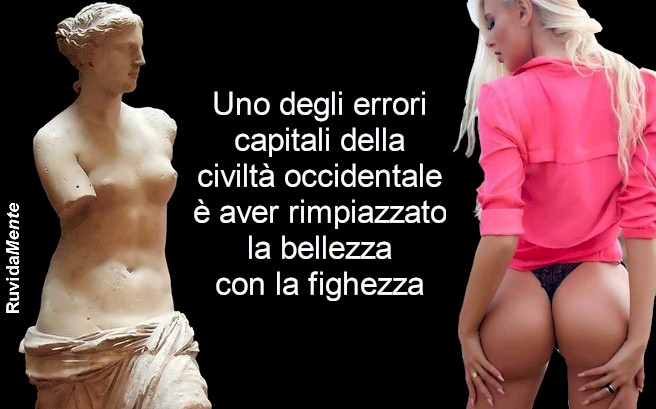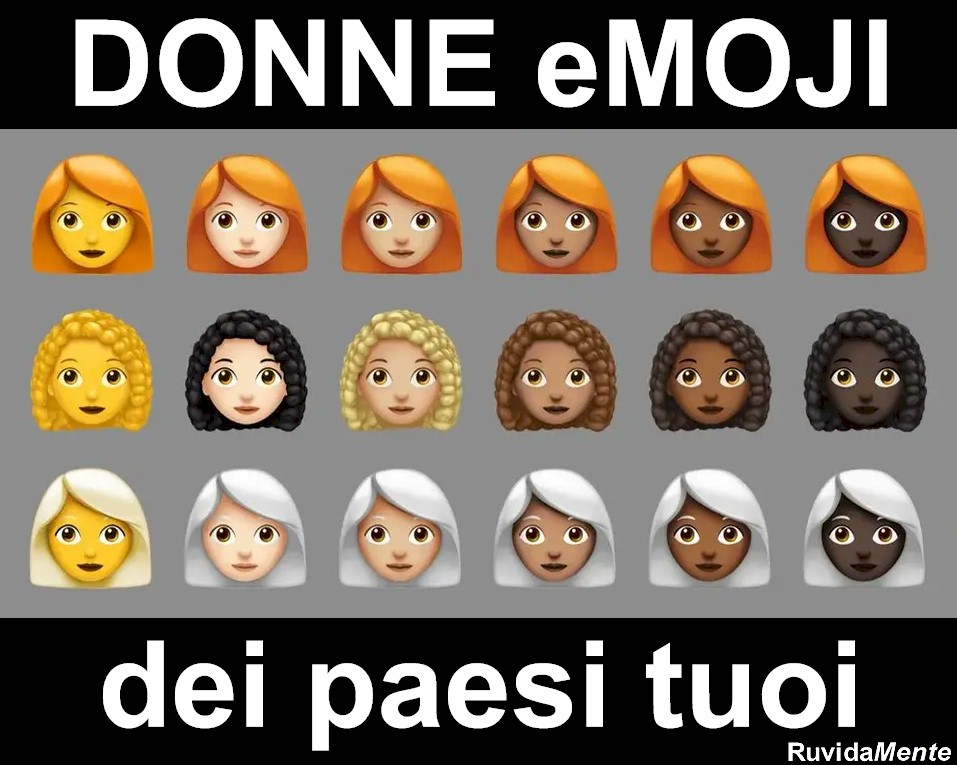Analizzando il panorama delle produzioni artigianali della Sardegna si potrebbe essere indotti a pensare che una delle condizioni più favorevoli al prosperare di queste attività sia l'isolamento.
Non c'è regione italiana, infatti, in cui le attività artigiane tradizionali siano più diffuse e meglio integrate nel contesto sociale, tuttora rispondenti a quei canoni tecnici ed estetici che le hanno contraddistinte fin dal loro apparire. Inoltre, salvo rarissime eccezioni, dalla ceramica all'intaglio del legno, all'oreficeria, alla tessitura, si tratta di attività nate ed evolutesi autonomamente nell'isola, senza influenze esterne determinanti, fatta salva l'acquisizione di alcuni canoni estetici, per lo più di matrice spagnola, che si possono riscontrare soprattutto nei manufatti in ferro battuto ed in alcuni gioielli tradizionali in filigrana.
La conferma definitiva di questa genesi autoctona viene dagli elementi decorativi che sembrano trasmigrare da un genere all'altro con le uniche varianti imposte dalla diversa tecnica di applicazione.
Ecco quindi che riscontriamo ovunque la presenza di motivi geometrici a spirale, a greca, a losanga e circolari, sicuramente originati dai primitivi oggetti intrecciati, oppure figure stilizzate di ispirazione naturalistica. Ed è straordinario come spesso i due generi riescano ad integrarsi nello stesso contesto decorativo, dando luogo a affetti stilistici che non possono essere ricondotti a nessun'altra matrice estetica esterna al modo sardo.
LA TESSITURA
La millenaria tradizione pastorale sarda ha determinato la nascita e l'evoluzione della tessitura, sviluppatasi in tutta l'isola come attività artigianale domestica i cui prodotti, caratterizzati da una essenzialità senza fronzoli e senza possibilità del superfluo, erano destinati alle necessità della famiglia e della campagna. Per questo, le tradizionali immagini rappresentate nei manufatti sono espressione di fantasie e leggende, di simboli e di miti che attingono la loro forza espressiva in un mondo misterioso di felicità e di solitudine.
Basta guardare gli arazzi e i tappeti popolati di danze, di fiori, di geometrie simmetriche, di cavalli e di daini, di voli di colombi, di festoni fantasiosi per
rendersi conto che il prodotto diventa arte, viva e vitale, ed esprime un mondo culturale, di autonomia, ma anche di isolamento, di soggezione, di fede religiosa, un patrimonio immenso che
costituisce una testimonianza fedele di un interminabile discorso poetico.
Nel Nuorese, il lavoro al telaio è praticato soprattutto a Dorgali e Sarule e si propone con tappeti a disegni geometrici o di ispirazione ambientale resi
particolarmente originali dalla tecnica della colorazione della lana, ottenuta, essenzialmente, con l'uso di sostanze vegetali e con procedimenti talvolta segreti, custoditi gelosamente
nell'ambito familiare o nella bottega.
Qui, come pure nella zona del Goceano (Nule, Benetutti e Bono, in provincia di Sassari) e in molte zone della Barbagia, si utilizza l'antico telaio verticale, meno diffuso di quello orizzontale, a pedali, tipico della altre zone dell'isola.
Tra le produzioni più significative, meritano una segnalazione, nella Sardegna settentrionale, i tappeti realizzati nella zona del Logudoro (a Ittiri, Villanova Monteleone, Ploaghe, Bonorva) e in Gallura (soprattutto ad Aggius e Calangianus), e le coperte di Pozzomaggiore.
Ma la produzione è vivace e florida in ogni zona dell'isola, dal Montiferru al Barigadu, alla Marmilla, al Sulcis-Iglesiente, al Sarcidano, dove si differenzia per particolari canini estetici e per tipologia di manufatti che spaziano dai tappeti alle coperte, agli arazzi.
GLI INTRECCIATI
Per le strade dei paesi che gravitano intorno agli stagni della provincia di Oristano è facile vedere ancora oggi le donne, sedute sulla soglia di casa e vestite nei variopinti costumi, dedite alla lavorazione di stuoie, cesti e canestri. Le prime testimonianze di questa tecnica, al tempo stesso semplice ma capace di offrire risultati di straordinaria complessità estetica, risalgono all'epoca nuragica e si sono sviluppate in maniera diversa a secondo della materia prima disponibile nelle varie parti territorio.
Ecco quindi che nelle zone paludose si utilizzavano i giunchi in fascine, strettamente legati fra loro, per costruire i "fassonis", imbarcazioni usate dai pescatori
degli stagni di Cabras e Santa Giusta e prodotti tuttora per le tradizionali "regate" che si svolgono nello stagno di Santa Giusta.
Nelle zone interne, invece, come la Planargia (in particolare a Flussio e Tinnura, nel territorio compreso tra i grossi centri di Macomer e Bosa), o la Barbagia
(soprattutto a Olzai e Ollolai, nel Nuorese) vengono impiegati gli arbusti di asfodelo, che qui vegeta spontaneamente e in abbondanza.
Ma l'inventiva popolare non si ferma qui: lungo le coste del Sassarese, a Castelsardo, Sennori e Sorso, viene utilizzata la palma nana, che cresce spontanea e dalla quale si ottiene una fibra molto resistente, particolarmente adatta per la realizzazione di contenitori funzionali alle necessità dell'uso agricolo e domestico.
IL LEGNO
Castagno e querce da sughero sono le piante dominanti nei panorami interni della Sardegna e da essere gli artigiani traggono la materia prima per la maggior parte delle loro realizzazioni. La produzione più significativa e diffusa, oltre agli utensili tradizionali e agli oggetti in sughero, spesso oggetto di ricerche estetiche molto innovative, è quella dei frontali finemente intagliati delle cassepanche, che sono l'unico vero mobile d'arredamento della casa sarda, per il resto molto semplice e costituita unicamente da elementi funzionali.
La produzione si articola essenzialmente in due soli modelli, un tipo basso e lungo, tipico del territorio lussurgese, ed uno più alto, caratteristico della Barbagia.
Uno dei centri in cui la produzione si è maggiormente diffusa è il Nuorese, in particolare a Tonara, Orani e Orosei, dove oltre alle cassapanche si realizzano arredi completi, anche su misura,
sedie impagliate, armadi ed elementi di arredo tutti in legno massello.
Di fianco all'artigianato di utilità, si colloca quello più strettamente funzionale alle antiche tradizioni che ha la sua massima espressione nelle maschere dei
"Mamuthones" e dei "Merdules" e quelle dei "Su Bundu", veri capolavori d'arte popolare realizzati da maestri intagliatori che operano a Macomer, Mamoiada, Ottana e Orani, nel Nuorese.
Questi manufatti, oltre ad avere una indubbia valenza artistica, costituiscono elementi importanti di cultura antropica in cui tecnica, materiali e canoni estetici si intrecciano in un unicum di grande fascino. Sono tutti realizzati in legno di pero, castagno o sughero e simboleggiano demoni e animali.
L'OREFICERIA
Spesso la nascita di una tecnica artigianale è strettamente connessa alla disponibilità della materia prima necessaria. Questo, in Sardegna, non è accaduto per l'oreficeria, nonostante le sue miniere di piombo aurifero siano state sfruttate da tempo immemorabile.
L'ipotesi più probabile è che nell'isola i primi manufatti in oro siano stati elaborati in epoca medioevale, anche se i più antichi gioielli esistenti risalgano al Settecento. Si direbbe, però, che questo lungo periodo di incubazione abbia avuto effetti positivi, visto la vivacità dimostrata da questo comparto negli ultimi secoli, evolutosi con caratteristiche tecniche e stilistiche molto personali.
Tra i gioielli più tipici dell'oreficeria sarda possiamo annoverare gli oggetti legati al culto e alle superstizioni, quali i rosari, “teche”, medaglie e crocifissi, e quelli funzionali all'abbigliamento, come il classico bottone, lavorato con fini decorazioni in filigrana e spesso arricchito con granati o pietre dure.
Un altro oggetto diffuso nell’artigianato orafo sardo è il “lasu”; un gioiello di chiara derivazione spagnola costituito da un pendente a forma di farfalla realizzato traforando la lamina d'oro e arricchendola con decorazioni a imperlato. La tradizione vuole che venga indossato allacciandolo al collo per mezzo di un nastro di velluto.
Chiude la panoramica dei gioielli più tradizionali la classica fede sarda, un souvenir irrinunciabile per chi visita la Sardegna, caratterizzata dalla originale
decorazione in filigrana granulata che orna la parte superiore.
La maggior concentrazione di orafi si risconta a Cagliari, Sassari e nel Nuorese, a Bosa, Oliena e, soprattutto, Dorgali.

LA BOTTARGA DI MUGGINE
Benché ai più la bottarga si sia rivelata solo negli ultimi anni, i gastronomi più raffinati l'apprezzavano da secoli, capitanati da Bartolomeo Scappi, cuoco personale di Papa Pio V, che nei suoi scritti si dilunga a disquisire della superiore qualità di quelle di muggine e di spigola.
Una delle migliori in assoluto è quella prodotta nei mesi di agosto e settembre dai pescatori dello stagno di Cabras, in provincia di Oristano, dove i muggini abbondano e le sacche ovariche possono essere lavorate nel momento stesso della pesca.
Dopo essere state estratte con cura, in modo tale che non si lacerino, esse vengono salate e fatte sgocciolare su un piano inclinato
, esercitando una leggera pressione in modo tale che perdano la maggior parte del loro liquido di vegetazione. Completata questa operazione, si fanno asciugare all'aria per qualche giorno e poi
lasciate maturare per 60-90 giorni in luogo asciutto e ventilato.
Al momento dell'acquisto, la bottarga di muggine deve presentarsi di colore uniforme tendente al bruno, senza macchie e screziature, soda e compatta al taglio, con la
membrana della sacca ovarica ben aderente alla massa essiccata delle uova.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
In quasi tutte le altre regioni italiane, l'artigianato è spesso il corollario di manifestazioni di altra natura o di celebrazioni popolari e religiose.
In Sardegna, invece, riesce ad essere l'elemento aggregante attorno al quale il popolo dei residenti e quello dei turisti hanno l'occasione di incontrarsi e vivere sereni momenti di socialità.
La serietà e la qualità di queste manifestazioni sono garantite dall'importante ruolo che l'artigianato tradizionale gioca all'interno di ogni piccola comunità e, al pari dell'incontro diretto con l'artigiano nella sua bottega, sono sicuramente le occasioni migliori per garantirsi ottimi acquisti.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente