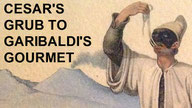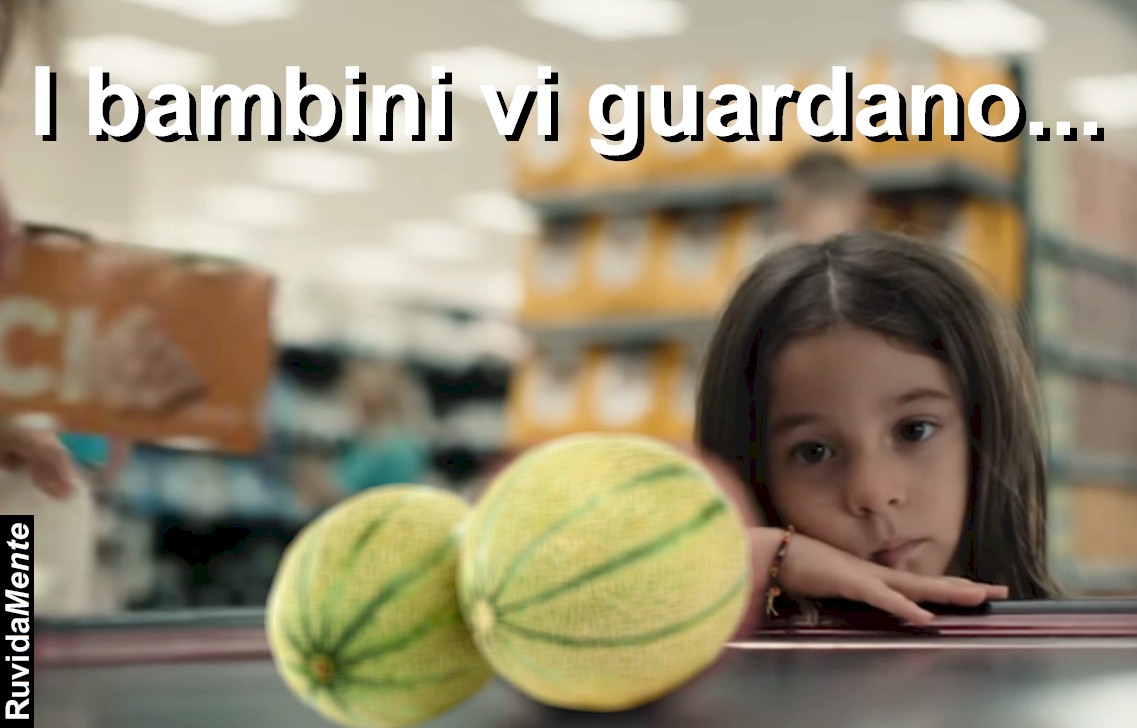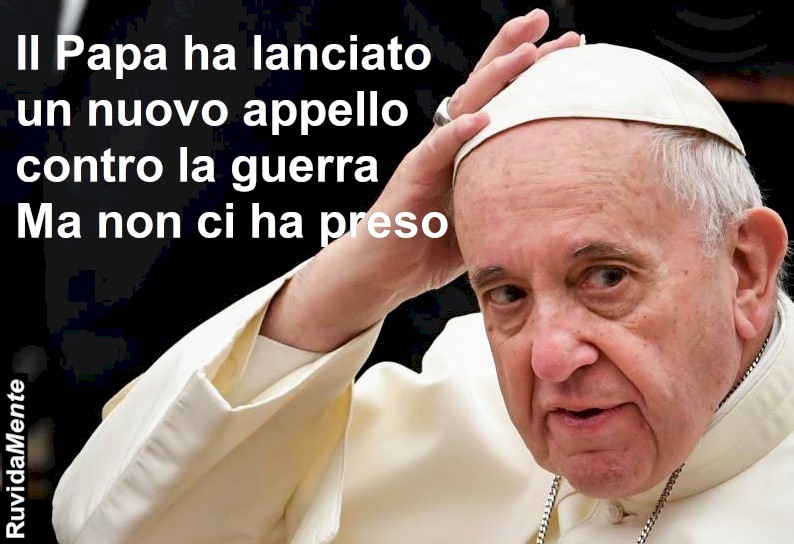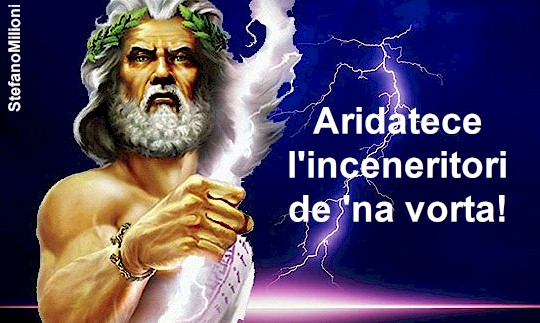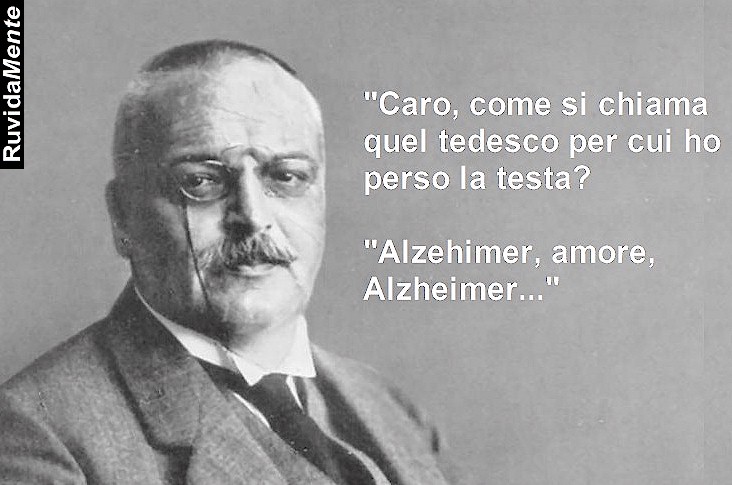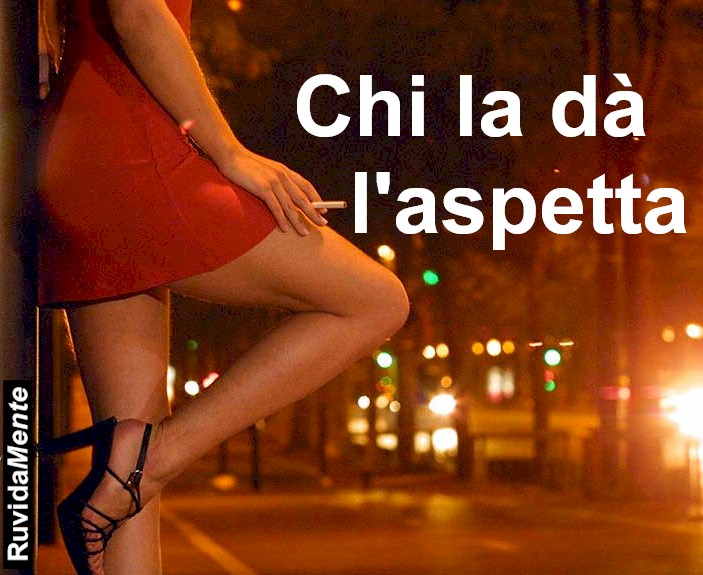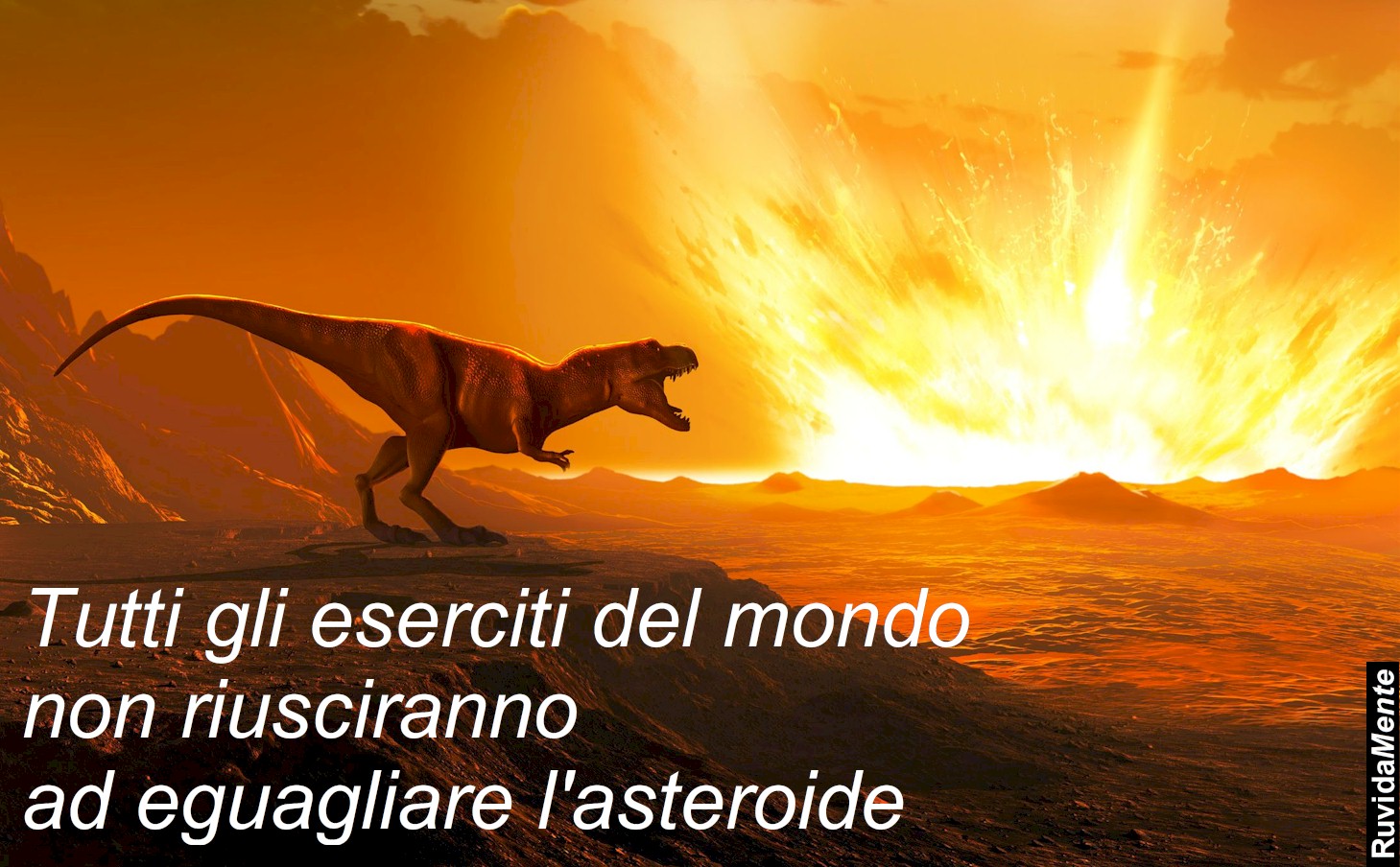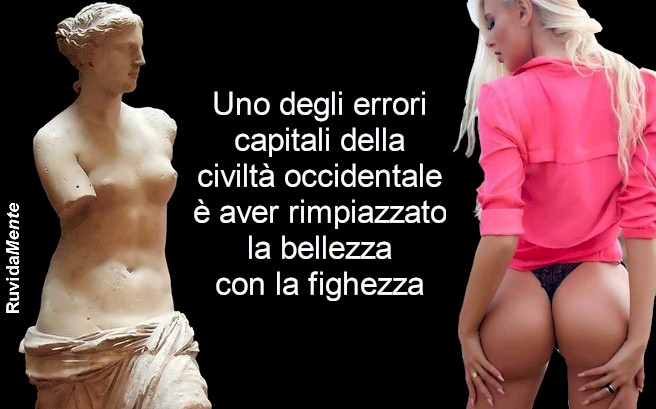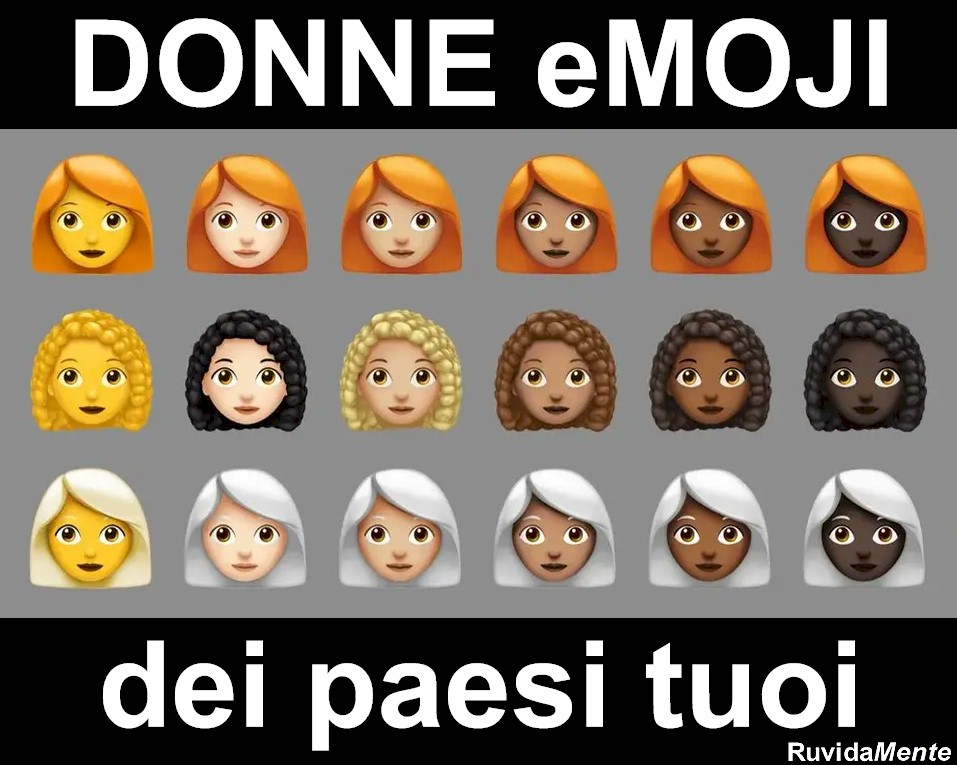La storia della Sicilia è un intreccio affascinante di eventi, civiltà e culture che ha segnato profondamente tanto il territorio quanto il carattere dei suoi abitanti. Lo stratificarsi delle influenze fenice, greche, romane, arabe, normanne, spagnole, spesso alternate a regressivi momenti di abbandono, ha prodotto effetti straordinari nell'arte e nell'architettura che si sono trasferiti come una dote sontuosa anche nelle forme più popolari dell'artigianato.
Per tutti, valga l'esempio dei carretti siciliani, un mezzo di trasporto che, nonostante la necessità di limitarne i costi, veniva arricchito di decori e addobbi di raffinatezza tale da trasformarlo in uno splendido esempio di artigianato artistico.
Se esiste un filo conduttore tra le varie attività artigianali siciliane, esso è sicuramente individuabile nella capacità di trasferire in qualunque manufatto, dal più umile al più prezioso, il ricco patrimonio di "sapere" accumulato nell'evolversi di una storia millenaria.
LA CERAMICA E LA TERRACOTTA

Gli eventi storici hanno fatto sì che non ci sia continuità tra gli splendori dell'arte ceramica della Magna Grecia e quella contemporanea. Dopo oltre un millennio di buio quasi totali, la produzione di rustiche terrecotte, prevalentemente contenitori per l'acqua, viene reintrodotta in alcune piccole comunità arabe, dislocate lungo le coste. Ma si deve arrivare al XVII secolo per vedere una comunità locale, peraltro costretta dagli eventi naturali, a rimettere in funzione quelle primordiali fornaci.
Questo accadde a Santo Stefano di Camastra, comunità di pastori insediatisi in riva al mare a seguito di movimenti franosi che avevano reso inabitabile il loro villaggio sulle alture. Più per necessità che per vocazione, cominciarono a realizzare dapprima mattoni evolvendo via via la produzione verso oggetti d'uso, quindi, dalla fine del '700, piastrelle maiolicate e ceramiche artistiche.
Anche la ceramica di Caltagirone ha una storia simile. Avviata dagli arabi che ne sfruttavano le cave di argilla, fu interrotta nel Trecento a causa di una enorme frana e ripresa nel Cinquecento nel nuovo rione dei “cannatari” (da “cannate”, recipienti per l’acqua), riscuotendo successi commerciali in tutta l'isola. La produzione spaziava di vasi agli orci ai lampadari, alle caratteristiche lampade antropomorfe, decorati con tocchi di giallo e verde nella decorazione a fogliame, oppure in monocromia turchina su fondo bianco.
Dopo le distruzioni del terremoto di Catania del 1693, la produzione riprese faticosamente tra alti e bassi finché, nel 1918, l'apertura di una scuola d'arte non
ridiede slancio alla produzione che continua oggi con grande vivacità.
Sciacca, in provincia di Agrigento, può essere considerato il terzo polo ceramico della Sicilia. Tutto cominciò tra il '400 e il '500, quando baroni e vescovi diedero
impulso all'attività di alcuni maestri maiolicari locali, con forti commesse di piastrelle decorate per abbellire chiese e palazzi (tra i quali, il duomo di Monreale). Fu l'occasione che permise
di affinare le tecniche e ricercare canoni estetici diversi da quelli di influenza saracena e catalana, aprendo al nuovo gusto rinascimentale italiano che caratterizza ancora oggi la produzione
di molti artigiani locali.
IL CORALLO
Diversamente da Torre del Greco, in Sicilia la lavorazione del corallo si è evoluta parallelamente alla pesca che offriva una materia prima dalle caratteristiche diverse a seconda delle zone. Per cui, ancora oggi, esperti e appassionati associano i coralli bianchi a Catania e Messina, quelli neri a Palermo, quelli rossi a Sciacca e Trapani.
La riserva marina più ricca era quella della costa trapanese ed era inevitabile che qui si sviluppasse un artigianato i cui splendori si protrassero dal Cinquecento
all'inizio dell'Ottocento, quando l'esaurimento dei banchi corallini costrinse la maggior parte degli artisti a trasferirsi altrove.
Oggi, a perpetuare l'antica tradizione, la cui massima espressione è la famosa “Montagna di Corallo”, una barocca composizione d’arte sacra con 85 figurine
scolpite, realizzata nel 1570 per il viceré Ferdinando d’Avalos d’Aquino, sono rimasti in pochi artigiani, per lo più concentrati nell'area trapanese, spesso associando all'attività di
lavorazione del corallo un vasto arco di tecniche orafe tradizionali.
I PUPI
In modo ancor più marcato di quanto accade per le figurine del presepe napoletano, i pupi siciliani sono il frutto di un lavoro corale che impegna tipologie diverse di artigiani, dai falegnami intagliatori che realizzano lo scheletro, ai fabbri che creano le armature, ai sarti che cuciono i costumi di raso, velluto o cotone, agli scultori che modellano la testa in modo tale che possa esprimere il carattere assegnato al pupo dalla storia che dovrà interpretare.
I due centri in cui fin dalla metà dell'Ottocento si è sviluppata la tradizione di pupi siciliani sono Catania e Palermo, ed è ancora qui che vengono prodotti anche se per un mercato completamente diverso.
Le compagnie di pupari si sono ridotte al lumicino, e gli artigiani, per sopravvivere, si sono adattati a produrre i pupi tanto ambiti dai turisti nelle località turistiche dell'isola, necessariamente meno costosi di quelli classici, più piccoli e meno curati nei particolari.
Fortunatamente, continua anche una limitata produzione di pupi tradizionali, repliche fedeli di quelli ottocenteschi, alimentata da un vivace mercato di collezionisti d'élite.
LA TESSITURA E IL RICAMO
Chiunque abbia il gusto della biancheria ricamata, conosce e apprezza lo "sfilato" siciliano, una tecnica le cui prime applicazioni risalgono al '400, quando veniva
impiegata prevalentemente per impreziosire grandi pezze di lino che venivano sfilate quasi per intero e intessute di nuovo con filo da ricamo. In seguito, la tecnica fu semplificata, prima
sfilando la stoffa solo dove si desiderava realizzare le decorazioni, poi lavorandola interamente a rete.
Diversamente da altre tecniche oggi praticamente estinte, quale quella dei damaschi di Messina che, nel Settecento, attiravano clienti da tutta Europa, lo sfilato
siciliano ha continuato ad essere prodotto, prima nei conventi, quindi nelle case di esperte ricamatrici che continuano ancora ad operare, soprattutto nella parte orientale dell'isola, a Sortino,
in provincia di Siracusa, Vittoria, in provincia Ragusa, e Castiglione, in provincia di Catania.
Quasi a far da contraltare allo sfilato, nella parte occidentale dell'isola, a Erice, si perpetua una lavorazione opposta anche per tecnica e canoni estetici, quella
della “frazzata”: si tratta di tappeti realizzati lavorando su un telaio a mano ritagli di stoffe di recupero e filati di cotone, caratterizzati da una grande vivacità di colori composti in modo
tale da formare luminosi disegni geometrici, oppure arabeschi o motivi floreali. I prodotti che ne derivano, godono di un successo tale che quella che un tempo era solo un'attività casalinga è
diventata, in pochi anni, una delle attività artigianali trainanti della zona.
LA PIETRA LAVICA
Nella Sicilia orientale c'è una categoria di artigiani che può contare su un'instancabile fornitore di materia prima: l'Etna. La pietra lavica formatasi nel corso dei millenni è sempre stata utilizzata dagli architetti con una sorta di rispetto, assegnandole un ruolo che trascendeva la mera funzione strutturale e che si materializza nella suggestione trasmessa dai lastroni neri e lucidi che ornano le pareti esterne dei santuari e delle chiese costruite nella zona etnea tra il '600 e il '700, oppure dai massicci mascheroni che ornano i palazzi barocchi di Ibla, Noto e Acireale.
L'abilità di trattare questa materia prima così particolare si è trasmessa di padre in figlio per secoli, alimentando un artigianato che è tuttora molto vivace nei comuni alle falde dell'Etna, ed in particolare a Giarre, dove la produzione spazia dagli oggetti artistici ai componenti per l'edilizia (balaustre, colonne, sedili, fontane, ecc. ), agli oggetti ricordo di stile tradizionale.
IL FERRO BATTUTO
Benché le origini non differiscano molto dalle altri regioni italiane, l'artigianato del ferro battuto siciliano ha seguito percorsi diversi che ben presto lo hanno reso uno degli elementi più caratterizzanti dell'architettura.
Ne sono un esempio eclatante le monumentali finestre dei palazzi edificati a Taormina, oppure le sontuose balconate che ornano gli edifici dell'età barocca.
Tali nobili origini hanno fatto sì che ai giorni nostri, una volta tramontate le commesse legate agli strumenti agricoli, i fabbri ne traessero ispirazione per rinnovare la loro produzione. Ispirandosi a canoni estetici barocchi e arabeggianti hanno cominciato a forgiare oggetti d'arredamento (in particolare letti, candelieri, lampadari, portavasi, lanterne e grate) che spesso realizzano anche su disegno del cliente.

LA FRUTTA MARTORANA
Il marzapane è un ingrediente di pasticceria di tradizione araba importato in Sicilia nel Duecento.
Si prepara pestando le mandorle insieme allo zucchero (ed eventualmente miele), legandole con albumi e aromatizzandole con acqua di fior d'arancio e vaniglia. Se la fusione di mandorle e zucchero è fata a freddo prende il nome di Pasta Reale o Pasta di mandorle.
Se invece avviene sul fuoco, a fiamma moderata finché lo zucchero si scioglie completamente, allora l'impasto prende il nome di Marzapane. La preparazione a base di marzapane più tipica dell'isola è la Frutta di Martorana. Il nome deriva da un convento vicino a Palermo le cui suore furono le prime , in occasione delle commemorazioni novembrine dei santi e dei defunti, a preparare dolcetti di marzapane che imitano perfettamente vari tipi di frutta e verdura.
Successivamente è diventato tradizione delle famiglie palermitane recarsi al Convento ad acquistare i dolcetti, finche l'idea si è diffusa in tutta l'isola e i vari pasticceri si sono sbizzarriti con i soggetti più fantasiosi, dal pane e salame alla coscia di pollo arrosto, alla pasta al sugo e così via.
L'artigiano che lavora la Frutta Martorana deve essere dotato di grande creatività e abilità tecnica, ma deve anche saper lavorare con grande rapidità per evitare che una prolungata manipolazione faccia affiorare l'olio di mandorla di cui è intrisa la pasta, rovinando l'aspetto e il gusto del prodotto.
Il tocco finale è affidato all'uso dei colori, rigorosamente naturali, e alla lucidatura che, secondo tradizione, è ottenuta con un sottile strato di gomma arabica.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Rispetto alle altre regioni meridionali, in Sicilia, il panorama delle manifestazioni cambia registro e, per qualche verso, si riallinea a quelle centro-settentrionali, con un arricchimento deciso in eventi dedicati all'antiquariato e al collezionismo.
È un chiaro segno di una diversa sensibilità del mercato, capace di apprezzare una qualità che non sia solo di facciata. Attraverso gli stessi canali, quindi, vengono regolarmente veicolati i migliori prodotti dell'artigianato locale, quelli che poco hanno da temere nel confronto con i manufatti antichi, e poco da spartire con la paccottiglia che deborda nelle bottegucce delle località turistiche.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente