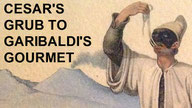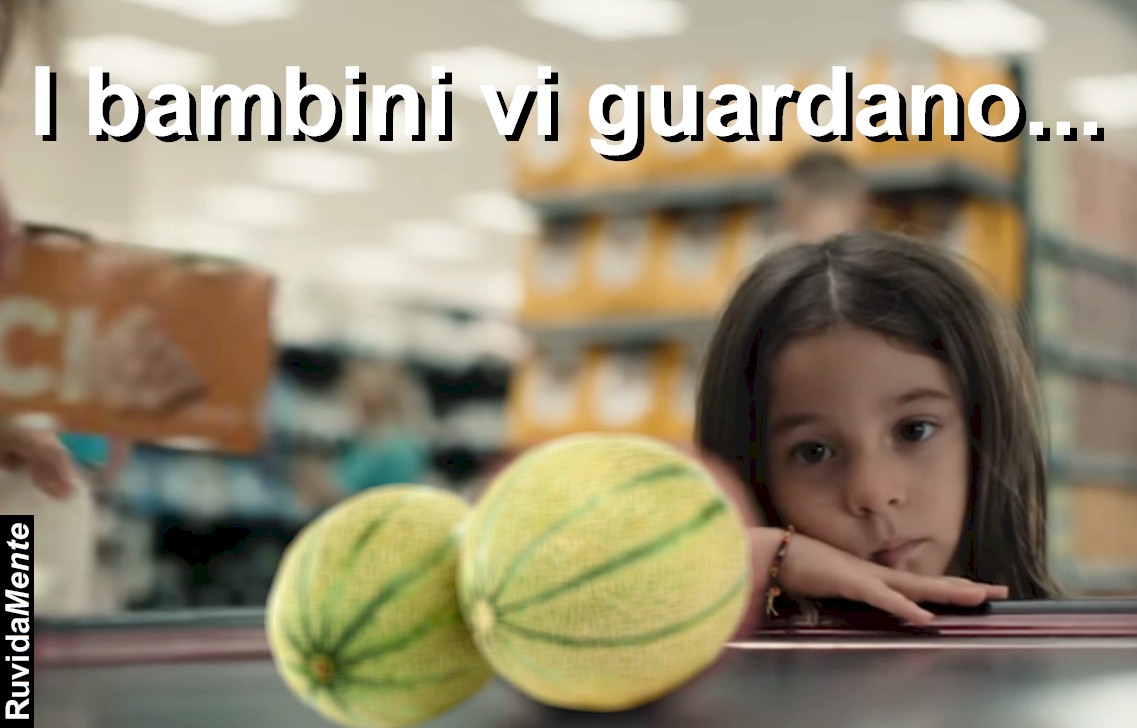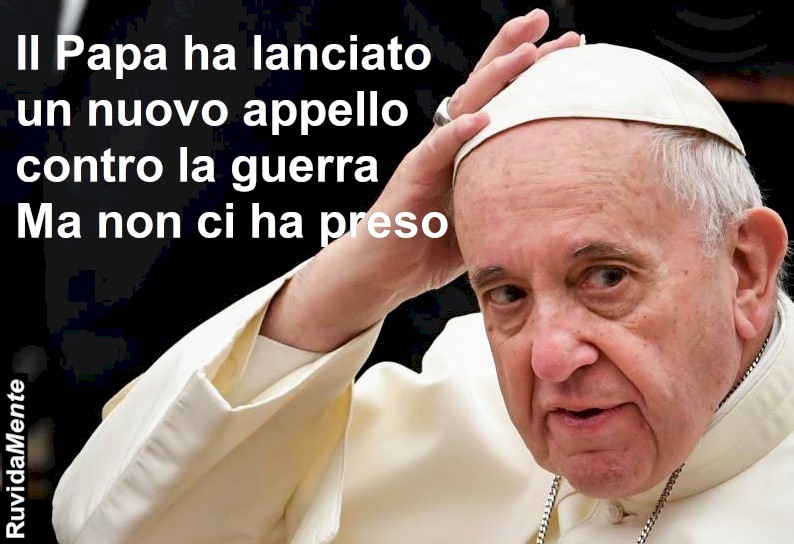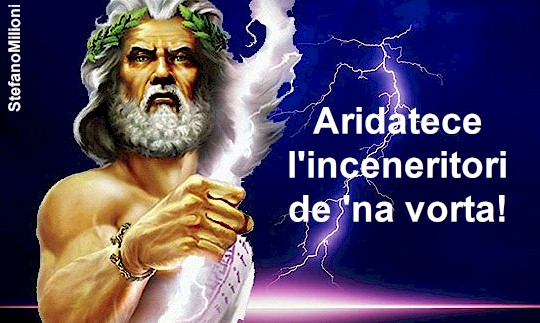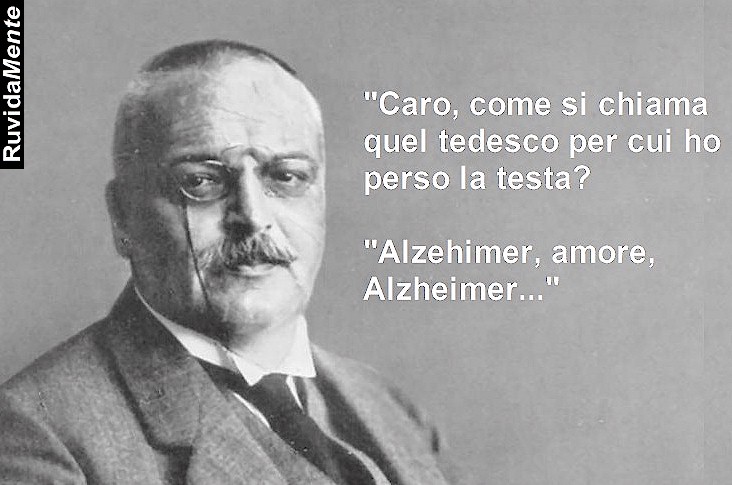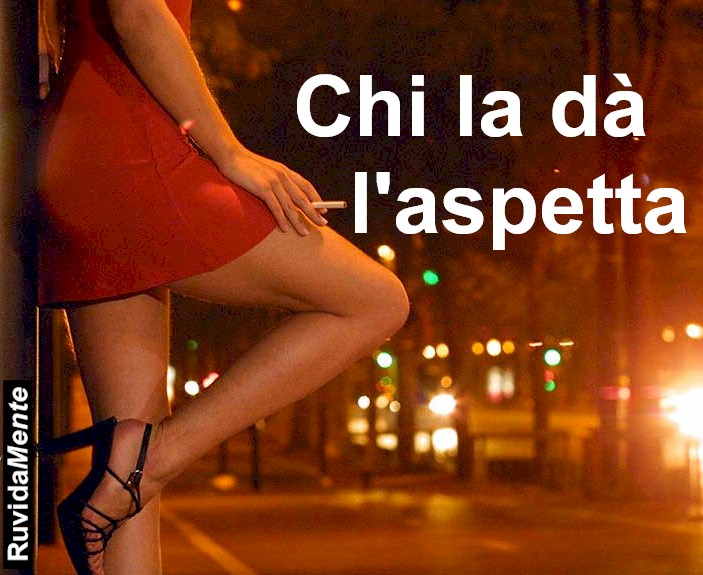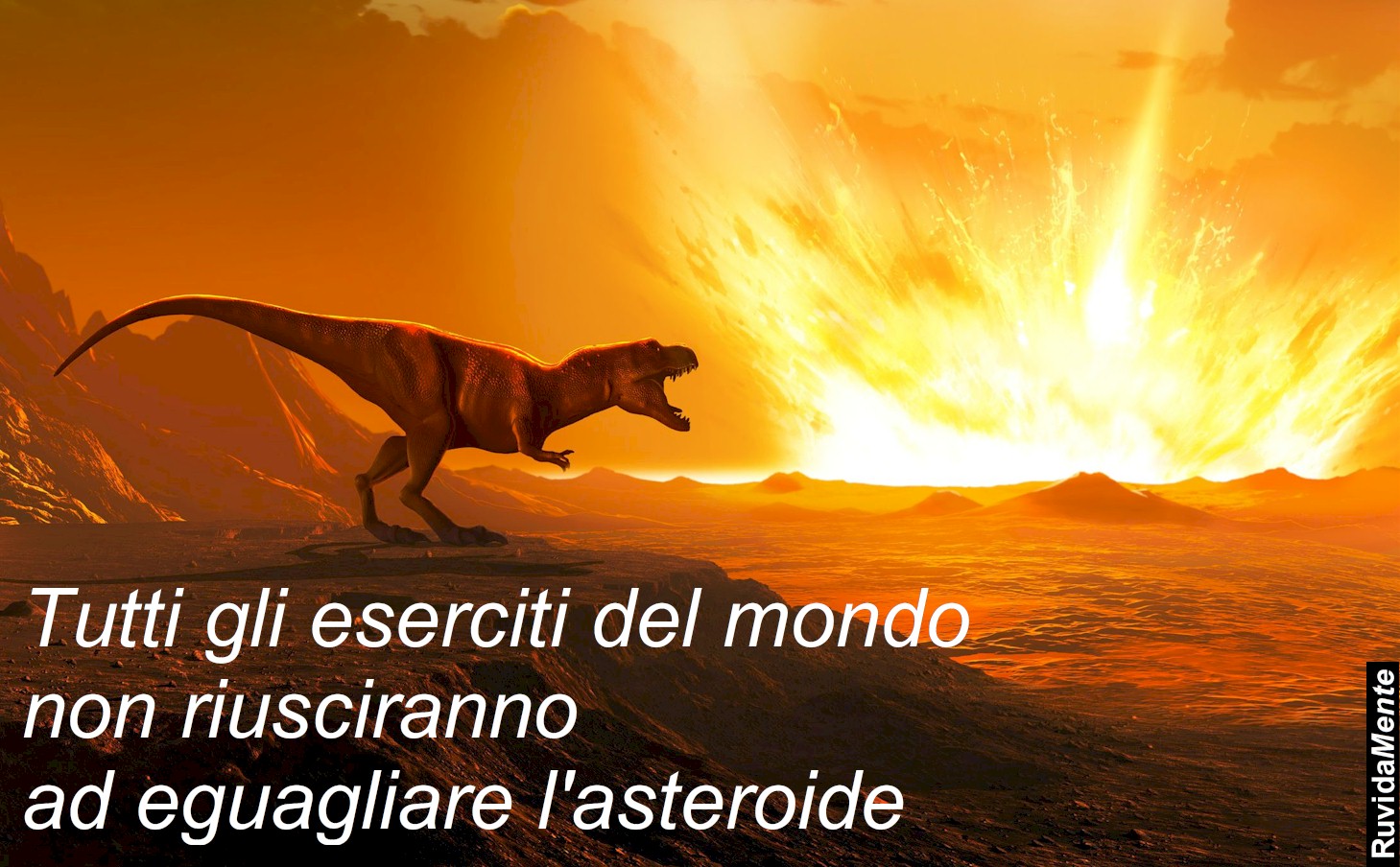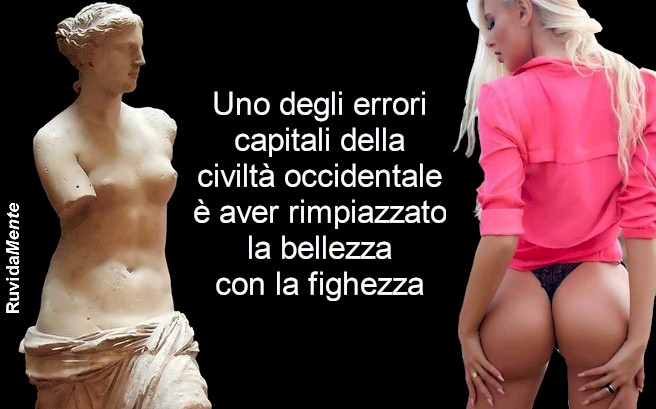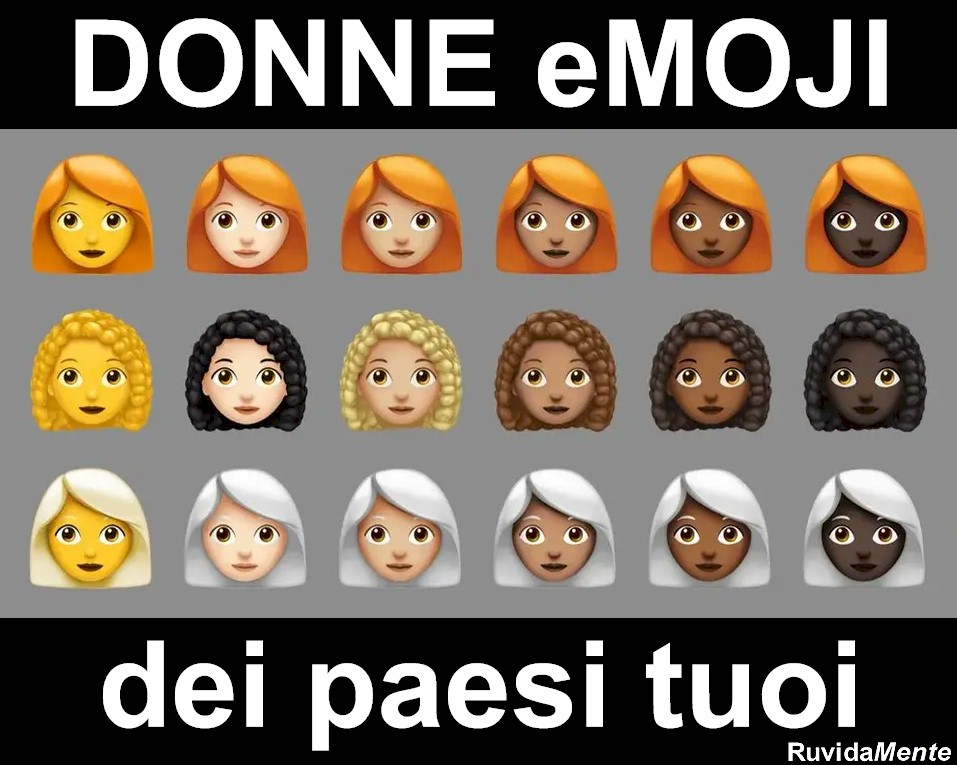L'immenso patrimonio artistico della Toscana è diffuso capillarmente nel territorio e si presenta in tutte le forme possibili, da quelle "elette", quali pittura, scultura e architettura, a quelle meno celebrate ma altrettanto straordinarie, come la ceramica, l'intaglio del legno, l'oreficeria, la lavorazione dei metalli e dei tessuti.
L'esercizio di queste arti ha impegnato per secoli legioni di artigiani che hanno cominciato ad assottigliarsi quando è venuta meno quella committenza illuminata che ha caratterizzato soprattutto il periodo del Rinascimento.
A quel punto, le professionalità accumulate hanno preso strade diverse e l'artigianato toscano si è diversificato in due distinte tipologie. Una parte ha messo a frutto le sue capacità tecniche applicandole ad una nuova tipologia di prodotti, meno raffinati ma molto remunerativi, procedendo verso una forte industrializzazione che ha permesso la nascita di floridi distretti quali l'oreficeria di Arezzo, i tessuti di Prato, i mobili di Poggibonsi e il marmo di Carrara. L'altra parte, invece, ha capitalizzato le proprie abilità tecniche e manuali indirizzandole alla manutenzione e al ripristino del patrimonio artistico preesistente.
Nel mezzo, comunque, sopravvive, e talora prospera, una folta schiera di artigiani che riescono a coniugare le tecniche antiche e le abilità manuali con le richieste del mercato, dando soddisfazione ad una clientela di nicchia abbastanza colta e volenterosa da andarseli a cercare nei piccoli paesi, quasi sempre ben lontani dagli itinerari canonici del turismo organizzato.
LA CERAMICA
In quasi tutte le regioni italiane, la lavorazione dell'argilla si è sviluppata parallelamente nella produzione di oggetti rustici, d'uso quotidiano, e in forme più raffinate che spaziano dalla maiolica alla ceramica d'arte, alla porcellana. E quasi sempre, una delle due ha prevalso sull'altra caratterizzando in questo modo la produzione regionale. In Toscana, invece, queste due forme di artigianato continuano a convivere, godendo entrambe di un buon successo commerciale.

Nel campo della ceramica "rustica", come non ricordare la grande tradizione del cotto toscano, con il suo maggior centro nelle fornaci dell'Impruneta, dove si produce
soprattutto cotto per pavimenti, ma anche grandi orci da olio, recipienti da salamoia, conche e vasi da giardino modellati a mano. Oppure le pentole in coccio, ideali per cuocere i fagioli e le
tante zuppe tipiche soprattutto dell'area meridionale della regione, prodotte in particolare nelle aree di Colle Val d’Elsa e di Chiusi, nel senese, e i classici catini a forma troncoconica, con
largo orlo e con l’interno verniciato “a spugnature” di color verde su fondo bianco o giallo tenue, nella cui produzione si sono specializzati gli artigiani di San Giovanni alla Venna, in
provincia di Pisa.
Grazie alla grande tradizione artistica toscana, il fronte della ceramica decorativa si presenta molto più ricco, sia come diffusione che nelle sue forme esteriori.
Particolarmente vivace è l'area aretina dove, nelle botteghe di Cortona, Anghiari e Monte San Savino, continua la manifattura di pezzi della tradizione antica, come i piatti decorativi, a fondo giallo e con al centro la margherita. In provincia di Firenze, ed in particolare a Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino, è tuttora florida la produzione di piatti decorativi, boccali, vasi e altri oggetti dalle forme e dalle decorazioni tradizionali, ispirate soprattutto alle storiche manifatture di Doccia che da Sesto erano esportate in tutto il mondo.
IL MARMO E L'ALABASTRO
La felice congiunzione di un contesto culturale pervaso, per secoli, delle più alte forme d'arte che abbia conosciuto l'umanità, e di risorse naturali qualitativamente e quantitativamente straordinarie come il marmo delle Alpi Apuane e l'alabastro di Volterra, ha permesso il radicarsi nel territorio di forme artigianali e artistiche non comuni. Trattandosi di materie prime che nel tempo non hanno mai conosciuto cadute di interesse da parte del mercato, era ovvio che per gran parte delle produzioni si finisse per cedere ai vantaggi dell'industrializzazione e della produzione di serie.
Questo cambiamento ha avuto un impatto minore nel settore del marmo dove le macchine si sono sostituite agli scalpellini in quelle lavorazioni che, di fatto, erano in serie anche quando tutto il ciclo di lavorazione era integralmente artigianale.
Dalle Apuane alla Versilia, però, la secolare arte di modellare la pietra è entrata a far parte del patrimonio genetico degli artigiani locali che riescono ad esprimere il meglio di se' solo attraverso la più tradizionale manualità. Certo, scalpelli pneumatici, frese e levigatrici elettriche sono entrate a far parte del corredo di attrezzi di ogni laboratorio, ma il loro utilizzo resta confinato alle fasi di sbozzatura e prima finitura dei manufatti.
Quando si passa alla fase finale, quella in cui il committente, sia esso un privato o un artista di grido, vuole vedere trasferite nel marmo emozioni e sensazioni,
allora tutto torna, come un tempo, a dipendere dalle nude mani dell'artigiano.
Per quanto riguarda l'alabastro, invece, trattandosi di un materiale tenero, inadeguato per la decorazione architettonica di esterni, l'attività è da sempre concentrata
nella produzione di oggetti e suppellettili; la cui inevitabile standardizzazione ha prodotto un generalizzato scadimento della qualità. E non è casuale che oggi le migliori produzioni siano
opera di quegli artigiani animati dall'istinto della ricerca di nuove forme espressive alle quali le straordinarie caratteristiche dell'alabastro hanno dimostrato di potersi piegare egregiamente.
IL VETRO
Per uno strano scherzo del destino, due città toscane, Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena, ed Empoli, in provincia di Firenze, dopo aver sviluppato due distinte forme di artigianato del vetro, si sono evolute l'una nella direzione dell'altra finendo per scambiarsi le rispettive leadership. L'attività, a Colle Val d'Elsa, era iniziata soffiando il classico vetro verde con cui si producevano fiaschi e damigiane.
Di qui si è passati a forme più raffinate di lavorazione, sostituendo via via il vetro al cristallo il quale, oltre che formato, veniva lavorato da abili incisori. La
gamma degli oggetti, sia di foggia antica che moderna, è oggi vastissima, ma il prodotto principale sono i bicchieri, in alcuni casi soffiati a bocca, spesso stampati da sofisticati robot, quindi
impreziositi da certosine cesellature a mano.
Nello stesso periodo in cui a Colle si formava il rustico vetro verde, Empoli era uno dei più importanti centri italiani di produzione dei bicchieri, ma la produzione
ha presto allargato il ventaglio delle sue tipologie, arricchendo la gamma dei modelli con bottiglie, vasi, caraffe, contenitori e quant'altro la fantasia degli artigiani riusciva ad inventare
combinando la funzionalità e la duttilità del materiale al suo estro creativo.
Era inevitabile che gran parte delle aziende del settore finisse per organizzarsi industrialmente, ma ad esse si affiancano numerosi i laboratori artigianali impegnati con successo in piccole produzioni dove le tecniche tradizionali associate alla ricerca di canoni estetici innovativi sono l'arma vincente.
IL FERRO BATTUTO
Il Casentino è una zona ricca di corsi d'acqua e questa risorsa ha permesso la nascita di molte ferriere che lavoravano i minerali estratti in loco. Dalla lavorazione del ferro grezzo si è presto passati alla produzione di strumenti di lavoro per i contadini e per i boscaioli, per poi dedicarsi, in tempi più recenti, a lavorazioni più sofisticate ad opera di artigiani operanti soprattutto a Stia, Castel San Niccolò, Poppi, Subbiano, a Capolona.
La produzione di oggetti in ferro battuto, comunque, è diffusa in tutta la regione, seppur con minore concentrazione di botteghe rispetto alla zona casentinese.
Qua e là, inoltre, ci si può imbattere in produzioni particolari, come quella dei "testi", strumenti per cuocere sul fuoco le cialde di farina di castagne, tipici della valle del Serchio e delle zone limitrofe, dalla Lucchesia fino alla Garfagnana.
A Scarperia, invece, l'originaria lavorazione del ferro battuto si è evoluta specializzandosi nella produzione di coltelli la cui qualità si è imposta anche in mercati molto lontani, contribuendo alla nascita di un distretto produttivo che oggi coinvolge un elevato numero di aziende artigianali.
LA TESSITURA
Le straordinarie fortune dell'industria tessile pratese hanno radici lontane e sono il risultato di attività artigianali specializzate che nelle varie zone della regione si sono tramandate per secoli di madre in figlia.
Nonostante la forte industrializzazione del settore, antichi telai e abili tessitrici che lavorano secondo i modi della tradizione sono ancora presenti in molti centri della regione, e vengono utilizzati per intessere le coperte di lana a complicati disegni geometrici o floreali (la cosiddetta “opera a rosastella”); i tappeti e la tela ruvida che, un tempo, serviva per la biancheria da letto e da cucina, oppure il cosiddetto "truciolone", un tessuto povero e grossolano ottenuto tessendo striscioline di stoffe di recupero e filo di canapa, oggi assai ricercato per tappeti e scendiletto.
Si tratta di prodotti particolari, ai margini dei canali commerciali tradizionali, reperibili con maggiore facilità nelle botteghe o nelle bancarelle di centri minori
come Aulla, a nord di Carrara, a Castelnuovo Garfagnana e Barga, in Lucchesia, e a Roccalbegna, in provincia di Grosseto.
Se nella maggior parte dei casi, comunque, si tratta di attività che sopravvivono più per la passione che anima gli artigiani che per l'effettivo apporto economico, è
importante rilevare come nel Casentino, in particolare a Stia, Poppi, Pratovecchio e Castel San Niccolò, stia rifiorendo l'antica produzione del "panno-lana", al punto da essersi trasformata in
una delle attività trainanti dell'economia locale.
L'OREFICERIA
La microfusione dell'oro, ottenuta attraverso il processo della "granulazione" è una tecnica messa a punto dagli Etruschi, maestri eccellenti e indiscussi nella lavorazione dei gioielli, e tramandata fino ai giorni nostri.
Il coniugarsi di questa prestigiosa progenitura con una società opulenta e raffinata ha permesso all'oreficeria toscana di svilupparsi attraverso i secoli con la realizzazione di veri e propri capolavori che hanno interessato tutti i possibili campi di applicazione di quest'arte, dai gioielli che ornavano le nobildonne agli arredi sacri, ai fini lavori di cesello che impreziosivano le case di nobili e mercanti.
Inevitabilmente, il grande e prolungato successo dell'oreficeria toscana è approdato alle più avanzate forme di industrializzazione, trasformando, in particolare, il territorio aretino in uno dei più importanti centri italiani per la produzione di gioielleria.
Anche in questo campo, comunque, continuano ad operare numerosi artigiani che fanno della manualità e della creatività l'arma vincente. Ne troviamo numerosi nella stessa Arezzo, a Firenze e distribuiti in tutto il territorio regionale, soprattutto nelle zone dove turismo e benessere creano condizioni di mercato ottimali.
GLI INTRECCIATI
Se ci si allontana dai grandi centri e dalle città a forte vocazione turistica, dove gli oggetti intrecciati tradizionali sono sommersi da quelli cinesi e filippini, si può ancora scoprire quanto sia vitale questa antica e umile forma di artigianato.
Benché diffusi in tutta la regione, gli intrecciati sembrano godere un momento di grande vitalità soprattutto nella parte nordoccidentale della regione, dall'entroterra pisano fino al confine con la Liguria e l'Emilia.
A Buti e Ruota, sui monti che separano Pisa da Lucca, si producono cesti delle più svariate forme e dimensioni intrecciando canne e stecche di castagno, oppure ventole per attizzare il fuoco.
Nell'entroterra della Versilia, nei paesini della Lunigiana e della Garfagnana, si intrecciano esili rami di salice, nocciolo, frassino e olmo per produrre vari tipi di cesti a un manico, grandi ceste ovali o rotonde, gabbie da foraggio dalle forme più svariate e il “valletto”, il grande contenitore a forma di conchiglia un tempo impiegato per la raccolta della frutta e per la vendemmia.
IL GESSO
La figura del "parente povero" non è destinata ad essere sempre perdente. Ne sanno qualcosa certi artigiani della Luchesia (in particolare, di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca) che si sono ritrovati eredi di una curiosa tradizione nata sui monti della Garfagnana e della val di Lima. Quando qui la povertà era estrema, qualcuno s'inventò di lavorare una materia poverissima, il gesso, modellando statuette che potevano essere spacciate, con una buona dose d'ingenuità, per marmo.
Grazie alla buona fattura, si passò presto a dipingere queste figurine, specializzando la produzione in aree distinte: il presepe, i santi, i busti dei grandi personaggi, e così via.
Per qualche decennio, queste :statuette sono state esportate con successo in ogni angolo del mondo, poi è intervenuta una crisi che, però, non ha, cancellato completamente questo settore, che si è in parte riconvertito, ottimizzando la produzione affiancando al gesso altre materie prime, quali la cartapesta e le resine sintetiche, e limitando l'offerta alle figurine dei presepi e ai soggetti di ispirazione religiosa.

IL LARDO DI COLONNATA
Scoperto solo recentemente dalla ristorazione d'élite e dai gourmet, il lardo prodotto a Colonnata, un piccolo centro delle Alpi Apuane la cui unica risorsa è stata per secoli il duro lavoro nelle cave, è sempre stato prodotto per autoconsumo e raramente ha affrontato viaggi più lunghi di quello che dal paese porta a Carrara.
La sua straordinaria qualità è determinata in gran parte dal contenitore utilizzato per la stagionatura, vasche realizzate in marmo perché in loco era il materiale a portata di mano e a costo zero e che si sono rivelate ideali grazie alla porosità che garantisce al prodotto finale un equilibrio gustativo perfetto.
La preparazione prevede che le vasche di marmo siano prima strofinate energicamente con l'aglio, quindi si dispone sul fondo un abbondante strato di sale marino, pepe, spezie (cannella, chiodi di garofano, coriandolo: ogni famiglia ha la sua ricetta segreta), rosmarino, salvia e aglio.
Sopra questo "letto profumato" si dispongono i pezzi di lardo, quindi si procede alternando aromi e lardo finché la vasca è piena. Si lascia la vasca coperta per una settimana, quindi si ricopre il tutto con una salamoia di acqua e sale, si chiude di nuovo e si lascia stagionare per almeno sei mesi in locali freschi.
Al momento del consumo, si ripuliscono i pezzi di lardo dalla concia e si servono a fette sottilissime dopo averli adagiati su crostini caldi di pane rustico: un'esperienza che non ha eguali.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Inevitabilmente, in Toscana, artigianato e antiquariato si intrecciano costantemente e in nessun'altra regione come in questa si presentano come le due facce di una stessa medaglia.
Per questa ragione, la prima raccomandazione è quella di non far derivare le proprie decisioni unicamente dal "titolo" delle manifestazioni.
È quanto mai frequente, infatti, imbattersi negli stand di artigiani, diversamente introvabili, nei più insospettabili mercatini dell'antiquariato, come spesso accade che le manifestazioni dedicate all'artigianato, ancorché specialistiche, si trasformino in felici occasioni per mettere le mani su oggetti cercati a lungo e invano proprio nelle botteghe degli antiquari.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente