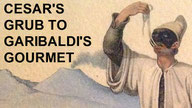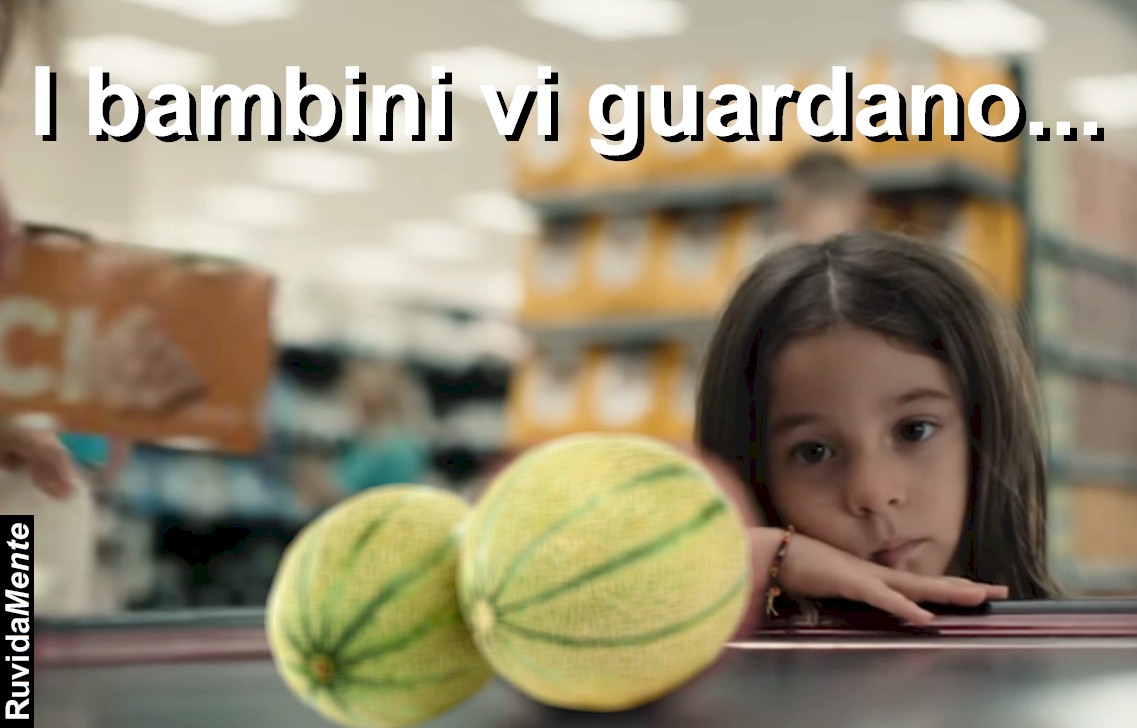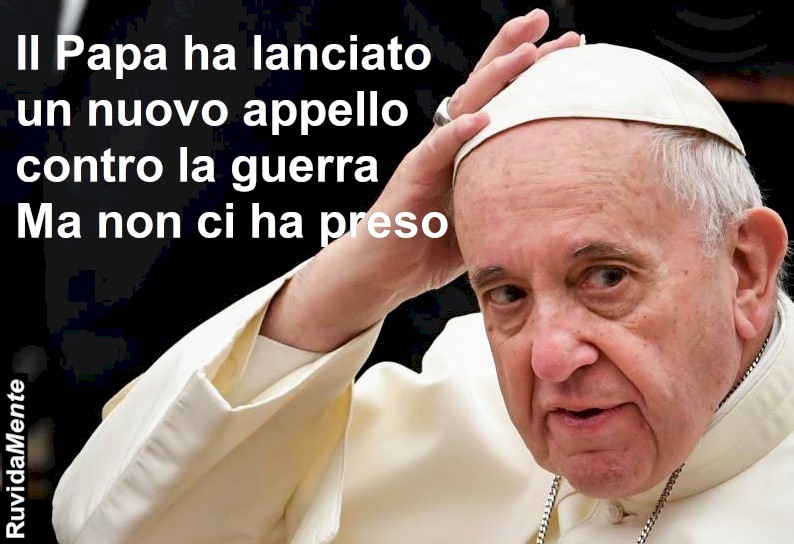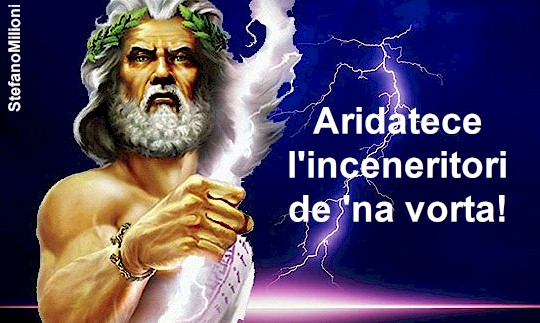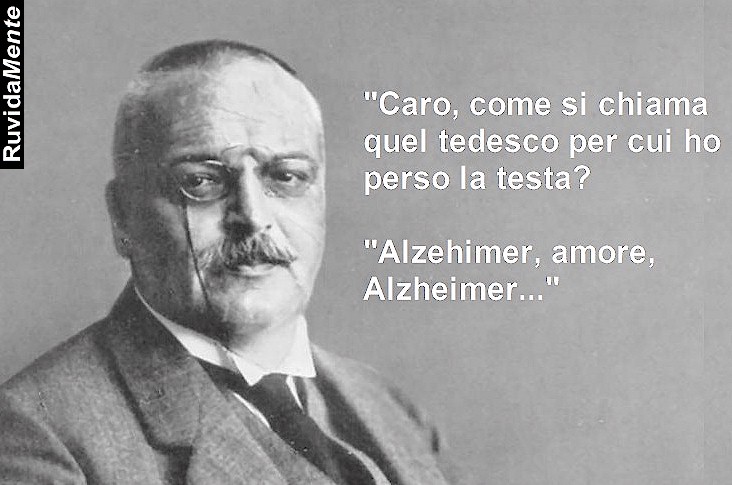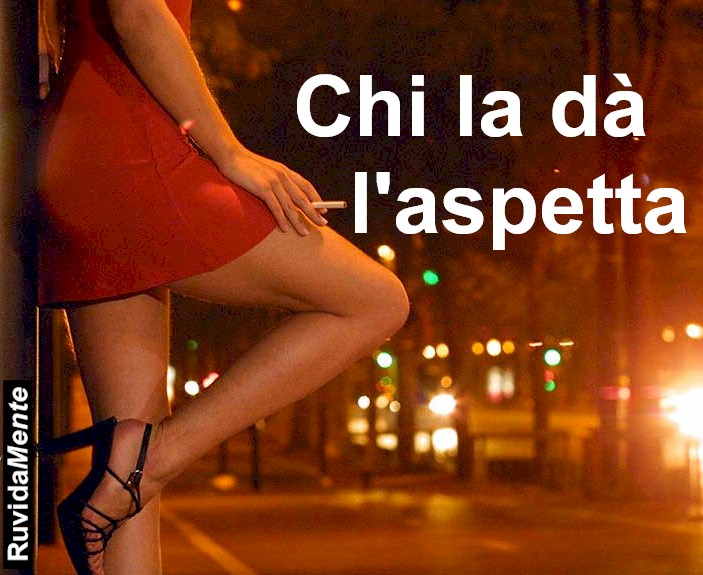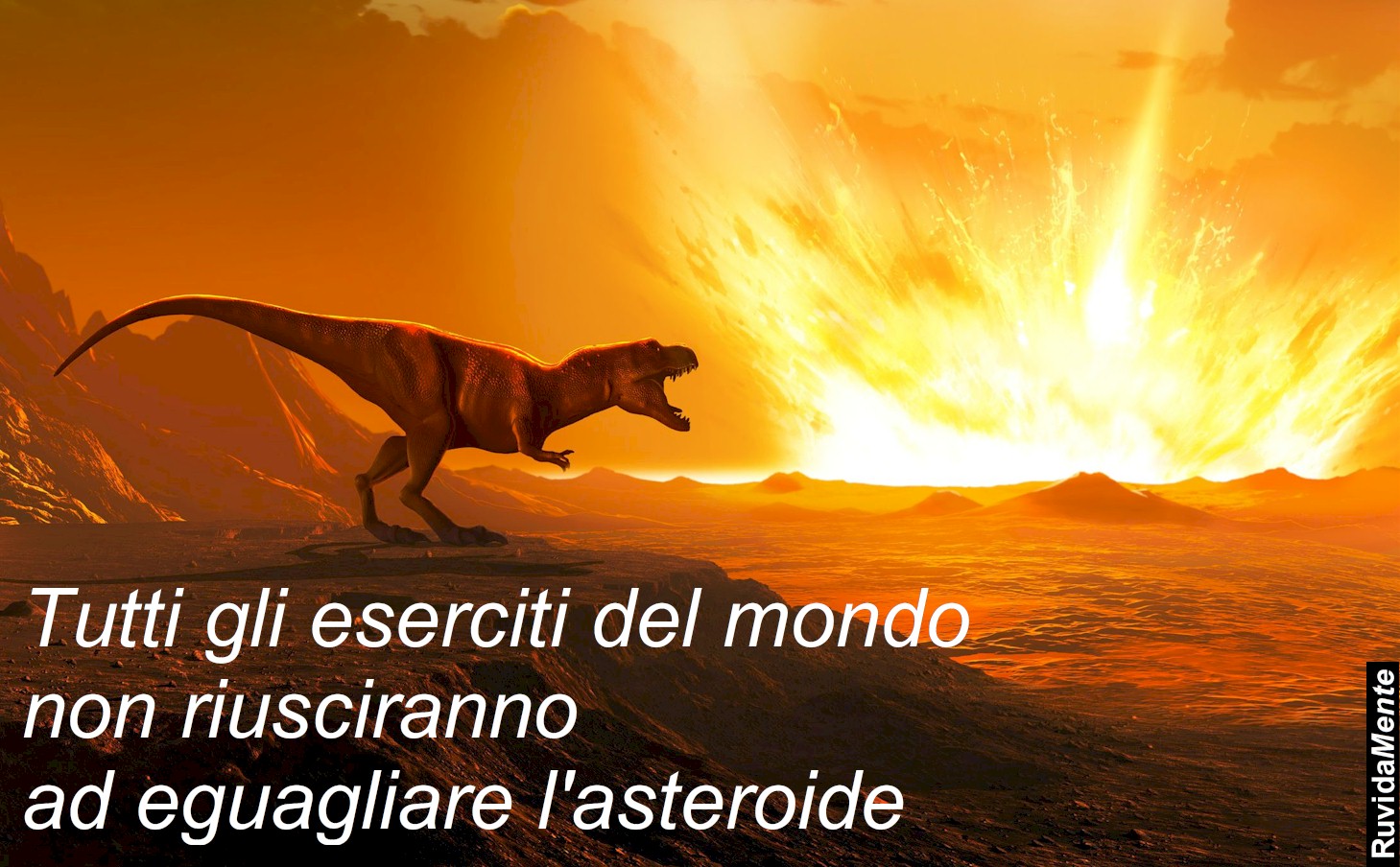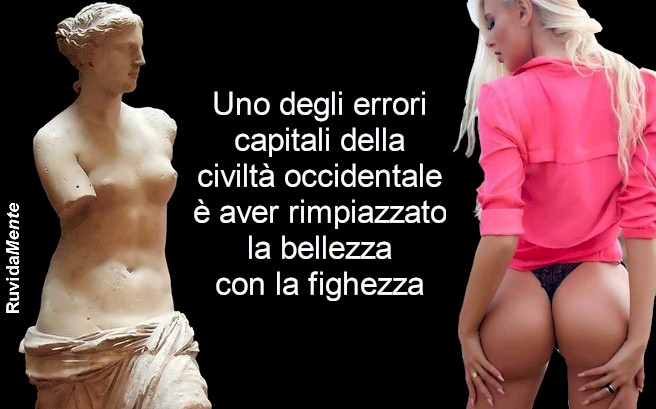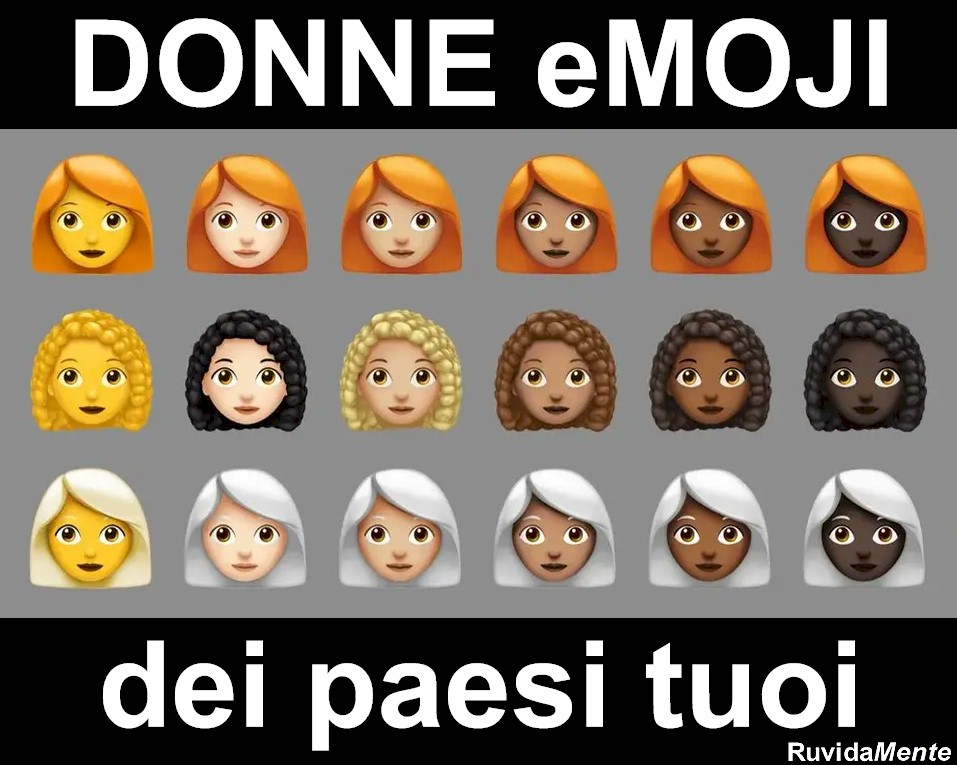Basta una breve visita per percepire come il patrimonio ornamentale conservato nelle chiese, nei castelli e nei musei di questa regione sia l'espressione di un'antica tradizione di artigianato artistico che spazia dalle sculture di carattere religioso in pietra risalenti al periodo romantico alle travature in stile gotico, dai soffitti a cassettoni del periodo rinascimentale alle inferriate in ferro battuto ispirate allo stile barocco, dai cinturoni ornati da chiodi in zinco alle cinture in pelle ricamata.
D'altra parte, il Trentino Alto Adige racchiude in se' una straordinaria complessità
culturale espressa da enclavi ora di lingua e cultura tedesca, strettamente affini a quelle del Tirolo austriaco (in Alto Adige, ma anche in Val di Fassa, in Trentino), ora di lingua ladina (in
Val Gardena, in Val Badia e in Val di Fassa).
E si può affermare che proprio la presenza di forti contrapposizioni etniche ha finito per radicalizzare la valorizzazione delle particolarità locali nelle produzioni
dell’artigianato artistico così come nel costume popolare e nelle feste.
IL LEGNO
Nelle case sparse per le valli, un tempo, piccole sculture in legno (in particolare animali-giocattolo, figurine da presepe, tappi per
bottiglie raffiguranti teste grottesche, pipe) venivano lavorate con processi rigorosamente manuali, ma associati ad una sorta di produzione "in serie" dove ogni componente della famiglia
si specializzava in una fase della lavorazione, dalla sgrossatura alla rifinitura, alla coloritura e così via. Questo metodo di lavoro ha portato a forti effetti di stilizzazione delle forme e
dei disegni che sono diventati uno dei tratti distintivi di questo artigianato, oggi orientato prevalentemente alla produzione di oggetti puramente decorativi e alle sculture di soggetto
sacro.
Le statue in legno policromo, che riprendono una tradizione già praticata attorno alla metà del '600, provengono soprattutto dalla Val Gardena, ma questo artigianato è
praticato con successo anche nelle valli di Fiemme e di Fassa ed in varie altre località dell’Alto Adige.
A queste forme di artigianato eletto, però, si affiancano attività improntate alla produzione di oggetti utili e di impiego immediato. Qua e là operano gli ultimi
tornitori non assorbiti dall'industria, che ci regalano un vasto assortimento di coppe, ciotole, candelabri e giocattoli formalmente perfetti e dal sapore antico.
Lo straordinario successo dei vini trentini e altoatesini, infine, ha permesso il perpetuarsi dell'attività del bottaio, un mestiere così integrato nel tessuto sociale
da essere diventato parte integrante di molti i cognomi dell'Alto Adige. Benché la botte sia uno strumento decisamente "tecnico", qui la tradizione vuole che almeno il coperchio sia consegnato
all'estro dell'artigiano che vi si sbizzarrisce con decorazioni artistiche e iscrizioni augurali che fanno di ogni recipiente un pezzo unico.
I MOBILI
Il legno è sempre stato un elemento fondamentale nell'economia delle valli trentine e altoatesine e ha dato luogo a una serie di attività in cui, spesso, la componente utilitaria sconfinava in quella artistica, e viceversa.
Tra le produzioni "di servizio", la principale è sicuramente quella dei mobili “rustici”, diffusa in tutto il territorio trentino con particolare concentrazione di laboratori in Val di Non, a Pergine Valsugana, a Trento e in varie località sul Garda. Lagindo, Malles e Sarentino, invece, sono i principali centri di produzione in Alto Adige e si distinguono per gli arredi delle tradizionali "stube", le stanze con camino che costituivano spesso l'unico ambiente della casa contadina.
Ispirandosi alle stube, oggi si producono armadi, sedie, panche, tavoli, caratteristici “pensili” con serrature in ferro battuto, cassepanche intagliate, capaci di arricchire con un tocco di rustica nostalgia qualunque ambiente moderno. Spostandosi nelle valli di cultura ladina, infine, la produzione di mobili si caratterizza per l'impiego del legno di conifera decorato con fiori e fregi dai colori vivaci.
LE STUFE IN MAIOLICA
Nella cultura trentina e altoatesina, la "stube" ha finito per trascendere il suo ruolo di epicentro della casa e assumere un alto valore simbolico e culturale che ha "contaminato" positivamente tutti componenti che ne facevano parte. Tra questi, l’elemento più caratteristico è sicuramente la grande stufa in muratura che, complice l'abilità e la sensibilità artistica dei ceramisti locali, ha finito per arricchirsi con raffinate coperture in maiolica.

Nei musei locali se ne conservano esemplari monumentali, splendidamente decorati, che fungono da punto di riferimento per le produzioni attuali, caratterizzate da una
fattura di altissima qualità, tanto sul piano estetico che su quello funzionale.
I più importanti laboratori di produzione di stufe e oggetti in ceramica sono concentrati a Bolzano e a Brunico.
Qui, la maggior parte dei vasai ancora oggi modella l'argilla con il procedimento tradizionale e per cuocerla si avvale di vecchi forni a legna. Con queste procedure si plasmano ciotole, vasi, piatti e tazze di terracotta, le piastrelle di maiolica per le stufe, oggetti artistici e figurine di ceramica.
LA TESSITURA E IL RICAMO
Contro la retorica che vorrebbe ogni forma di artigianato nascere da mani umili per soddisfare le esigenze dei ricchi, i preziosi merletti a tombolo dell'Alto Adige, detti anche a fuselli, in origine erano frutto di un'occupazione svolta dalle signore benestanti con l'unico scopo di passare gradevolmente il tempo.
Sul loro esempio si dedicarono poi a quest'attività anche le donne di famiglia contadina, in particolare quelle della Valle Aurina, alle quali va il merito di aver dato inizio alla vera e propria produzione artigianale di questi piccoli capolavori, oggi concentrata soprattutto a Merano e in Val Sarentino.
Sempre in Alto Adige e, in particolare, a Brunico, è tuttora fiorente la produzione di capi di abbigliamento in panno loden e in feltro (prevalentemente cappelli e
pantofole), e di tessuti a mano con disegni tradizionali che impreziosiscono tovaglie, asciugamani, tende, cuscini e stoffe per arredamento.
Un altro elemento molto particolare dell'artigianato altoatesino, di stretta matrice austriaca, è il ricamo su pelle applicato a cinture, scarpe, portafogli, che viene
realizzato con penne di pavone tagliate in sottili strisce e poi ricomposte a formare disegni stilizzati.
I METALLI
La passione e l'impegno profusi da generazioni e generazioni di fabbri nell'arte di fucinare e lavorare a martello il ferro sono testimoniate dalle inferriate artisticamente modellate che ancor oggi adornano le residenze nobiliari, dalle recinzioni poste a delimitazione dei cori nelle chiese, dalle insegne delle antiche locande ed osterie nei paesi.
I fabbri ferrai di oggi si rifanno costantemente ai capolavori eseguiti dai loro predecessori e la loro produzione è caratterizzata da forme ed elementi decorativi
tratti dal patrimonio artistico regionale uniti a metodi e tecniche tradizionali.
Benché anche le altre lavorazioni del metallo, quali la creazione di oggetti in rame, in peltro e in ottone, siano profondamente radicate nella tradizione, quella del
ferro battuto è sicuramente la più significativa, con numerosi centri di produzione sparsi nel territorio, da Trento, alla Valsugana, a Cles, in Trentino, fino a Cortaccia, Dobbiaco, Lagundo, San
Candido e Chiusa, in Alto Adige.
LE MASCHERE
Molti studiosi attribuiscono alla produzione di maschere scolpite in legno origini che risalirebbero all'epoca precristiana. Esse, comunque, sono collegate agli aspetti più complessi, e per certi versi misteriosi, della tradizione culturale alpina ed è doveroso notare che, al di là del loro valore artistico e del diffuso utilizzo quali elementi di arredamento, queste maschere sono impiegate ancor oggi in vere e proprie cerimonie rituali, che si celebrano dall’inizio di Dicembre fino a Carnevale.
I figuranti le indossano unitamente ai coloratissimi costumi tradizionali per interpretare personaggi di volta in volta grotteschi, tragici, giocosi, eleganti e
raffinati.
La produzione è limitata e si concentra principalmente in Valfloriana e in alcune località delle valli di Fassa e di Fiemme, in Trentino, ed in numerosi centri
altoatesini della Val Pusteria e della Val Sarentino.
LA PIETRA E IL MARMO
Le cave di Lasa, in Val Venosta, sono rinomate per il candore del marmo che se ne ricava e per le sue caratteristiche di resistenza agli influssi atmosferici e climatici. Le opportunità offerte dalla presenza di questa preziosa risorsa hanno determinato lo sviluppo di attività artigianali e artistiche legate alla lavorazione del marmo e della pietra.
Per non disperdere questo prezioso patrimonio tecnico e culturale, fin dal 1982 è stato dato rinnovato impulso al locale Istituto Professionale per Scultori in Pietra dove, attraverso l'insegnamento delle lavorazioni tradizionali, come le tecniche di impiego dello scalpello, del mazzuolo, del valcagnolo e del picchierello, si cerca di promuovere le capacità artistiche degli allievi, avviandoli ad un settore di mercato dove la concorrenza si vince puntando sulla qualità delle lavorazioni piuttosto che sul prezzo.
L'OREFICERIA
Nei secoli scorsi, in Trentino Alto Adige la lavorazione dell'oro e delle pietre preziose era finalizzata principalmente alla realizzazione di oggetti di culto e alle decorazioni dei costumi tradizionali che, indossati durante le cerimonie più importanti dell'anno, dovevano eccellere in ogni particolare.
Fortunatamente, le competenze acquisite in questo settore, invece di andare disperse, sono state l'humus fertile su cui si è sviluppato un settore artigianale che, nelle sue forme espressive, appare totalmente nuovo, libero dai vincoli estetici della tradizione e completamente pervaso di creatività.
Così, oggi, dal felice accostamento dell'oro alle pietre preziose, alle perle, all'argento, agli smalti e all'acciaio, nascono monili che affascinano per la finezza della lavorazione e testimoniano eloquentemente la grande capacità e abilità dei loro artefici, sempre meglio inseriti nello spumeggiante mondo della moda italiana.

LO SPECK
Vagando per le salumerie delle città, l'alternativa è tra grossolane imitazioni ed il vero Speck altoatesino, garantito dal marchio a
fuoco del consorzio. Chi invece ha la fortuna di trascorrere una vacanza in Alto Adige, non dovrebbe perdere l'occasione per andare a caccia del vero Speck contadino, un prodotto destinato al
fabbisogno famigliare e, quindi, più difficile da reperire.
La produzione dello Speck, infatti, è una delle principali cadenze annuali della vita contadina e prende l'avvio ad autunno inoltrato in modo che il cosiddetto "nuovo"
possa esser pronto e ben stagionato per il tempo della fienagione.
Dapprima, le cosce del maiale vengono mondate, rifilate e poste per circa 15 giorni in una salamoia aromatizzata con pepe nero,
peperoncino in polvere, sale, aglio, bacche di ginepro e zucchero. Dopo averle asciugate, esse vengono affumicate a freddo (18-20ºC) per 2-3 settimane e poi stagionate per almeno 20-24 settimane
(a seconda del peso) in locali freschi, umidi e in penombra.
Al termine di questo ciclo lo Speck è pronto e si presenta sodo, con poca cotenna e con la parte grassa sui lati che non prevale su quella magra. Il gusto è ben
equilibrato, saporito e delicato al tempo stesso, con sfumature nel sapore e nel profumo diverse che variano nettamente da uno Speck all'altro.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Vista dall'esterno, la complessità di etnie e culture che si affiancano e sovrappongono nelle valli trentine e altoatesine è difficile da percepire. Eppure, basta avviarsi tra gli stand di una sagra o tra le bancarelle di un mercatino per rendersi conto di come, anche nei particolari apparentemente più frivoli, dai decori delle stoviglie allo stile dei ricami, ogni atto della vita quotidiana e professionale di queste genti sia espressione ed affermazione di un orgoglio atavico che nessuna globalizzazione sembra avere la forza di affievolire.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente