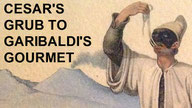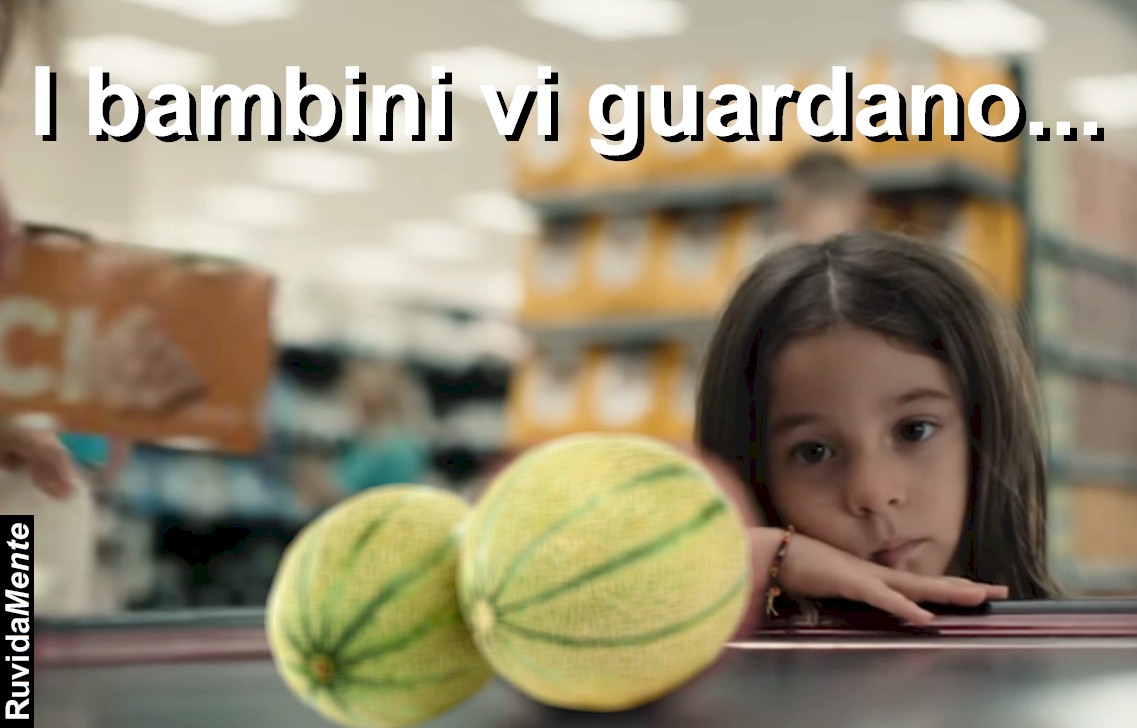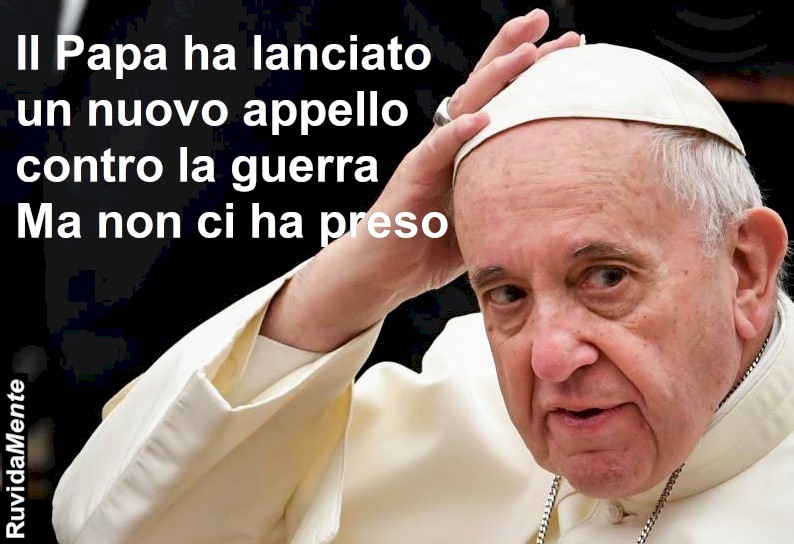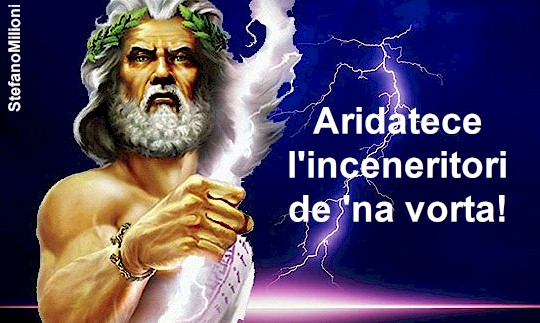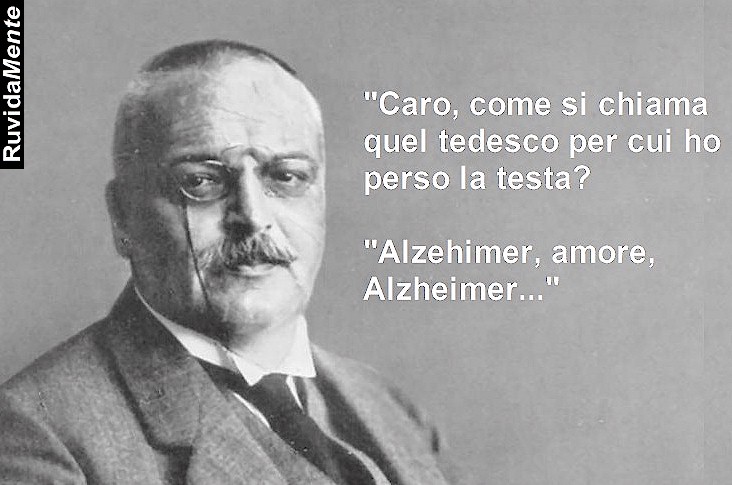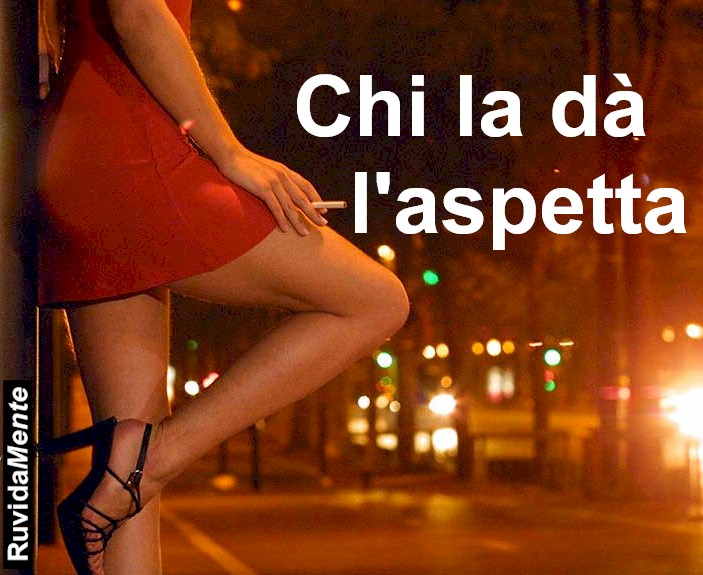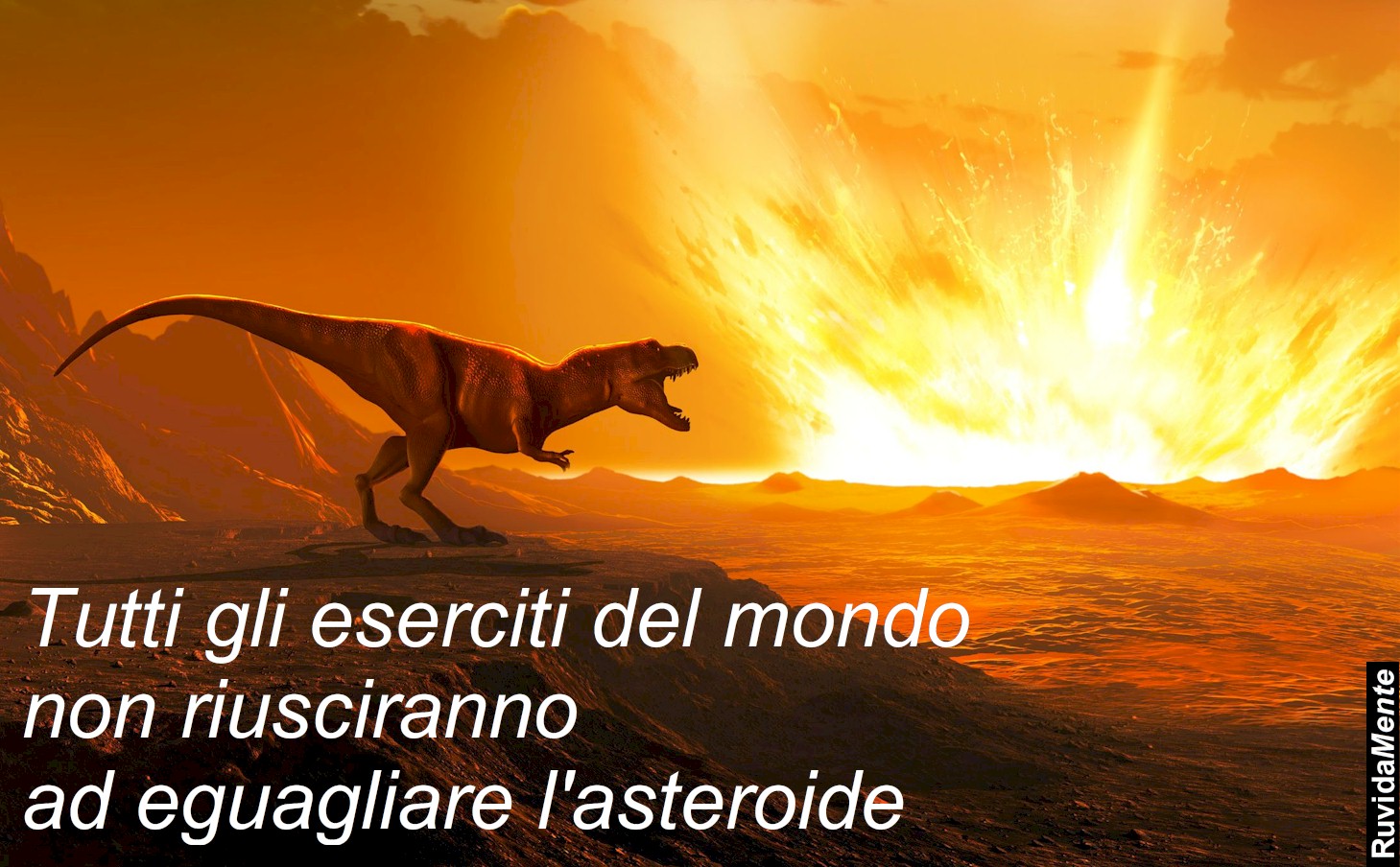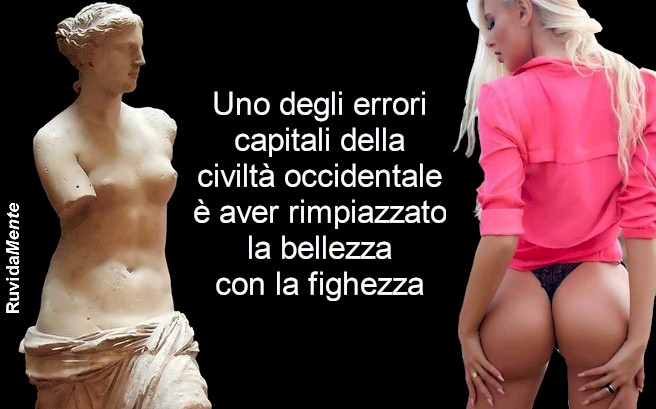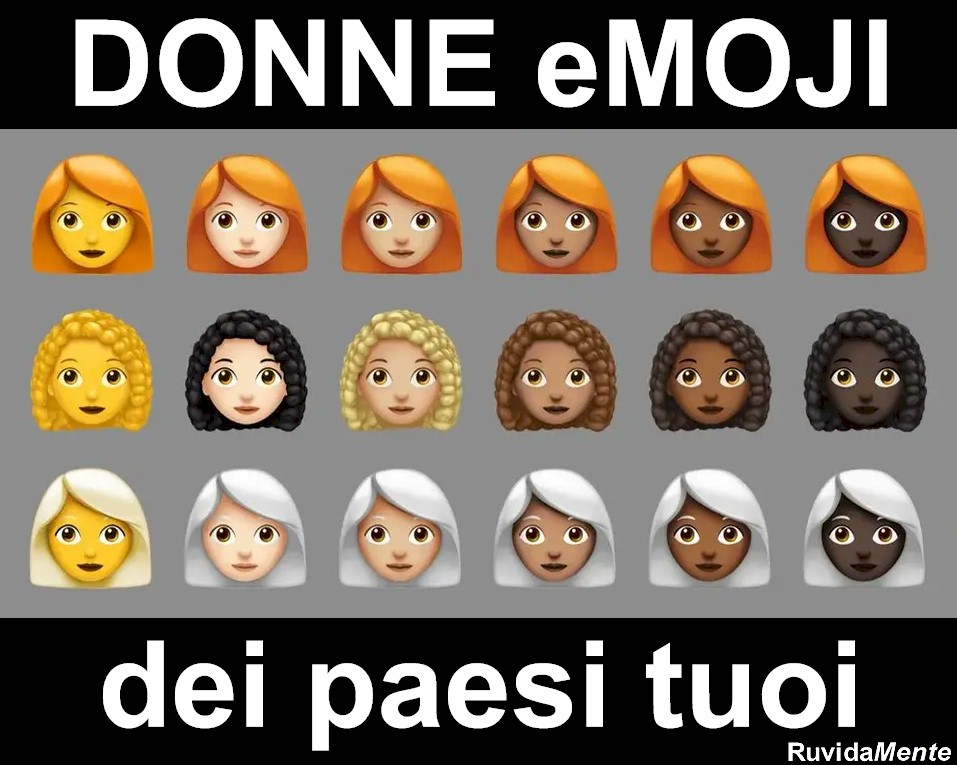Da sempre, in Umbria, la fabbricazioni di oggetti d'uso quotidiano si è affiancata a produzioni artistiche di alto livello che, per contiguità, hanno contribuito ad elevarne il livello estetico, come testimoniano ancora oggi le produzioni ceramiche e tessili.
D'altra parte, già nel Medioevo l'istituzione di Arti e Corporazioni, che tutelavano con rigore la qualità del lavoro delle botteghe, ci indica l'importanza culturale ed economica assunta dall'artigianato.
Questo patrimonio, seppur in parte ridimensionato dalla crescente industrializzazione, in Umbria è stato conservato gelosamente e oggi viene valorizzato attraverso lo studio e la ripresa delle tecniche e delle iconografie tradizionali con l'intento di non disperdere un grande bagaglio tecnico e creativo, e indicare nuove strade di sviluppo.
LA CERAMICA
In Umbria l'antica arte di plasmare l'argilla ha prosperato in numerosi centri (Deruta, Perugia, Gubbio, Gualdo Tadino, Orvieto, Città di Castello, Umbertide) e trova continuità in un artigianato che non cessa di ricercare, documentare e tutelare i suoi caratteri originari per valorizzare la qualità e la specificità della produzione contemporanea di ciascuna località.

Deruta è forse il centro di più antica tradizione, documentata fin dal '200, e giunta ai suoi massimi vertici nel '500, quando lo stile era caratterizzato da smalti bianchissimi e l'uso
dell'arancio, del blu e del giallo.
Nello stesso secolo, si imponevano anche le maioliche prodotte a Gubbio da Giorgio Andreoli, il più grande ceramista del '500 umbro, celebre per aver introdotto una
tecnica di origine araba che ammanta le opere di riflessi dorati.
A Gualdo Tadino,si realizzano ancora le ceramiche a riflessi a terzo fuoco, vanto secolare delle manifatture locali, mentre le produzioni di tipo industriale
prediligono forme e decori di ispirazione medievale.
Anche le ceramiche di Orvieto possono vantare tradizioni millenarie dallo stile inconfondibile, dove dominano i motivi vegetali e animali in un'originale mescolanza di
elementi etruschi e romanici.
La ceramica artistica di Umbertide, che ebbe grande sviluppo negli anni Trenta, si distingue per i riflessi metallici ottenuti con la tecnica del "nero fratta", mentre
a Città di Castello predominano le decorazioni araldiche e gli ornamenti a rilevo.
In questo tripudio di toni elevati, comunque, non sfigura nemmeno l'umile terracotta d'uso quotidiano, come i vasi, gli orci e le anfore di Ripabianca, oppure i vasi, i
fischietti e i tradizionali "ziri" di Ficulle e i laterizi in cotto fatti a mano ed essiccati al sole di Castel Viscardo.
LA TESSITURA E I MERLETTI
I più antichi esemplari della tessitura a mano umbra risalgono al XII secolo, quando a Perugia si afferm6 la fabbricazione delle "tovaglie perugine", veri e propri capolavori che hanno conosciuto un forte rilancio alla fine dell''800, continuando ad essere prodotti fino ai giorni nostri.
A Città di Castello si producono ancora lini operati a "occhio di pernice" con bande colorate, o il bisso con motivi spolinati, o ancora il "quadruccio umbro".
Basta spostarsi nella vicina Assisi, per ammirare nelle botteghe un tripudio di tessuti lavorati con il "punto Assisi", una tecnica di origine copta fatta propria dagli artigiani locali nel '300.
Il merletto di Orvieto, invece, trae le proprie radici dalla "trina d'Irlanda", poi arricchitasi con motivi di gusto tradizionale e rinascimentale, ispirati ai bassorilievi della facciata del Duomo.
La stessa tecnica, insieme ai merletti al tombolo, è diffusa nell'area del Trasimeno, mentre a Panicale si perpetua da secoli la tradizione del ricamo a mano su tulle, con tecniche originali reinterpretate negli anni Venti nella scuola fondata da Anita Belleschi Grifoni.
IL LEGNO
Come in altre regioni, in Umbria la lavorazione del legno ha due matrici parallele, una rurale, originata dalla necessità di dotarsi di oggetti d'uso quotidiano, ed una "colta" che qui ha elevato la tecnica dell'intaglio fino ai mirabili decori lignei delle chiese e dei palazzi rinascimentali e barocchi.
Oggi, tramontate entrambe queste opzioni, l'artigianato umbro del legno, laddove non ha preso la strada dell'industrializzazione, guarda alla tradizione nelle specializzazioni del restauro e dei mobili in stile (in particolare, madie, tavoli, cassettiere e specchiere, spesso finemente intarsiate e dorate) dando vita a botteghe e laboratori sparsi un po' ovunque, con significative concentrazioni a Città di Castello, Todi, Gubbio, Assisi e Perugia.
IL FERRO E IL RAME
La forte presenza del ferro battuto come elemento, ora strutturale, ora decorativo, negli antichi palazzi dell'Umbria, testimonia come questa lavorazione fosse qui
ampiamente diffusa fin dal Medioevo. Testimonianza oggi rinnovata dalle tante officine di fabbro che si incontrano nella regione, soprattutto ad Assisi, a Città della Pieve, nei paesini intorno
al Trasimeno e nello Spoletino.
Accanto a questa attività principale, però, si sono sviluppate produzioni specializzate, e talvolta curiose, come quella delle armi antiche di Gubbio, oppure le lime e
le raspe di Villamagina e i ferri chirurgici realizzati a Norcia fin dal Cinquecento.
Non manca, ovviamente, un diffuso artigianato della battitura del rame che, un tempo, era diffuso un po' in tutta la regione. Oggi, le migliori botteghe si concentrano
a Magione, sul versante perugino del Trasimeno, dove i maestri ramaioli eccellono nella produzione di prodotti martellati, incisi o lavorati a sbalzo.

L'ARTE DEL NORCINO
L'abilità dei salumieri di Norcia è così antica e raffinata che ormai, in tutta Italia, il termine "norcino" si è svincolato dalla sua connotazione geografica ed indica unicamente il livello più elevato di quella professione.
In realtà, l'arte di trasformare le carni del maiale in una serie infinita di leccornie è ormai un tratto genetica degli abitanti di Norcia, di cui vale la pena approfittare. L'eccellenza della loro professionalità la esprimono nella preparazione del prosciutto "antico" di Norcia.
Per ottenere i massimi livelli di qualità, il maiale viene ucciso dal norcino ai primi freddi autunnali, in un contesto dalle forti connotazioni rituali. Una volta sezionato, il prosciutto viene rifilato, conferendogli la caratteristica forma a pera, quindi salato a secco e fatto riposare per tre settimane.
Dopo averlo lavato con acqua e vino, il coscio viene aromatizzato con pepe e aglio, stuccato con un impasto di strutto e farina e posto a stagionare in un ambiente umido e fresco.
L'intero ciclo di lavorazione si protrae per quasi due anni, con risultati che compensano ampiamente una così lunga attesa.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
L'artigianato umbro è così ben integrato nel tessuto urbano delle cittadine d'arte della regione che non necessita certo di eventi ad hoc per mettersi in mostra. È forse per questo che assistiamo al predominio delle grandi mostre antiquarie, qui davvero degne di portare questo nome.
Da non perdere, comunque, il mercato delle Gaite di Bevagna, dove ogni anno gli artigiani si sfidano in un vero campionano dei lavori del passato, l'illuminante panorama sulle nuove tendenze offerto a Gualdo Tadino dalla mostra-concorso della ceramica e l'esauriente Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato di Todi.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente