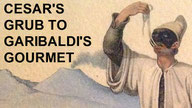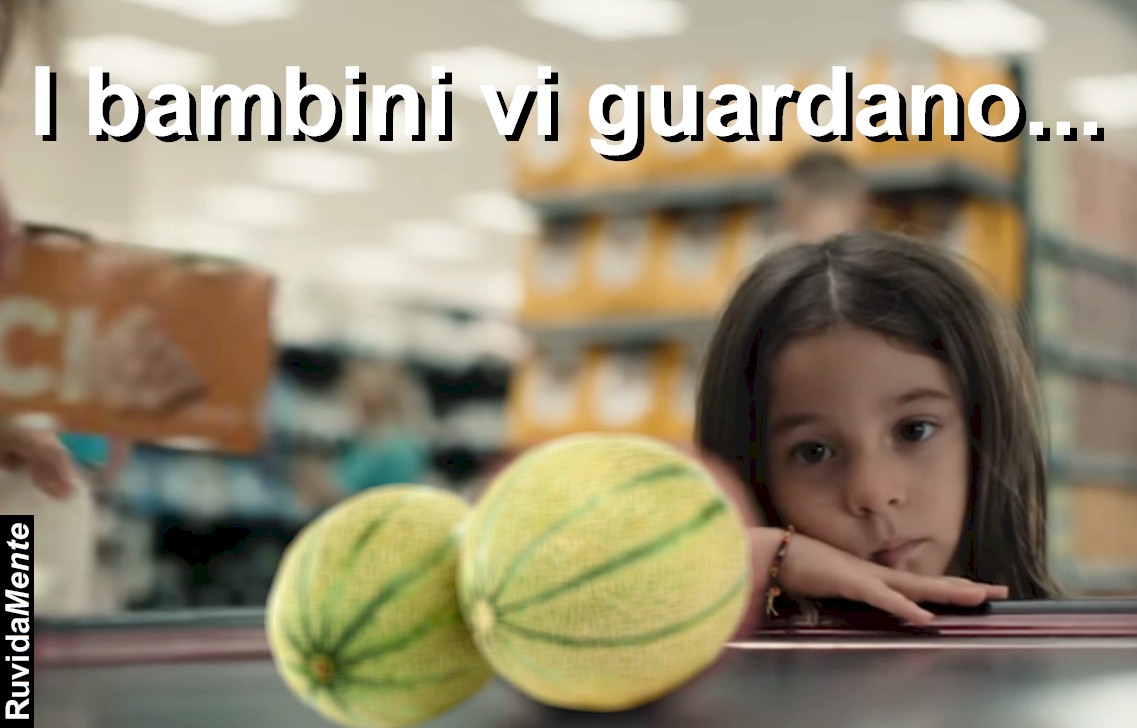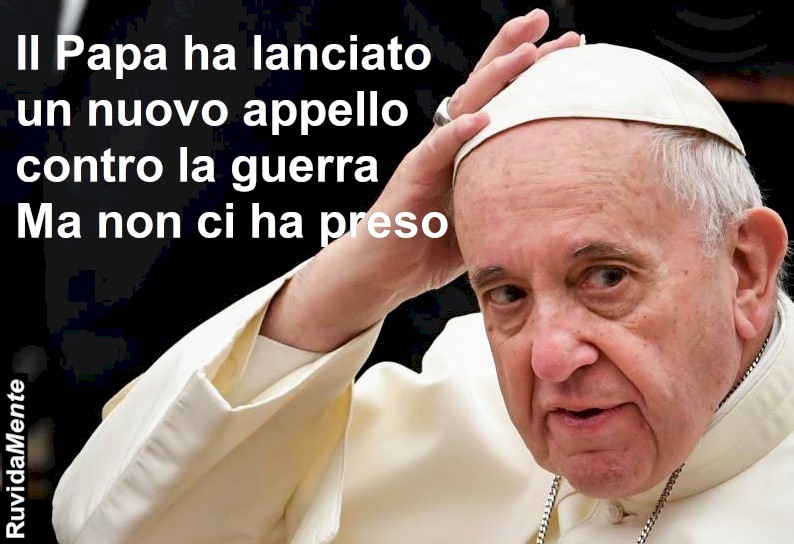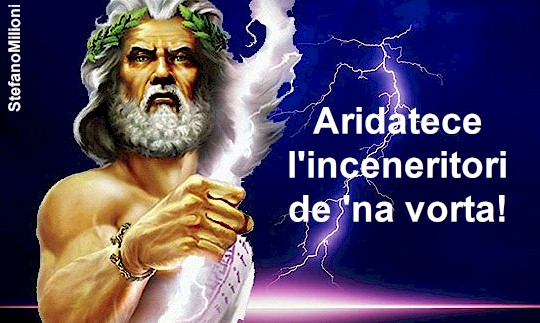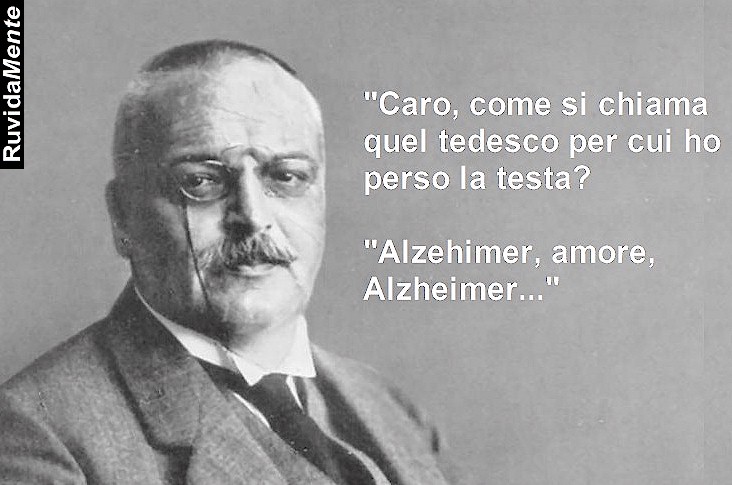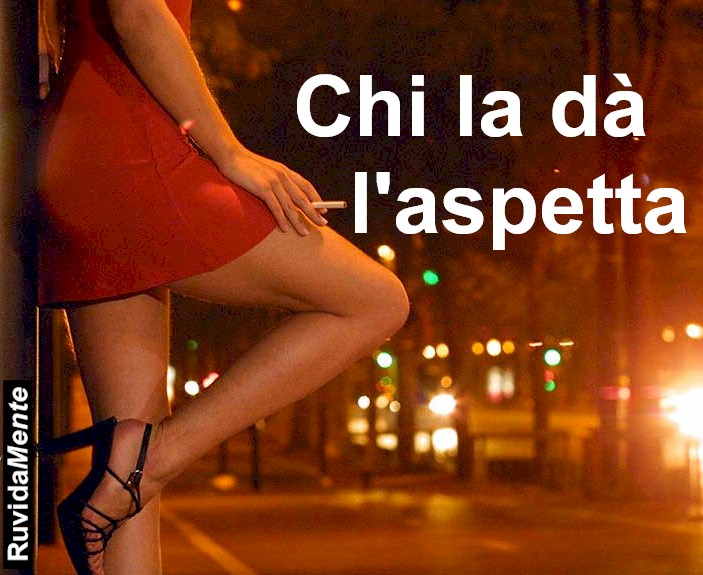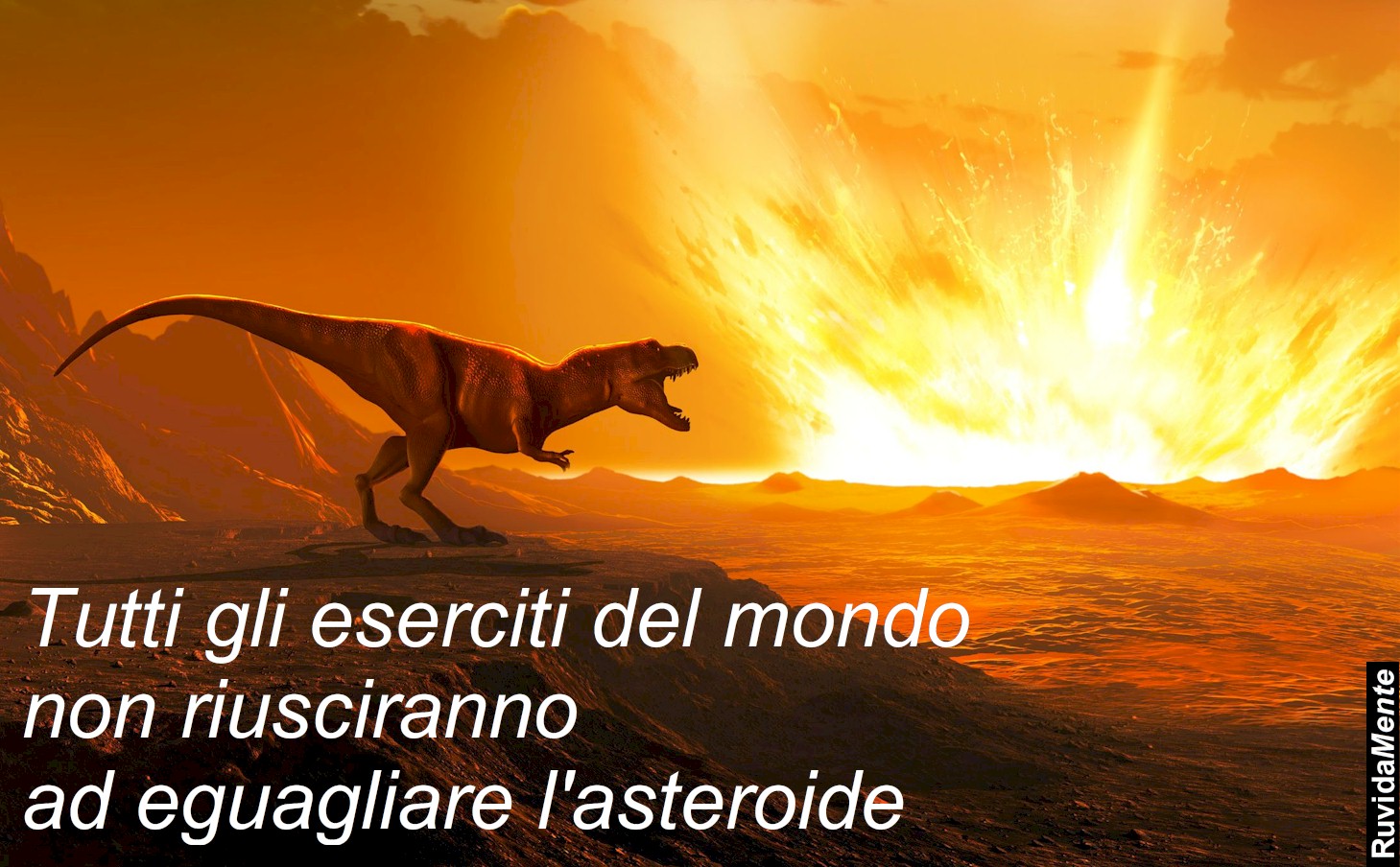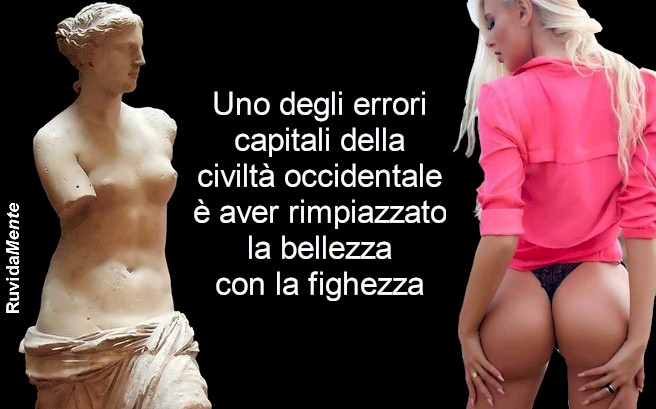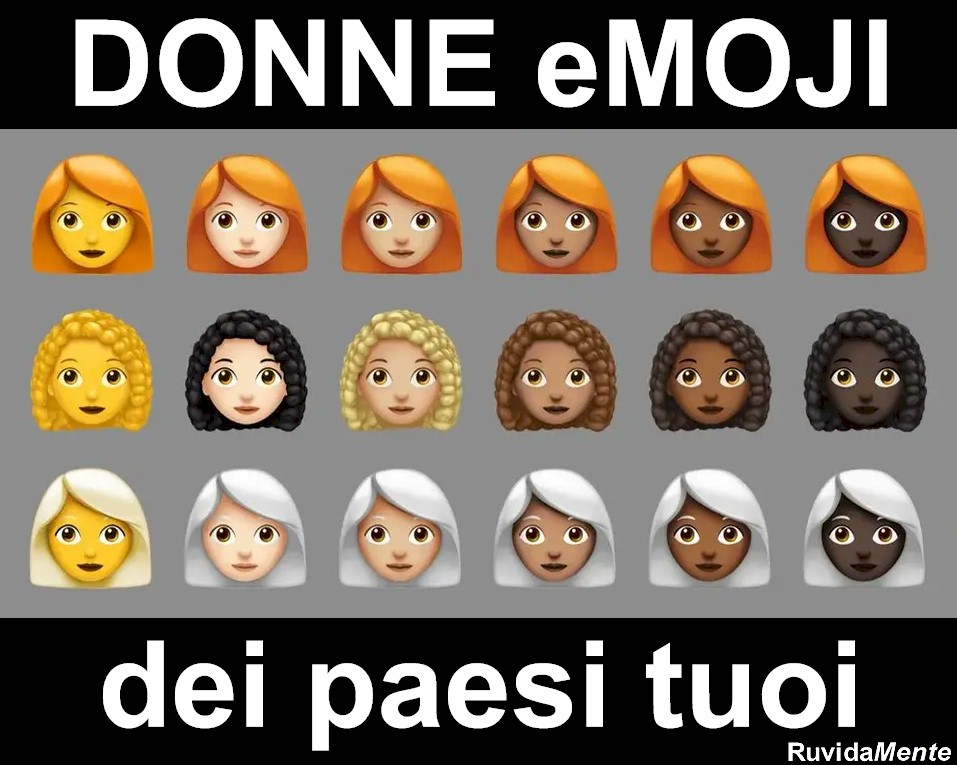Piccolo scrigno montuoso tra Francia, Svizzera e Italia, la Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana; una regione dalla fisionomia e la personalità ben spiccate, orgogliosa della sua autonomia ed individualità.
IL TERRITORIO
La regione, preminentemente montuosa, è racchiusa tra le Alpi Graie e Pennine ed è
coronata dai gruppi montuosi più alti dell'intero arco alpino: a nord il Monte Bianco (4.810 m), il Monte Rosa (4.633 m) ed il Cervino (4.482 m), mentre a sud si chiude idealmente con il
massiccio del Gran Paradiso (4.061 m). Le superfici di questi massicci, coperte quasi esclusivamente da ghiacciai, contano 140 piccoli laghi, quasi tutti d'origine glaciale, sparsi fino ai 2.800
metri.
Incastonata tra questi monti, scorre la Dora Baltea che determina una valle principale, lunga circa 100 chilometri, verso la quale convergono una serie di piccole vallate laterali e numerosissimi
valloni che frazionano ulteriormente la struttura della regione.
Il clima della regione varia molto di valle in valle, a seconda delle esposizioni al sole. In generale regna comunque un clima di tipo continentale-alpino con l'inverno
particolarmente lungo e freddo, e breve stagione estiva caratterizzata da elevate temperature.
L'apertura dei trafori del Monte Bianco e del San Bernardo, oltre al miglioramento delle vie stradali e ferroviarie, ha favorito lo sviluppo di un'industria turistica
notevolissima, che costituisce oggi una delle attività più fiorenti in Valle d'Aosta.
L'agricoltura viene praticata ovunque possibile: soprattutto nel fondovalle, dove si trovano colture cerealicole e fiorenti vigneti; le zone superiori hanno invece un
tipo di economia silvo-pastorale.
LA STORIA
I primi insediamenti umani in Valle d'Aosta ebbero luogo in epoca neolitica, principalmente nella vallata centrale; ne sono testimonianza le necropoli di Montjovet,
Saint-Nicholas, Villeneuve.
In seguito la valle fu abitata dal popolo dei Salassi, fino all'inizio dell'era cristiana, quando venne conquistata dai Romani, attirati dall'importanza strategica
della regione quale trampolino verso il territorio dei Galli. Gli scontri con le legioni romane furono ripetuti e la regione non fu di facile assoggettamento. Nel 143 a.C., nella piana di
Verolengo, le truppe del console Appio Claudio subirono una dura sconfitta, presto riscattata.
Ma la conquista definitiva avvenne per ordine di Augusto, nel quadro della più vasta azione intrapresa per domare tutte le "gentes" alpine. E fu il console Terenzio
Varrone Murena che nel 25 a.C. portò a termine l'impresa e fece edificare, all'incrocio delle strade per l'Alpis Graia (Piccolo San Bernardo) e l'Alpis Pennina (Gran San Bernardo), ossia alla
confluenza del fiume Dora con il torrente Buthier, la città di Augusta Praetoria da cui è derivato il nome Aosta. Altre testimonianze ci rimangono di quell'epoca: ponti, strade, acquedotti.
Nel Medioevo la regione divenne teatro di dispute violente tra feudatari e uomini di chiesa; il territorio venne spartito dai signori locali, tra i quali la nota
famiglia degli Challant, che la travagliarono con le loro lotte intestine. Passò in seguito sotto il dominio dei Goti, dei Franchi, dei Longobardi, dei Duchi di Borgogna finché, nel IX secolo,
non divenne un feudo dei Savoia. Passata ai Savoia, la valle ottenne più volte delle concessioni di autonomia, a cui il popolo ha sempre aspirato in virtù delle particolari condizioni
geografico-sociali.
L'autonomia della regione, nello Stato Italiano, è stata sancita dopo la seconda guerra mondiale, e confermata dal riconoscimento ufficiale di bilinguismo, italiano e
francese.
L'ARTIGIANATO TIPICO
L'artigianato tipico della Valle d'Aosta affonda le sue radici nella civiltà contadina delle Alpi. Il tradizionale stile di vita dei montanari implicava per ciascuno di
essere al tempo stesso agricoltore ed allevatore, al fine di sfruttare al meglio le risorse limitate di un territorio avaro, e di diventare in caso di necessità anche artigiano, dato che i
mercati cittadini erano distanti e i prezzi alti in rapporto alle limitate disponibilità finanziarie. Da qui la necessità di produrre direttamente a casa propria, per quanto possibile, gli
attrezzi necessari per il lavoro dei campi e l'uso domestico.
Innumerevoli generazioni di contadini-artigiani hanno così elaborato, attraverso i secoli, molteplici tecniche per sfruttare in modo ottimale alcuni prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento - la canapa, la lana e il cuoio - e per utilizzare al meglio materie prime come il legno e la pietra che la natura offriva in quantità abbondante. Senza
dimenticare inoltre che un importante attività mineraria forniva ai fabbri della regione ferro e rame di eccellente qualità.
L'artigianato valdostano, fiorente per secoli, conobbe una grave crisi nell'Ottocento per l'introduzione nella regione, fino allora caratterizzata da una economia in
gran parte di tipo autarchico, di prodotti industriali a prezzi concorrenziali. Questo, però, non ha fortunatamente portato alla completa sparizione dell'artigianato locale: essendo gli utensili
di prima necessità oramai importati e l'agricoltura meccanizzata, tutti coloro che avevano acquisito competenze e raffinate capacità tecniche, in questi ultimi decenni hanno saputo riconvertirsi
dedicandosi a forme di artigianato d'arte le cui creazioni non cessano di diversificarsi e di raffinarsi.
IL LEGNO
La maggior parte degli artigiani valdostani si dedica alla scultura del legno, tecnica con cui si sono prodotte alcune delle principali opere d'arte della regione, come
gli stalli dei cori della cattedrale e della collegiata di Sant'Orso ad Aosta
Il legno più usato nell'artigianato tipico della Valle d'Aosta è il noce, un'essenza molto diffusa nel passato nei boschi della regione ed ampiamente utilizzata nelle
costruzioni (in particolare per i travi dei tetti e i soffitti) e nell'arredamento. Attualmente gli artigiani usano il noce per realizzare mobili di pregio e sculture figurative. L'acero, invece,
viene utilizzato per realizzare posate e vasellame, ed in particolare le tradizionali coppe per il vino: le "grolles" e le coppe "dell'amicizia". Il cirmolo, legno tenero e facile a intagliare, è
impiegato nella scultura e nei lavori di falegnameria. Il pero, il melo e il bosso, duri e compatti, sono utilizzati per sculture di piccole dimensioni, come anche la betulla, più tenera ma
nodosa; il bosso in particolare è ricercato per la fabbricazione dei "fiollets", piccoli ovoidi utilizzati durante le partite di uno sport popolare locale che porta lo stesso nome.
Dalle esigenze storiche di realizzare mobili e oggetti per la vita quotidiana, utili sia per il lavoro che per la casa, si è giunti oggi ad una grande differenziazione
dei prodotti, riconducibili a generi ben precisi che riportano alla scultura in bassorilievo o a tuttotondo, alla tornitura, all'intaglio o alla produzione di mobili. I prodotti finali, quindi,
spaziano dalla piccola stattuetta intagliata alle maschere, alle figure di animali che hanno significato decorativo e beneaugurale, agli oggetti torniti, alle vere e proprie sculture in cui
predomina l'intento artistico.
Tra le realizzazioni più caratteristiche dell'artigianato del legno possiamo annoverare i "sabots", calzature robuste e confortevoli, economiche, che avevano il
vantaggio di essere calde e asciutte, adatte ai rigori dell'inverno e al fango. Quelli da uomo sono massicci e robusti, quelli da donna più snelli, con il tacco più alto e sottile, mentre quelli
destinati ai bambini sono muniti di legacci per la caviglia.
Tra i giocattoli, i più tipici sono "les cornailles", piccole forme di mucche stilizzate dal corpo tozzo, senza gambe, costruite dai bambini in assoluta libertà di
proporzioni. In Valle d'Aosta, tradizionalmente, i giocattoli erano quasi tutti zoomorfi: oltre a mucche e pecore, erano presenti galline dal collo altissimo, i "tata", muli posti su quattro
ruote, gatti, caproni, la cui produzione continua, anche se con funzione puramente decorativa.
Tra i mobili, meritano attenzione le cassepanche o "artson", mobili indispensabili, utilizzati per contenere farina ed alimenti o per riporre il corredo della casa. Con forma esterna di cassone,
all'interno sono dotati di vari scomparti a seconda dell'uso, in alcuni casi anche con nascondigli ingegnosamente mimetizzati, decorati da disegni geometrici o da soggetti religiosi. Oppure le
culle, di modeste dimensioni, un tempo realizzate personalmente dai futuri padri che spesso le regalavano alle spose il giorno delle nozze, sollevate da terra da corti piedi, collegati tra loro
da due assicelle ricurve per assicurarne il dondolio.

Van, Fléyé, Tamis e Larre
Dei tanti attrezzi in legno che utilizzavano anticamente i contadini, oggi si fabbricano ancora scale, rastrelli in frassino con i denti di acero, i "fléyé", attrezzi per la battitura del grano formati da due bastoni di diversa lunghezza (manico e battente) collegati da una striscia di cuoio, I "van", cesti piatti con un bordo rialzato per la setacciatura del grano,i "tamis", setacci a doppio fondo per la setacciatura della farina, il "larre", attrezzo dal lungo manico e con una specie di piccola rastrelliera rotonda per la raccolta delle mele e delle pere, e poi barili, botti, gerle, tinozze e slitte di varie dimensioni per il trasporto del fieno sulla neve.
E poi, ceste e canestri per i più svariati usi, dalla "gorba" per il trasporto e la distribuzione delle sementi nei campi, alla "corbeille" alta e fornita di due coperchi, usata per il trasporto nei campi di viveri e vettovaglie, ai "tsaven" di forma emisferica, usati per raccogliere ortaggi, frutta.

IL FERRO
L'artigianato del ferro forgiato è fiorente in Valle d'Aosta fin dal Medio Evo, quando a Chatillon, già nel XIV secolo, si producevano armi da fuoco. Il capolavoro di
questa tecnica è rappresentato dalla fontana del melograno del castello d'Issogne, forgiata alla fine del XV.
L'attività siderurgica, legata allo sfruttamento delle miniere di magnetite - particolarmente di quelle di Cogne - e alla costruzione di un gran numero di "fusines
forgé", si diffuse dal XVIII secolo fino all'inizio del XIX su tutto il territorio della regione. Gli eleganti balconi in ferro battuto degli edifici della città di Aosta e dei borghi della Valle
testimoniano della abilità dei fabbri valdostani dell'epoca.
La crisi della siderurgia locale, nella seconda metà del XIX secolo, segnò il declino di questo artigianato, che non ha conosciuto alcun credibile sviluppo fin dalla
seconda guerra mondiale. Lo sviluppo dell'arredamento rustico ha favorito una ripresa di queste attività, concentrate soprattutto nella Bassa Valle, che si concentra prevalentemente nella
produzione di serrature artisticamente lavorate, lampadari, portaombrelli, appendiabiti, lampioni, recinzioni e insegne in ferro battuto.
I TESSUTI
Nel Medio Evo l'allevamento degli ovini era molto diffuso, come la coltivazione della canapa , e in ogni comunità, anzi in ogni famiglia, vi era qualcuno in grado di
tessere la lana o la tela.
La tradizione di tessere la lana continua oggi soprattutto nella Valgrisenche, dove anche gli uomini praticano questa attività. Qui si produce il caratteristico "drap", che viene utilizzato
ancora oggi soprattutto come tessuto d'arredamento, grazie alla sua capacità di armonizzarsi facilmente con l'arredamento rustico. Alle tinte unite che caratterizzano le produzioni tradizinali
unita (grigio, nero, blu, porpora), oggi si sono affiancati disegni di fantasia e motivi geometrici.
La tessitura della canapa è limitata alla valle di Champorcher, dove si realizzano camicie, drappi, asciugamani e tovagliati.
Nella valle del Lys, a Gaby, si producono ancora delle particolari pantofole, chiamate "sock", con del tessuto riciclato, a volte ricamate, con le suole di feltro e canapa.
La valle di Cogne, invece, si è specializzata nella produzione di caratteristici pizzi a tombolo (dentelles) in filo di lino, di colore naturale o bianco. I motivi dei
pizzi, realizzati senza l'aiuto di disegni o modelli, si trasmettono da madre a figlia e sono contrassegnati da nomi nel dialetto locale come: "teppa clèire" (zolla di terra chiara), "teppa
teuppa" (zolla scura), "pavioula" (farfalla), "joué de perni" (occhio di pernice), ecc.
La canapa ed il panno, sono insieme con i tessuti importati come il lino, la seta e il panno di Biella, i componenti principali della fattura dei costumi popolari della
regione, in particolare quelli di Cogne, arricchiti dalle caratteristiche "dentelles", e quelli di Gressoney, tipici per i loro ricchi ricami e per la magnifica cuffia dorata, decorata con pietre
dure.
LA PIETRA OLLARE
La pietra ollare, cloroticiste di colore verdastro di origine eruttiva molto diffusa nelle Alpi, compatta e facile da tagliare, è lavorata dall'uomo sin dalla
preistoria. Essa si presta stupendamente a essere sezionata, scolpita e lavorata al tornio.
In Valle d'Aosta la si trova soprattutto nelle valli di Champorcher, Ayas e Valtournenche. La sua caratteristica resistenza al calore la rende particolarmente adatta
come materiale per la fabbricazione di stufe e fornelli, oggi ancora diffuse nella Valtournenche e nella valle di Gressoney.
Gli artigiani utilizzano ai giorni nostri la pietra ollare per realizzare anche statue, pentole, vasi, scrigni finemente lavorati, recipienti dalle fogge più diverse e sculture decorative.
IL CUOIO
Strettamente legato allo sviluppo e al mantenimento dell'allevamento, l'artigianato del cuoio conosce oggi una certa flessione, a causa della diffusione sempre più capillare delle materie plastiche. Attività originariamente di servizio, anche quello del cuoio sta diventando un artigianato d'arte.
Se le bisacce, gli otri, le borracce in cuoio diventano sempre più rare, si trovano ancora dei fabbricanti d'oggetti legati alla tradizione contadina come i collari per le vacche e per le capre artisticamente decorati, i finimenti e le "socques" (zoccoli con la tomaia in cuoio e la suola in legno).
Parallelamente, in questi ultimi anni si è sviluppata la produzione di articoli di abbigliamento, quali cinture, borse, portafogli e calzature.

LA GASTRONOMIA
Una cucina sostanziosa e genuina, rustica e generosa, per gente forte delle Alpi, a base di burro, latte, formaggi, salumi, carne bovina, cacciagione e pane di segale,
condita da aromi alpestri, e completata da profumati dolci di forno.
Questi gli elementi fondamentali di una cucina che ha poche specialità, ma estremamente caratterizzate. Alcune sono state cedute al
vicino Piemonte, altre, riprese da esso, sono poi state rielaborate fino a creare piatti a se'. Sono tutti piatti che acquistano ancora più sapore se gustati sul posto, non solo per la genuinità
delle materie prime adottate, ma anche per la loro sintonia con l'ambiente, il paesaggio, i deliziosi ristoranti di legno rustico, decorati con oggetti di arte popolare.
Tra i primi piatti, la famosa zuppa valpellinense, il minestrone alla cogneinze, le dense minestre col pane di segale, la minestra di latte, riso e castagne, la
polenta, i raviolini, gli gnocchi alla fontina. Tra i secondi, oltre alla classica costoletta alla valdostana impanata con fontina, ormai diffusa in tutta Italia, sono da citare la carbonade con
la polenta, la testina di maiale aromatizzata, la trota di torrente spaccata al burro e le preparazioni di cacciagione in civet.
E poi i deliziosi tipi di salumi: la famosa quanto rara mocetta (carne secca di camoscio, capriolo o stambecco trattata con sale, aglio, lauro, rosmarino e salvia); le
"saucisses" (salsicce di carne mista suina e bovina aromatizzate con aglio, lauro e chiodi di garofano); i "boudins" (salsicciotti preparati con sangue di maiale, patate bollite, lardo e spezie);
il salame di camoscio; i prosciutti (prelibato quello di Bosses); il lardo di Amad, i funghi di bosco e l'infinita varietà di formaggi.
E per finire mele, pere e frutti del sottobosco. E miele squisito. Tra i dolci, le tegole di Aosta, i torcettini di Saint Vincent, la crema alla panna chiamata "blanc
manger".
A conclusione del pasto un buon "caffè valdostano", bevuto in comune dalla grolla di legno: vino rosso bollente, con poco caffè rinforzato da grappa, zucchero, buccia
di limone, spezie.

LA GRANDE TRADIZIONE DEI FORMAGGI
Il formaggio più conosciuto della Valle d'Aosta, ed anche più diffuso al di fuori dei confini regionali, è la fontina, tuttora prodotta con metodi artigianali dai
piccoli allevatori e conferita alle cooperative solo per la maturazione o per la commercializzazione. Sull'origine del suo nome i valligiani sono divisi: una parte sostiene che derivi da Fontin,
alpeggio sito nel comune di Quart, mentre altri sostengono che ci si deve rifare al villaggio Fontinaz, nelle vicinanze di St. Marcel.
La tradizione dei formaggi valdostani, però, non si ferma alla fontina, e chi vaga per queste valli avrà l'ooportunità di avvicinarsi a piccole produzioni di grande
pregio. Dopo la fontina, il formaggio più diffuso è la "toma", prodotta con latte vaccino non sottoposto a fermentazione, dalle caratteristiche diverse da zona a zona: le tome della Valgrisanche,
sono magre, molto aromatiche e profumate; quelle di Bruson, cono vendute sia fresche che stagionate; le tome di Gaby e Issíme, che si rifanno alla toma di Gressoney, sono di forma cilindrica,
normalmente stagionate per sei mesi, con gusto tendente al piccante che è più deciso quando la toma si fa davvero vecchia.
Presso gli stessi produttori è possibile trovare la "tometta", una toma di dimensioni ridotte, con le stesse caratteristiche, ma commercializzata più fresca e di pronto
consumo, ed il "tomino", fresco e di piccole dimensioni, spesso conservato sotto sale con pepe e peperoncino.
Da non perdere, un assaggio di "Serass", la ricotta valdostana così chiamata dal latino "seracium", che anticamente veniva prodotta come un tempo in due modi diversi, a
seconda delle stagioni: in estate un tipo dolce, detto "del fen", cioè del fieno, ed in inverno con sapore leggermente piccante.
Utilizzando come base la ricotta grassa, nella zona di Gressoney si produce il "salignon", formaggio affumicato ottenuto setacciando e mescolando alla pasta una buona
dose di paprika con la ricotta grassa, cui si affianca un tipo fresco, ottenuto impastando la ricotta, oltre che con paprika, con aglio e sale.
Per chi ama i sapori delicati, infine, è consigliabile andare alla ricerca del "reblec", ottenuto con la panna di affioramento del latte vaccino riscaldata e quindi
cagliata. È un formaggio dolce e molto delicato e in genere viene consumato immediatamente, sia al naturale che addolcito con una spruzzata di zucchero e di cannella.

I SALUMI
Per i montanari, la conservazione delle carni era un'attività relativa ala sopravvivenza prima ancora che al gusto. Questo, comunque, non ha impedito che, grazie anche
alla disponibilità di una eccellente materia prima, si raggiungessero vertici gustativi eccelsi che permetterebbero a questi prodotti di dilagare nelle tavole raffinate di tutto il mondo, se solo
vi fosse disponibilità di quantitativi sufficienti di prodotto. Invece, chi vuole approfittare di queste delizie deve vagare per la Valle ed affacciarsi direttamente ai laboratori di questi
artigiani.
Il principe dei salumi tradizionali, è lo Jambon de Bosses, prodotto nel territorio dei comuni di Saint Rhémy e Bosses impiegando unicamente cosce di suini di razza
pregiata locale, sottoposti ad un regime alimentare assolutamente naturale. Dopo un trattamento manuale che prevede la conciatura con un composto a base di sale, pepe macinato e in grani, salvia,
rosmarino, aglio, ginepro, timo e alloro, si passa aduna stagionatura che si prolunga per 18-24 mesi, spesso nei "rascards", costruzioni di legno degli alpeggi, che fungono anche da fienili, e
che si trovano circa a 1800 metri di altezza
Di grande pregio, è anche il "Lardo di Arnad", prodotto nella zona omonima, nella bassa Valle, tra Verres e Bard. La tecnica tradizionale prevede che il lardo, rifilato
e privato della cotenna, venga posto in un recipiente di vetro o di coccio e ricoperto, a strati alterni, con sale e erbe aromatiche. Dopo tre strati il lardo viene interamente ricoperto con
acqua (bollita con sale e aromi e raffreddata), chiuso con un coperchio fermato da un peso. Dopo tre mesi si può passare al consumo, ma ne esiste una versione dalla stagionatura prolungata (oltre
un anno), ed in questo caso si usano vasi a chiusura ermetica e si copre il lardo con vino bianco.
Tra le leccornie della valle, sempre più difficili da reperire, spicca la "Mocetta", ottenuta ripulendo le carni magre di camoscio (ma si possono usare anche carni di stambecco o di bovino) dei
nervi e dell'eventuale grasso, conciandole con un composto a base di sale, pepe, timo, salvia, alloro, rosmarino e santoreggia sale e aromi, e facendole stagionare appese per ameno tre
mesi.
Chi ama i sapori decisi, infine, non si lascerà sfuggire una assaggio di Boudin (o salame di sanguinaccio) ottenuto amalgamando il sangue del maiale con lardo e patate
bollite, oltre ad un condimento composto di sale, pepe, aglio, cannella, noce moscata, salvia, rosmarino e ginepro. L'impasto viene poi insaccato nel budello naturale del maiale e si può
consumare sia crudo che cotto, fresco o stagionato.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Le numerose fiere dell'artigianato organizzate in tutta la Valle non sono un'invenzione recente, "strumenti di marketing" creati per animare la stagione turistica, ma
il perpetuarsi di momenti d'incontro e di scambio che per secoli hanno rappresentato, per le popolazioni della montagna, l''unica opportunità di rottura dell'isolamento in cui venivano
confinate.
La più importante di queste manifestazioni è la Fiera di San Orso, organizzata ogni anno ad Aosta, a fine gennaio. Le sue origini, che si perdono nella notte dei tempi,
tradizionalmente sono fatte risalire all'anno 1000. La sua prima regolamentazione conosciuta risale al 1243.
Nata per favorire gli scambi degli oggetti agricoli, tessuti e qualsiasi altra merce di prima necessità o di lusso - fatta eccezione per il bestiame - tra i valdostani e gli abitanti delle
regioni circostanti, (Savoia e Vallese in special modo), essa riunisce oggi tutti gli artigiani della Valle, che presentano qui la loro migliore produzione.
La fiera si sviluppa nel vecchio borgo di Sant'Orso, all'entrata occidentale della città vecchia. Il suo cuore è la piazza della Porta Pretoria, dove sono esposti gli
attrezzi agricoli in legno (il tipo di merce più antico) e i capolavori degli scultori unanimemente riconosciuti come migliori. Nelle vie Sant'Anselmo e Porta Pretoria sono numerosissimi i banchi
degli artigiani del legno, della canapa, del tessuto, dei pizzi, del ferro battuto e della pietra ollare.
Sulla piazza E. Chanoux si possono visitare gli stand dei mobilieri e delle scuole di scultura, che in questi ultimi anni si sono moltiplicate su tutto il territorio
valdostano. Nelle piazze e nelle vie circostanti vengono esposte le macchine agricole e i prodotti dell'artigianato in generale (vasellame, patchwork, lavori a maglia, ecc.).
Il numero di espositori, in questi ultimi anni, ha subito un notevole incremento costringendo la fiera ad espandere i suoi spazi in quasi tutti i quartieri del centro
storico della città.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente