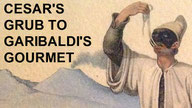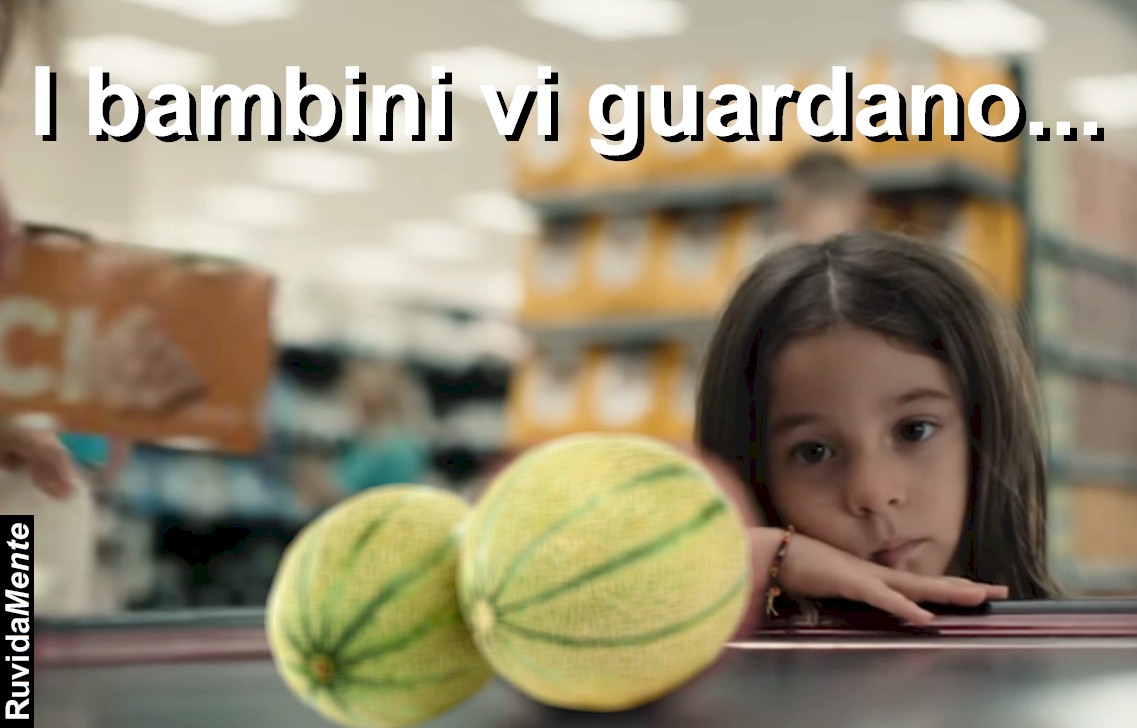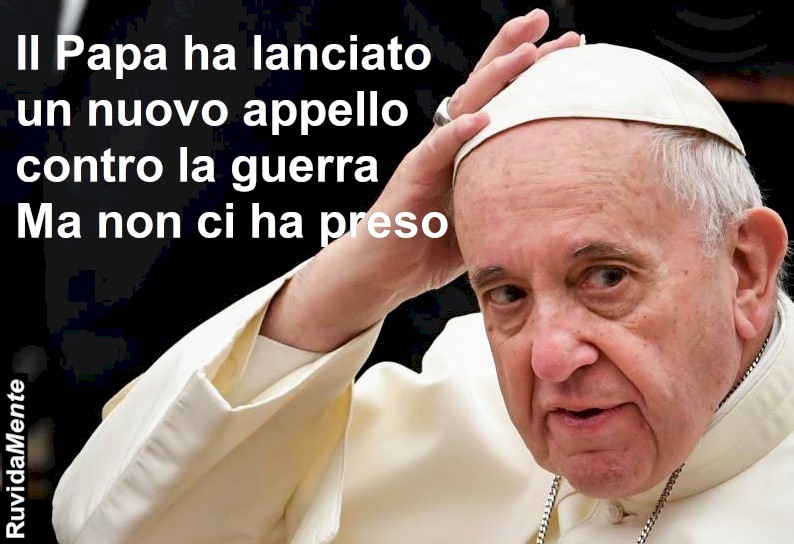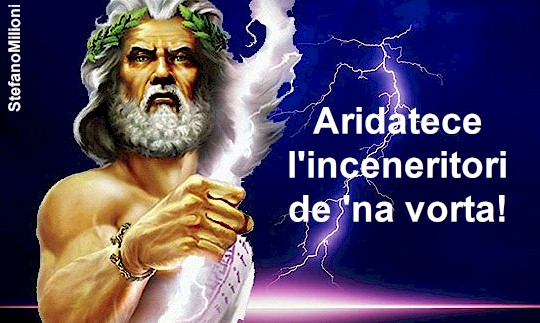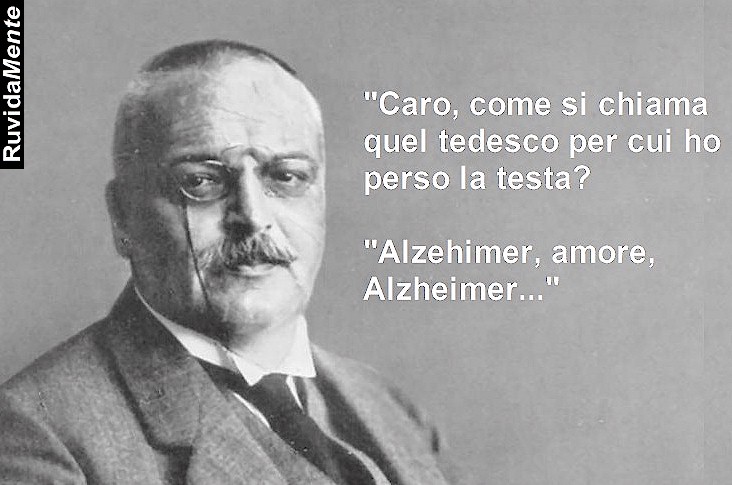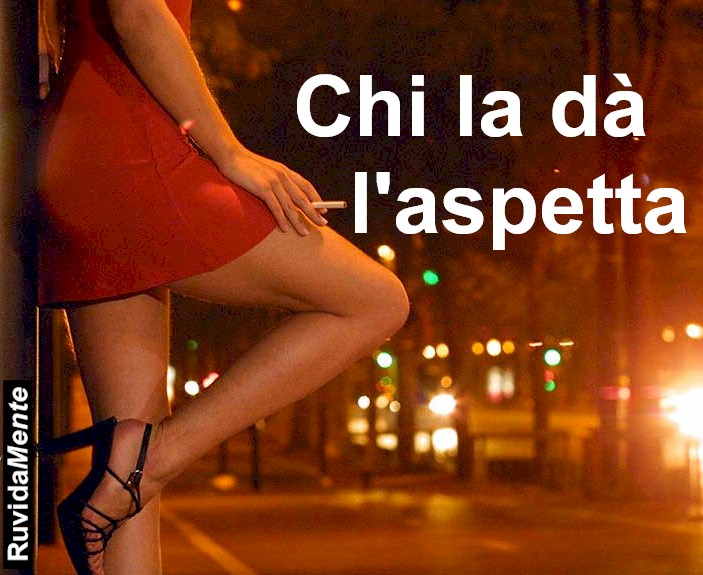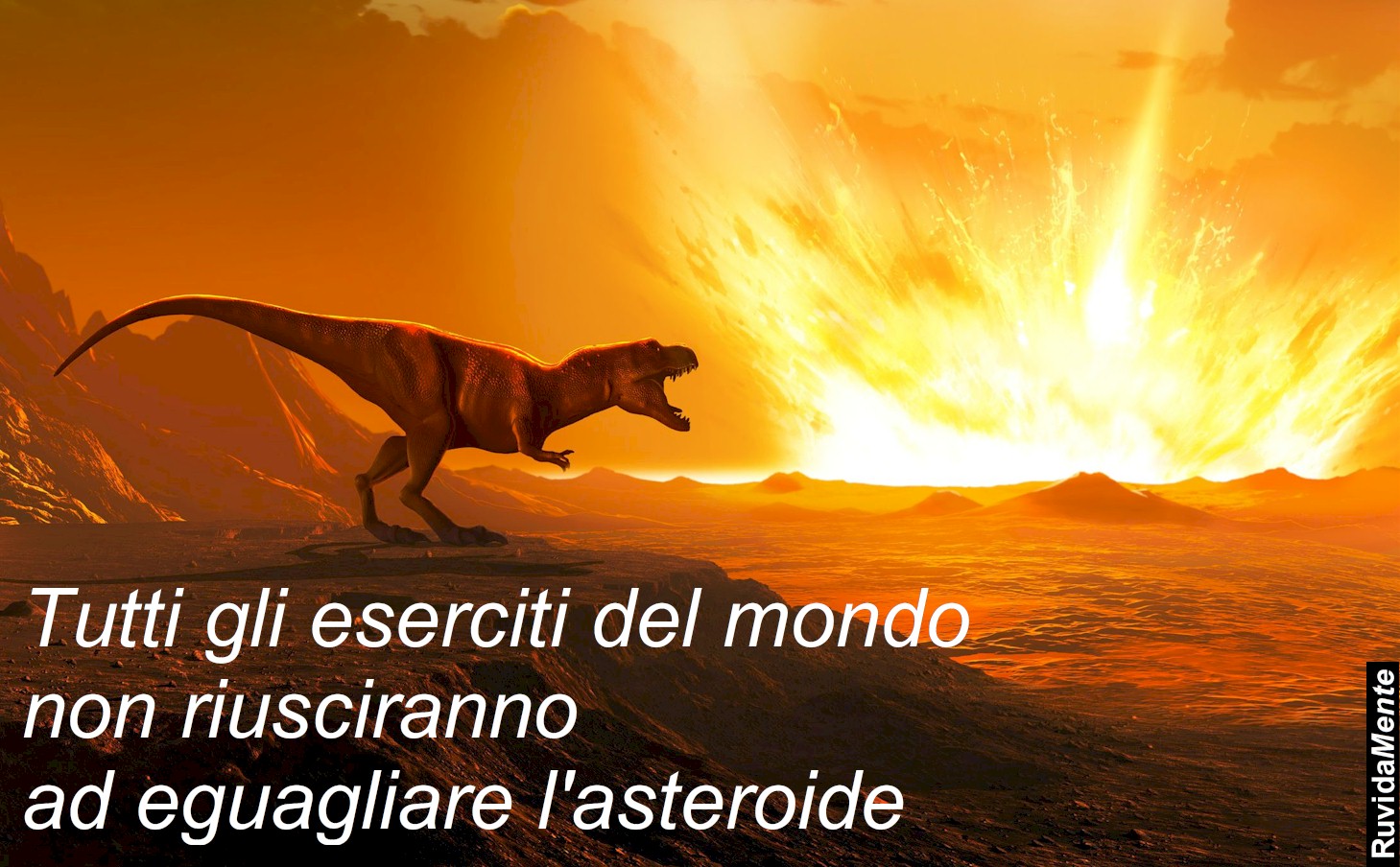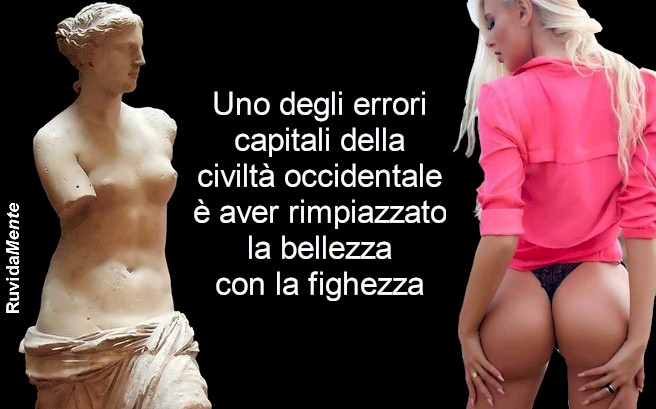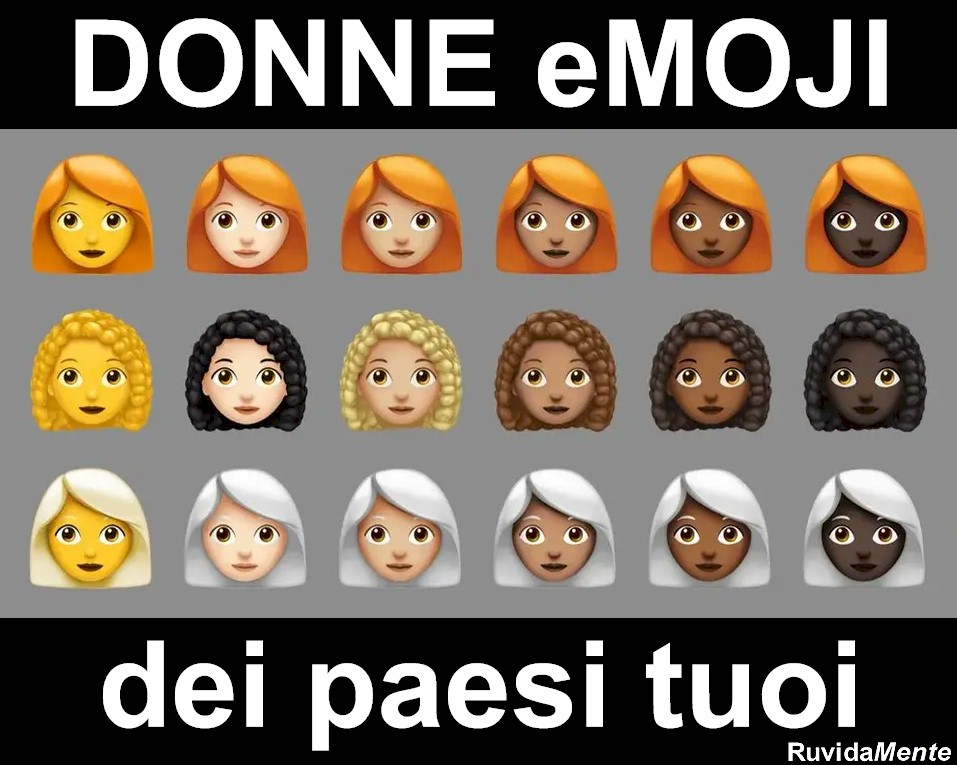La potenza, lo splendore e la raffinatezza espressi nel corso dei secoli dalla Serenissima hanno condizionato e caratterizzato lo sviluppo dell'artigianato di tutta la regione, finalizzandolo in modo pressoché totale alle commesse provenienti dai palazzi veneziani.
La continua richiesta di prodotti nei settori dell’oreficeria, dei tessuti, dei ricami, del vetro, dell’ebanisteria, della ceramica, e così via, determinò lo svilupparsi, sia nelle botteghe affacciate sulle calli che nell'entroterra, di un sistema artigianale integrato dove le varie professioni diventavano funzionali l'una all'altra, con evidenti effetti benefici sulla qualità finale dei prodotti.
Il tanto decantato sistema produttivo del Nord-Est, altro non è che l'evoluzione industriale di questa grande tradizione artigianale che rimane tuttora alla base di un comparto i cui punti di forza rimangono la creatività, l'operosità e l'abilità tecnica dei singoli, intesi oggi più come piccole entità aziendali che come gli operatori individuali, affascinanti ma ormai sorpassati, del passato.
IL VETRO
La concentrazione di vetrerie nell'isoletta di Murano non è dovuta a nessuna delle ragioni che, usualmente, determinano la nascita di un
distretto artigianale. Fu una decisione presa nel 1295 dai governanti veneziani preoccupati dal pericolo di incendi costituito dalle fornaci vetrarie. Fino a quel momento, e fin dal IX secolo, il
maggior centro dell'arte vetreria italiana era proprio Venezia, dove queste produzioni erano giunte da Aquileia, città in cui l’artigianato del vetro era già ampiamente presente in epoca romana e
si era poi sviluppato accogliendo suggestioni provenienti dall’Oriente attraverso Bisanzio.
La produzione delle vetrerie di Murano è ancora interamente artigianale, con processi produttivi così spettacolari che la visita alle fornaci è diventata una delle mete
turistiche obbligate della laguna.
Oggi, la gamma delle produzioni è vastissima. Agli oggetti classici, quali vetri “a smalto”, “a ghiaccio”, vetri incisi e filigranati; coppe, bottiglie, specchi,
cornici, figure di animali reali e fantastici, lampadari, vasi, bottiglie e calici, realizzati con le forme della tradizione, le botteghe hanno affiancato una produzione di elementi di arredo di
altissima qualità, nati dalla collaborazione con designer e artisti di fama internazionale che hanno permesso all'artigianato del vetro veneziano di espandere i suoi orizzonti commerciali in
segmenti di mercato impensabili solo trent'anni fa.
I MERLETTI
Sviluppatosi qua e là nelle isole della laguna, forse come sublimazione femminile della tecniche utilizzate dai pescatori per fabbricare le reti, l’artigianato dei
merletti si perpetua da secoli a Venezia ed ha conosciuto i suoi momenti di massimo splendore tra il XVII e il XVIII secolo, quando essi erano un elemento immancabile e qualificante dell'abito
maschile.
Dopo aver superato momenti di disaffezione, determinati per lo più dal fluttuare delle mode, l'artigianato del merletto è tornato ad essere un'attività molto vivace,
soprattutto nell'isola di Burano, dove ancora oggi le merlettaie lavorano in piccoli gruppi davanti alle porte delle loro case perpetuando una tradizione la cui sopravvivenza è strettamente
legata ai grandi flussi turistici e all'attività di stimolo della scuola locale, ospitata nel palazzo del Podestà, cui è annesso un interessantissimo museo che raccoglie gli esemplari più
straordinari della produzione locale.
Oltre che a Burano, specializzata nella lavorazione ad ago con punti originali creati localmente (punto Venezia, punto Burano, punto cappa, punto a roselline, ecc.)
l’arte del merletto è praticata diffusamente anche a Pellestrina, dove la trina è lavorata al fusello e al tombolo, e a Chioggia, dove si lavora il filet.
LE MASCHERE
Il recente rifiorire del carnevale di Venezia ha ridato slancio alla produzione di maschere, un'attività antichissima strettamente legata alla cultura veneta in cui si sono sempre intrecciate le “bautte” indossate dai nobili veneziani nelle feste di un tempo e le classiche maschere teatrali.
Questo vero e proprio boom ha portato alla riconversione di numerosi artigiani che hanno riscoperto antiche tecniche e scovato nei magazzini gli speciali stampi in legno abbandonati da decenni iniziando ex novo la produzione delle antiche maschere in cartapesta o in cuoio lavorato sottilissimo.
Ad essi si sono presto accodati molti giovani che, accogliendo le richieste sempre più stravaganti della clientela, hanno cominciato a introdurre nuovi materiali, spesso accostati a quelli tradizionali, con effetti di grande fascino che hanno permesso alle nuove maschere veneziane di trovare mercato in ogni periodo dell'anno ed imboccare felicemente anche la strada dell'export.
LA TESSITURA E IL RICAMO
Mussolente, in provincia di Vicenza, è tuttora l'epicentro di un vivace comprensorio in cui si pratica la tessitura d’arte su telai a mano e si estende fino alla
provincia di Treviso, da Bassano del Grappa ad Asolo. Qui, applicando tecniche immutate da secoli, si realizzano tessuti pregiati in seta e lana per abbigliamento e arredamento.
Gli artigiani di Asolo, invece, sono specializzati, prevalentemente, nel ricamo su lenzuola, tovaglie, fazzoletti, camicette, con una interessante diversificazione
nella realizzazione degli arazzi, stimolata dall'attività di una qualificata scuola locale.
Risalendo verso le montagne, infine, è facile trovare ancora laboratori dediti alle produzioni tradizionali, come quella degli scialli ricamati di Belluno, o delle
coperte e dei tappeti in patchwork, fiorente nel Cadore.
LA CERAMICA
Il '500 ha rappresentato il secolo di massimo splendore della ceramica d'arte veneta, quando, soprattutto nelle cittadine di Bassano del Grappa e Nove, in provincia di Vicenza, operavano alcuni dei più grandi ceramisti dell'epoca. A partire da quel periodo, si è consolidato uno stile caratterizzato principalmente dai decori, che spaziano dalla rappresentazione delle stagioni e dei mesi attraverso figure della vita contadina alle immagini dei santi e dei profeti, alle nature morte, ai paesaggi popolati di rovine, tipici del Settecento.
Fortunatamente, questa antica tradizione artigianale continua a prosperare ed alimenta un mercato fiorente che predilige, in particolare, boccali, zuppiere, grandi
vasi, soprammobili, acquasantiere e centritavola (molto richiesti quelli interamente smaltati in bianco a foggia di cesti di fiori o di frutta).
Este, in provincia di Padova, è il secondo centro di produzione delle ceramiche artigianali del Veneto. Qui, i primi laboratori sorsero nel '700, imponendosi
immediatamente per gli eleganti decori a sfondo mitologico, tuttora riproposti fedelmente dai numerosi laboratori artigianali ancora in attività.

L'OREFICERIA
I fasti veneziani non potevano non alimentare, nel corso dei secoli, lo svilupparsi di una scuola orafa pronta a fornire capolavori da esibire sia nei luoghi sacri che nei palazzi del potere e della nobiltà, ben articolata in un vasto assortimento di oggetti di culto, vasellame e gioielli. Questa tradizione non ha subito flessioni nemmeno quando il ruolo di Venezia si è ridimensionato e ha trovato un forte impulso in particolar modo a Vicenza che, a partire dall'inizio del Novecento, si è via via confermata come una delle capitali dell'alta oreficeria italiana. Benché forti del bagaglio tecnico e culturale della tradizione veneziana, arricchitasi, gli orafi vicentini hanno dovuto presto mettere da parte i canoni estetici tradizionali e lanciarsi in un rinascimento creativo che permettesse loro di rispondere alle richieste dei più importanti mercati mondiali: una scommessa sull'innovazione che ha dato presto i suoi frutti, collocando questi raffinati artigiani ai vertici del settore.
I METALLI
Basta posare l'occhio sulle raffinate architetture delle ville venete per comprendere immediatamente quali raffinate abilità manuali siano state all'origine delle
cancellate, balaustre e inferriate che le ornano e difendono, tanto robuste nella sostanza, quanto lievi e leggiadre all'aspetto. È una tradizione secolare che oggi si perpetua un po' in tutta la
regione, spaziando fino a oggetti d'arte quali lampadari, candelabri, componenti d'arredo e attrezzi da camino. La maggiore concentrazione di laboratori si riscontra in provincia di Verona (in
particolare a Cogollo di Tregnago, Bussolengo, Dossobuono e Lazise), e in provincia di Treviso (soprattutto a Vittorio Veneto e a Mogliano, dove ha sede l’Accademia internazionale del
ferro).
Meno diffuse, anche se di indubbio interesse, le lavorazioni degli altri metalli. La lavorazione del rame battuto è tipica della zona di Bassano del Grappa e della Val di Zoldo, dove si lavora
anche il bronzo per produrre i “bronzini”, caratteristiche caldaie a tre piedi da usare nel camino. In provincia di Belluno, infine, è tuttora florida la tradizionale lavorazione di oggetti, vasi
e recipienti in peltro.
IL LEGNO
Diffuso originariamente nelle zone di montagna, grazie all'abbondanza di materia prima, l'artigianato del legno è tuttora un comparto vivace, anche se animato più dalla
passione che dalle prospettive di guadagno. Comunque, ancora oggi, in provincia di Belluno, Piai e Tambre d’Alpago sono rinomati per la loro produzione di giocattoli, e Sappada per le sue
caratteristiche maschere in legno scolpito, cui si affianca un vasto assortimento di oggetti decorativi. Sulle pendici del Grappa, invece, l'oggetto intorno a cui ruotano tutte le produzioni sono
le pipe: a Borso del Grappa vengono realizzate in legno scolpito e dipinto, mentre a Bassano si sono specializzati in quelle di fascia alta, in radica pregiata.
La produzione di mobili artigianali, invece, si è spesso evoluta in forme industriali, anche se recentemente si è notato un rifiorire di laboratori che si rifanno alla grande scuola
dell’ebanisteria veneta. Le aree più attive si trovano in provincia di Verona (in particolare a Cerea, Bovolone, Sanguinetto e Salizzole), con forte vocazione alla riproposizione di mobili in
stile, e nel Bellunese, dove prevalgono i canoni estetici dei mobili rustici legati alla tradizione alpina.

L'ASIAGO
Già intorno all'anno 1000 l'altopiano di Asiago era luogo di pascolo per le greggi da cui si ricavava un gustoso formaggio. A partire
dal XVI secolo, la diffusione dell'allevamento bovino e l'attenzione degli operatori hanno dato a questo prodotto regole di lavorazione precise e definite, perpetuatesi per secoli e raccolte poi
nel 1978 nel disciplinare della Doc. L'area di produzione è limitata all'intero territorio delle province di Vicenza e Trento e parte di quelle di Padova e Treviso.
Con l'unico nome di "Asiago", in realtà, si identificano due tipologie di formaggio abbastanza diverse tra loro, il "pressato" e l'"Asiago di allevo". Il primo, di origini recenti, si consuma
dopo una stagionatura di 20-40 giorni e ha sapore dolce e colore bianco leggermente paglierino, mentre il secondo richiede una maturazione che può variare dai tre mesi (e allora viene definito
"mezzano') a un anno e oltre ("vecchio") e ha un gusto più deciso e forte personalità, pasta compatta e granulosa e colore paglierino ben marcato. È detto "di allevo" perché la sua stagionatura
richiede le cure di un vero e proprio "allevamento", condotto con particolare attenzione in appositi locali.
A garanzia del consumatore, su ogni forma di entrambe le tipologie è impresso il contrassegno del consorzio, una sigla di riconoscimento del caseificio e la denominazione.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
In Veneto, il sentimento religioso è diffuso e ben radicato. Non deve stupire, quindi, che molte delle manifestazioni in cui meglio ci si può avvicinare alle più genuine espressioni dell'artigianato tradizionale siano, in realtà, un intreccio di eventi religiosi e commerciali dove la fiera, il mercato, la sagra e la funzione religiosa sfumano una nell'altra senza un confine preciso. Tra le tante, meritano una segnalazione particolare la fiera di SS. Pietro e Paolo, a Villafranca di Verona, che si sta avvicinando alla trecentesima edizione, e la Fiera della Madonna delle Grazie, a Pettorazza Grimani, in provincia di Rovigo, che si tiene puntualmente ogni anno dal 1520 in poi.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente