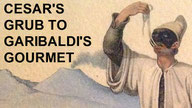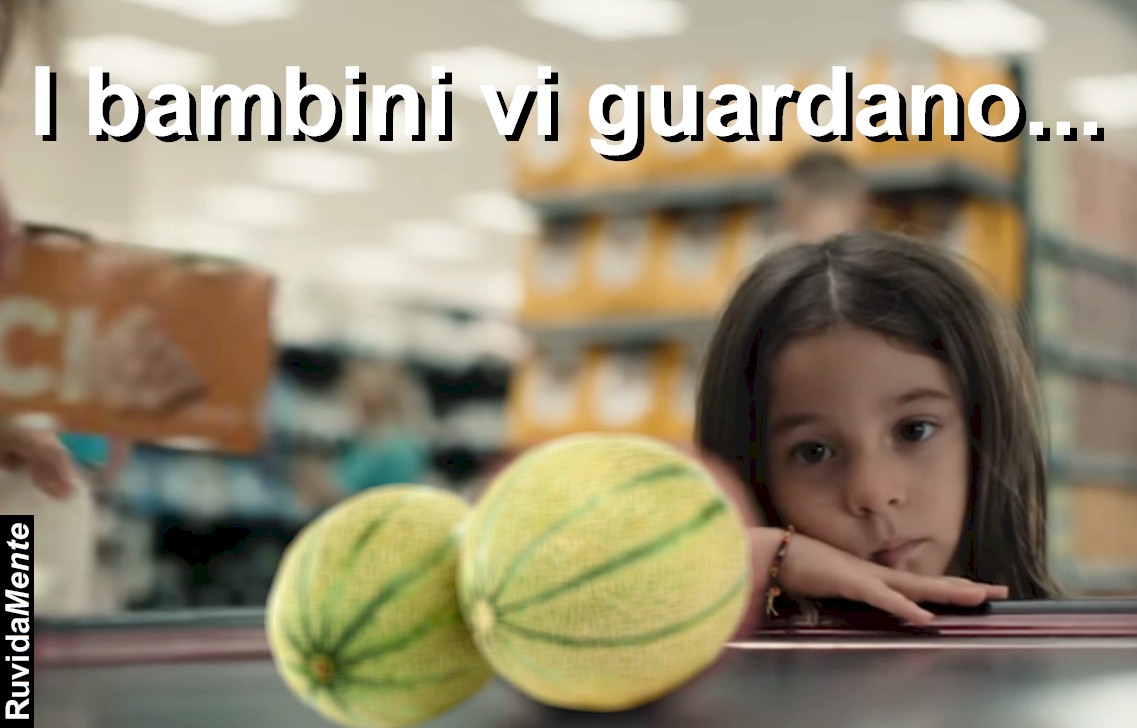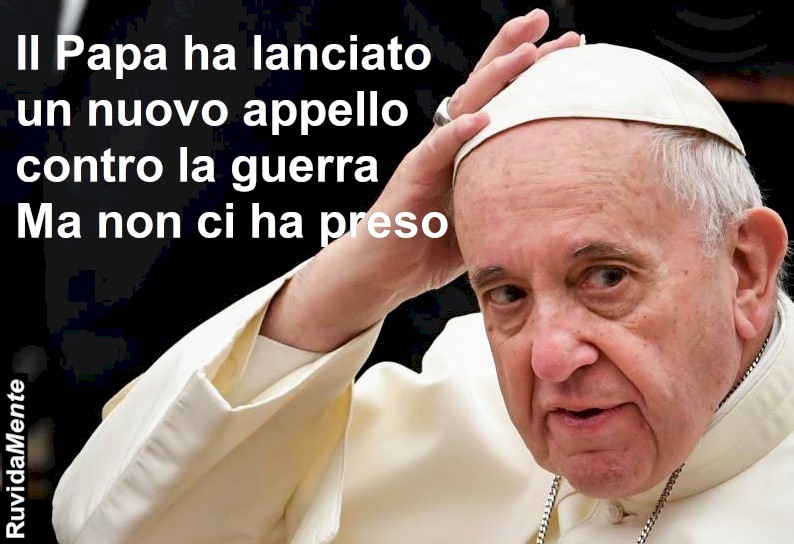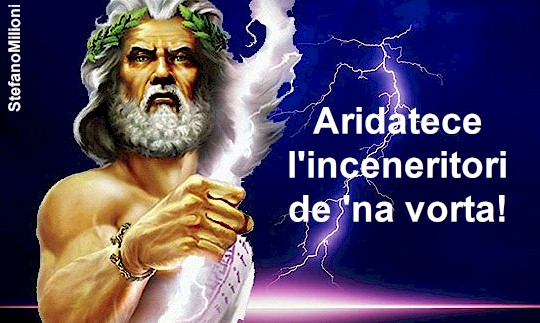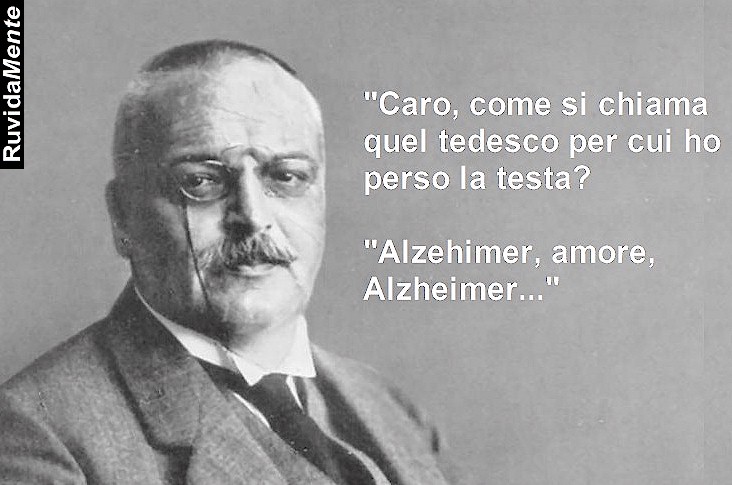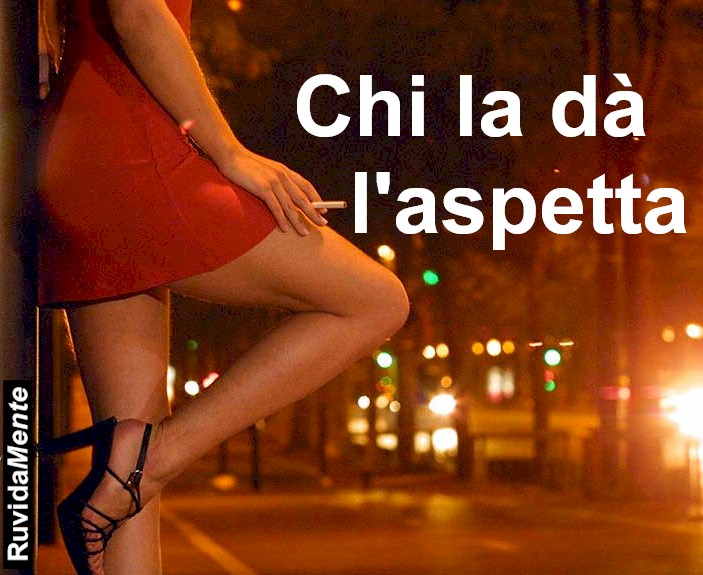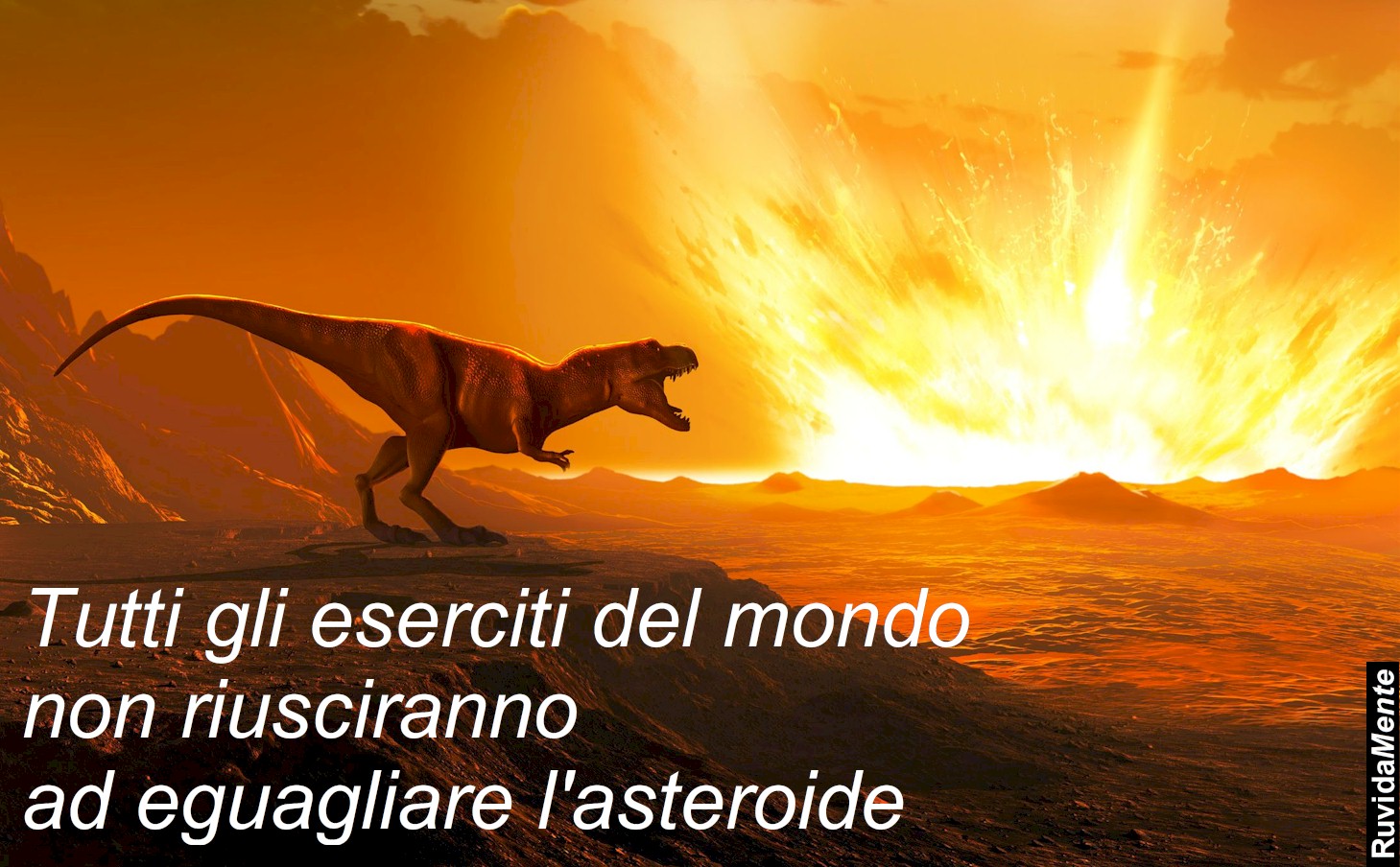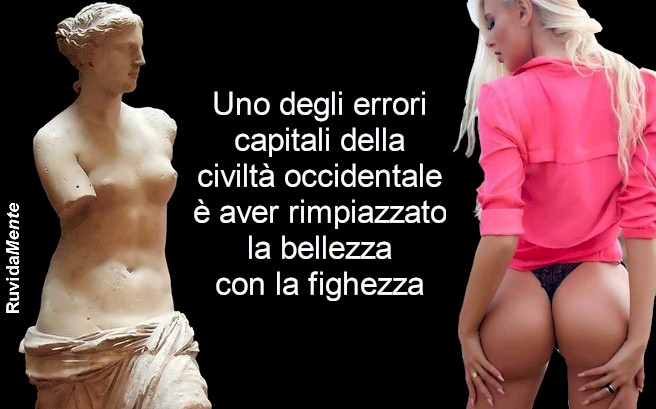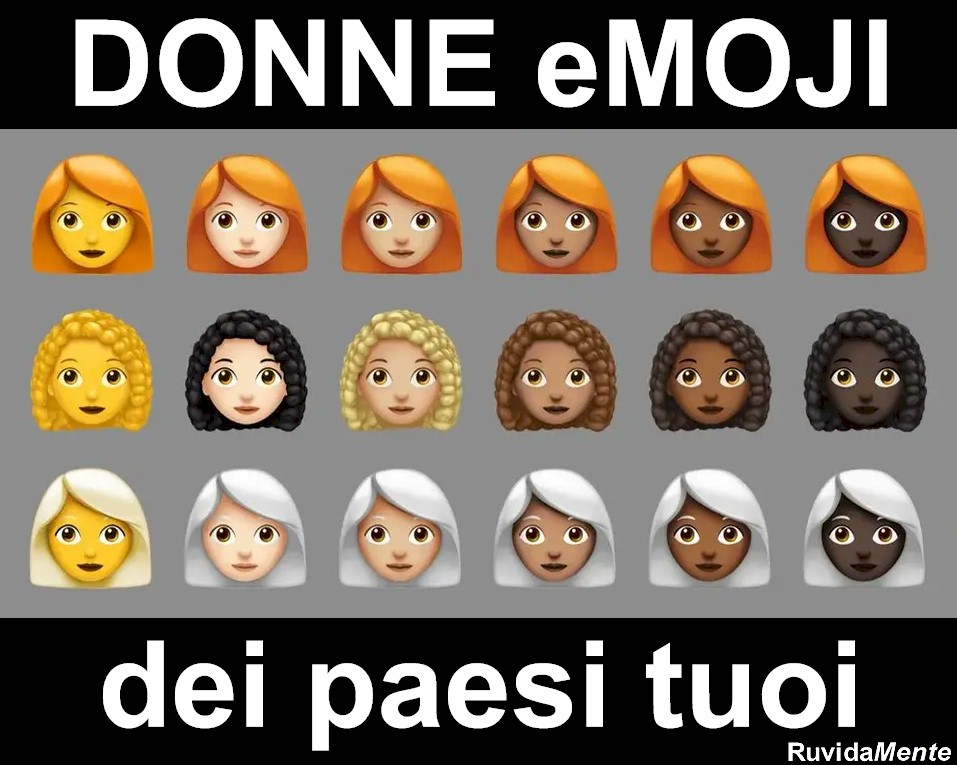Nel corso dei millenni, nel territorio laziale si sono sviluppati parallelamente e senza quasi mai incrociarsi, due distinti filoni di artigianato. Il primo, nobile e raffinato, faceva capo alla Capitale ed era quello che contribuiva a rifinirne le grandi opere perennemente in cantiere, dalla Repubblica, all'Impero, al Papato, al Regno, e di nuovo alla Repubblica.
Le chiese, i palazzi, i monumenti e i giardini che rendono incantevole Roma sono al tempo stesso espressione di grandi artisti e agglomerati di sapere artigianale, arricchitosi nel tempo di una ininterrotta sequenza di apporti esterni, convogliati nella città eterna dai potenti desiderosi di eccellere e lasciare un segno indelebile della loro presenza.
Il secondo, invece, è l'artigianato delle campagne, nato e sviluppatosi in un contesto di estrema povertà, quasi sempre secondario e accessorio rispetto alla prevalente attività agricola, mirato a risolvere i problemi della vita quotidiana e caratterizzato da esiti estetici spesso casuali e involontari, che sono comunque un risultato e raramente una premessa.
Il primo tipo di artigianato prospera ancora, in forme non immaginabili per un normale consumatore, difficilmente accessibile perché impegnato su commessa, ora come nei secoli scorsi.
Per il secondo si potrebbe utilizzare la solita formula del “pressoché scomparso” se, soprattutto nell'ultimo decennio, la crescente domanda di manufatti non industriali esercitata dai consumatori delle città non avesse provocato un generalizzato risveglio tra gli artigiani dei paesini e delle campagne, rimettendo in moto una macchina che si era arrugginita e che, anche sotto la spinta di buone prospettive di reddito, ha ricominciato a produrre pescando a piene mani nel grande serbatoio della tradizione.
LA CERAMICA E LA TERRACOTTA
Per gli antichi Romani, la terracotta era più o meno l'equivalente della nostra plastica: elemento duttile, facilmente formabile e "piegabile" alle varie esigenze dei commerci, perfetta, con piccoli accorgimenti, per conservare e trasportare tutto, dall'olio al vino, al grano, alle spezie, nelle navi come nei mercati e nelle case. Erano oggetti funzionali e rustici, finalizzati unicamente alla soluzione ottimale di un problema.
Questo filone artigianale non si è mai interrotto e ancora oggi, soprattutto a sud di Roma, nelle zone di Pontecorvo, Arpino e Fiuggi, in provincia di Frosinone, si perpetua la produzione di vasi e anfore decorate a freddo con motivi in terra rossa, cui col tempo si è affiancato un assortimento di oggetti in cotto che vanno dai posacenere alle statuine per presepi, alle piastrelle, alle maschere zoomorfe.
Nel nord del Lazio, invece, molto prima che si affermasse la civiltà romana, gli Etruschi si dedicavano alla produzione di ceramiche ben più raffinate, dove la ricerca estetica prevaleva spesso sulla funzione dell'oggetto.
Non è casuale, quindi, che proprio nelle stesse zone, ancora oggi si concentri la maggiore produzione di ceramiche artistiche della regione, in particolare a Tarquinia e Civita Castellana, in
provincia di Viterbo, dove ai laboratori che si dedicano produzione di repliche dei preziosi reperti etruschi, si alternano ceramisti totalmente votati alla ceramica d'arte, svincolata da
qualunque canone artistico del passato.
La provincia di Viterbo, comunque, è in grado di dare soddisfazione anche a chi è in cerca di oggetti più quotidiani.

Nelle zone di Acquapendente, Tuscania e Vetralla sono numerosi gli artigiani dediti alla produzione di terraglie rustiche, quali pignatte, boccali, scolapasta, tegami, vasi ecc., di ottima fattura e dal prezzo assolutamente abbordabile.
I METALLI
I mestoli, i tegami, le casseruole, i pentoloni, le forme per i dolci, un tempo erano realizzati quasi esclusivamente in rame e da artigiani che, quando erano particolarmente bravi, facevano scuola e stimolavano il moltiplicarsi di botteghe analoghe nel loro circondario. Le successive ondate dell'alluminio e dell'acciaio hanno rischiato di cancellare queste raffinate forme di artigianato che hanno ritrovato vitalità solo in anni recenti come reazione alla esasperata standardizzazione dei prodotti industriali.
Lo spostamento di interesse della clientela dagli aspetti funzionali a quelli decorativi ha permesso anche di ampliare l'offerta che oggi si è arricchita di accessori
per camini, soprammobili, vasi da fiori, portaoggetti, fermacarte, posacenere, appendiabiti, che possono ispirarsi alle forme della tradizione come seguire l'estro creativo dell'artigiano.
Se la lavorazione del rame si è perpetuata prevalentemente negli stessi luoghi dove si era sviluppata in passato (e Poggio Bustone, in provincia di Rieti, continua ad
esserne la capitale, con i migliori artigiani della regione, insuperabili nella lavorazione di pannelli a sbalzo, bassorilievi e figure sacre), quella del ferro si è invece diffusa un po' ovunque
con produzioni di qualità concentrate a Tivoli, in provincia di Roma, a Latina, a Pontecorvo, Sora e Alvito, nel Frusinate; ad Antrodoco, in provincia di Rieti, e a Tarquinia e Bolsena, nel
Viterbese.
L'OREFICERIA
Diversamente da tante altre zone, nel Lazio l'arte orafa ha sempre avuto due mercati distinti e separati: uno, classico, concentrato prevalentemente a Roma, legato al
mondo della chiesa, della nobiltà e dei potenti; l'altro, diffuso prevalentemente in provincia, teso a soddisfare le richieste di una clientela popolare che, spesso a dispetto di condizioni
economiche disagiate, difficilmente ha saputo rinunciare, come testimonia anche l'abbondante iconografia ottocentesca, alle stupende collane di coralli, ai pendagli-orecchini vistosi ma eleganti,
alle massicce catene d’oro, agli anelli carichi di "blillocchi" dalle dimensioni esagerate.
Gli artigiani della prima categoria hanno continuato a prosperare, molti operando in una discreta penombra, alcuni trasformandosi in griffe di risonanza mondiale. Gli
altri, sono quasi scomparsi, rimpiazzati da una nuova generazione di orafi i quali, facendo leva ora sulla creatività, ora sull'abilità tecnica che permette loro di produrre straordinarie
imitazioni di gioielli antichi, hanno saputo conquistare la borghesia per poi espandere i propri orizzonti su scala internazionale.
Il maggior numero di questi laboratori di oreficeria si concentra, ovviamente, nella capitale, ma anche in provincia stanno sviluppandosi delle vere e proprie "scuole", in particolare nella zona dei Castelli, ad Albano Laziale, Ariccia e Mentana, a San Felice Circeo, in provincia di Latina, nel Frusinate (soprattutto a Frosinone, Veroli e Fiuggi) e a Tarquinia e Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo.
IL LEGNO
A chi ha vagato per i vicoli del centro storico di Roma, non è certo sfuggita la grande quantità di botteghe dedite al restauro di mobili, cornici e suppellettili in
legno. È un'attività che non conosce flessioni, visto l'enorme patrimonio antiquario accumulatosi nei secoli nei saloni, nelle cantine e nelle soffitte dei palazzi romani.
La realtà più consistente della lavorazione del legno, però, è vitale lontano dalla Capitale, dove dall'inesauribile serbatoio della tradizione popolare si trae
ispirazione per riproporre una variegata gamma di manufatti che spaziano dai pifferi agli ombrelli usati un tempo dai pastori, ai pestasale, ai set di cucchiai, mestoli e forchettoni, fino ai
mobili rustici in tutta la modulazione dei modelli "classici", madie, arche, panche, sedie e tavoli.
Con il tempo, ogni distretto ha sviluppato produzioni specifiche, così, chi è in cerca di sedie rustiche o impagliate si dovrà dirigere a Frosinone, oppure a Cori, in
provincia di Latina, e a Turania, nel Reatino. Il Frusinate (in particolare Vico nel Lazio, Anagni, Boville Ernica, Sora, Arpino, Ceccano, Isola del Liri) è leader anche nella produzione di
mobili rustici, in concorrenza con alcuni centri dei Castelli (Genzano e Zagarolo) del Reatino (Poggio Mirteto) e del Viterbese (San Martino al Cimino, Canapina e Vignanello).
Sul fronte dell'oggettistica, Carpineto Romano si distingue per gli ombrelli da pastore, le pipe, i mastelli ed un'ampia gamma di contenitori realizzati con l'antica
tecnica del bottaio, tuttora vitale anche nel comprensorio dei Castelli Romani. Infine, a Ripi e Veroli, in provincia di Frosinone, è fiorente un raffinato artigianato del legno traforato e
intagliato che ha le sue matrici storiche negli stupendi cori lignei delle chiese e delle abbazie sparse per tutto il territorio provinciale.

IL PECORINO ROMANO
Il Pecorino Romano è sostanzialmente uguale a quello che producevano i pastori dell'Agro Romano 2000 anni fa. Varrone, Galeno, Ippocrate e Plinio il Vecchio riportano nei loro libri le antiche tecniche di caseificazione che non differiscono molto da quelle attuali.
Chi, però, descrive con maggiore dettaglio una metodologia di preparazione, salatura e stagionatura che richiama più da vicino l'attuale Pecorino, è Columella, nel De re rustica, scritto nel I° secolo d.C..
Oltre alle notazioni tecniche, l'autore si sofferma sulle caratteristiche di ottima conservabilità del pecorino, giungendo ad affermare che "questo tipo di cacio può anche mandarsi di là del mare".
Non è casuale, quindi, che il Pecorino Romano sia il formaggio italiano più esportato. Nonostante il suo grande e consolidato successo commerciale, il Pecorino è rimasto un prodotto sostanzialmente artigianale, nel quale la "mano" del casaro gioca un ruolo determinante.
Ne sa qualcosa chi riesce a superare l'aggressività del suo sapore e lo gusta a scaglie, riuscendo gradatamente ad assaporare l'infinita modulazione di aromi che si cela dietro la sua immediata rusticità.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Non c'è weekend a Roma non si organizzi un "mercatino", ma sono tutte occasioni giuste per chi ama l'antiquariato, il modernariato, e le forme più bizzarre di collezionismo.
Per l'artigianato, invece, bisogna allontanarsi dalla metropoli, rincorrendo le manifestazioni specifiche, come l'antica Fiera dell'Artigianato di San Giuseppe a Tivoli o la Primavera a Palazzo Rospigliosi a Zagarolo.
Oppure lasciandosi coinvolgere in eventi popolari di antica tradizione, come la Barabbata di Marta, sulle rive del Lago di Bolsena, dove i principali protagonisti sono le corporazioni del paese con gli strumenti del proprio mestiere.

Valle d’Aosta • Piemonte • Liguria • Lombardia • VENETO
Trentino-Alto Adige • Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna • Toscana • Marche • Umbria • Lazio
Abruzzo • Molise • Campania • Basilicata
 RuvidaMente
RuvidaMente